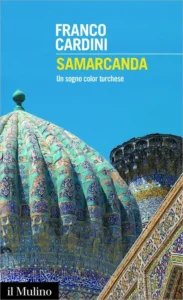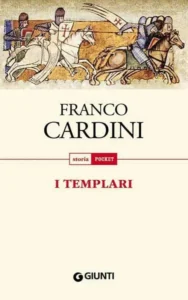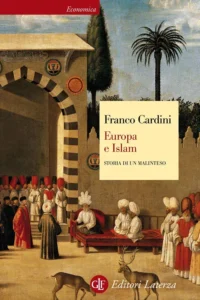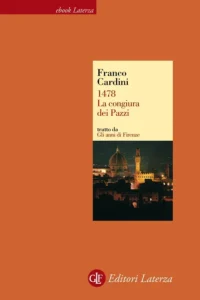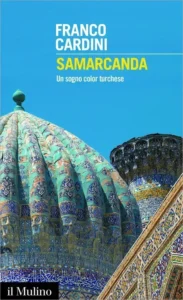1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Vita di Carlomagno” di Franco Cardini ti porta nel cuore del Medioevo, subito dopo la fine dell’Impero Romano d’Occidente. È la storia di come il regno dei Franchi, partendo dai Maestri di Palazzo come Carlo Martello, arrivi a creare un impero enorme con Carlomagno. Vedrai come i Franchi si legano al Papato a Roma, conquistano i Longobardi in Italia e combattono i Sassoni. Il libro ti fa capire come Carlomagno non fosse solo un guerriero, ma anche un organizzatore, che cercò di tenere insieme questo Impero Carolingio da luoghi come Aquisgrana, usando sistemi come il vassallaggio. Scoprirai anche la sua rinascita carolina, un tentativo di rilanciare cultura e sapere, e i suoi rapporti complicati con Costantinopoli e persino con il Califfato. È un viaggio attraverso un’epoca cruciale che ha plasmato l’Europa, mostrando la complessità di un sovrano che è diventato un mito, un po’ come la nascita del Sacro Romano Impero.Riassunto Breve
La fine dell’Impero Romano d’Occidente nel 476 è un processo lungo, segnato da crisi interne come i grandi latifondi e l’influenza dell’esercito, e dalla pressione dei popoli germanici che cercano integrazione. L’Impero d’Oriente a Costantinopoli continua, con Giustiniano che tenta una riconquista in Occidente, riprendendo Italia e Africa, ma con risultati precari, perdendo l’Italia ai Longobardi. L’Islam nel VII secolo riduce l’influenza bizantina nel Mediterraneo occidentale. In Occidente nascono regni romano-barbarici, tra cui i Franchi in Gallia diventano centrali. La dinastia merovingia, con Clodoveo, si converte al cristianesimo romano, facilitando l’integrazione e legandosi alla Chiesa di Roma. L’indebolimento dei Merovingi porta all’ascesa dei Maestri di Palazzo, in particolare i Pipinidi con Carlo Martello nell’VIII secolo. Carlo Martello rafforza il regno, espande i confini, riorganizza l’esercito introducendo il vassallaggio e usa terre della Chiesa per ricompensare i fedeli. Una vittoria a Poitiers nel 732 contro un’incursione musulmana contribuisce alla sua fama. La Chiesa di Roma si allontana da Bisanzio per controversie religiose e cerca un nuovo alleato contro i Longobardi, trovandolo nei potenti Maestri di Palazzo franchi. Il potere effettivo passa dai re Merovingi ai Pipinidi. Pipino III diventa re con l’approvazione del papa, stabilendo una nuova sacralità del potere basata sull’elezione divina tramite la Chiesa. Alla morte di Pipino, il regno si divide tra i figli Carlo e Carlomanno; Carlo diventa unico sovrano dopo la morte del fratello. Carlo Magno espande il regno e consolida il legame con il papato. Conquista il regno longobardo in Italia nel 774 su richiesta del papa, assume il titolo di re dei Franchi e dei Longobardi, rafforza l’alleanza con Roma con donazioni territoriali e riceve il titolo di *patricius Romanorum*. Intraprende guerre sanguinose contro i Sassoni pagani per sottometterli e convertirli, usa metodi brutali. Sottomette la Baviera. Una spedizione in Spagna fallisce con l’imboscata di Roncisvalle. Nonostante questo, il regno franco diventa la principale potenza in Europa occidentale. L’espansione affronta popolazioni come gli Àvari nell’area danubiana, sconfitti alla fine dell’VIII secolo. Il regno franco si espande in Gallia, Germania occidentale e Italia settentrionale. I rapporti con la Chiesa sono solidi. L’ascesa imperiale è influenzata da eventi a Bisanzio (imperatrice Irene) e a Roma (aggressione a papa Leone III). Carlo interviene, riabilita il papa e viene incoronato imperatore a Roma da Leone III la notte di Natale dell’800. Questo segna la rinascita di un impero in Occidente, cristiano e latino, sollevando questioni sul rapporto tra potere temporale e spirituale. Carlo usa il titolo di “imperator Romanum gubernans imperium” per prudenza verso Bisanzio. Negli ultimi anni, Carlo affronta conflitti e pianifica la successione, associando al trono il figlio Ludovico, incoronato imperatore ad Aquisgrana nell’813 senza intervento papale. Carlo muore nell’814. La figura di Carlo è descritta come alta, robusta, con baffi, preferisce costumi franchi ma indossa abiti romani a Roma. È un amministratore attento delle proprietà regie (*Capitulare De Villis*). La corte si stabilisce ad Aquisgrana. Ha numerosi figli, educati alle arti liberali; le figlie non si sposano per ragioni politiche. L’impero carolingio si basa sulla fedeltà personale al sovrano (*fideles*), non su una burocrazia. Il regno è proprietà del sovrano, gestito tramite giuramenti. Il potere del re (*Bann*) include ordini, punizioni e un ruolo religioso (*defensor fidei*). Le decisioni sono nei *Capitularia*, discusse nell’assemblea annuale (“campo di maggio”). Si cerca di razionalizzare il diritto. Un organo centrale è il *Palatium* ad Aquisgrana, con ufficiali spirituali e temporali. I consiglieri sono scelti per timore di Dio, fedeltà e riservatezza. Il territorio è diviso in contee (*comitatus*) affidate ai conti (*comites*) con ampi poteri. Si introducono giudici specializzati (*scabini*). I *missi dominici*, funzionari itineranti (un laico e un ecclesiastico), controllano i funzionari locali. Le aree di confine sono marche, guidate da *marchiones*. I rapporti vassallatici evolvono: il re lega a sé l’aristocrazia (*vassi dominici*) con giuramenti (*accomandatio*) e terre (*beneficium*). Questo fornisce supporto militare, ma i grandi signori con propri vassalli creano un potenziale di disgregazione. L’esercito si convoca annualmente (*bann*). La cavalleria pesante diventa importante, formando un’aristocrazia militare, mentre la fanteria contadina perde rilievo. Il servizio militare obbligatorio dipende dalla ricchezza fondiaria (*mansi*). Una riforma monetaria standardizza il *denarius* d’argento, basato su *libra* e *solidus*, adeguando il sistema all’economia agricola. La diplomazia è importante. Carlo cerca il negoziato. Conquista le aristocrazie dei popoli sottomessi. Il principale interlocutore è Bisanzio, con rapporti difficili dopo l’incoronazione imperiale. Un tentativo di unione matrimoniale con l’imperatrice Irene fallisce. Il riconoscimento bizantino del titolo imperiale di Carlo è ambiguo e tardivo. Per bilanciare i rapporti con Bisanzio, Carlo stabilisce contatti con il Califfato Abbaside di Baghdad (Harun al-Rashid) per scopi geopolitici e religiosi, cercando protezione per i cristiani in Terra Santa. Scambi di ambascerie e doni rafforzano il legame. Il patriarca di Gerusalemme invia le chiavi dei Luoghi Santi a Carlo. La fede di Carlo Magno è profonda, visibile in cerimonie, pellegrinaggi e venerazione delle reliquie. Si considera un monarca cristiano con responsabilità spirituali, un “nuovo Mosè” o “nuovo David”, protettore della Chiesa. Interviene in questioni dottrinali. Questa visione lo spinge a promuovere un rinnovamento culturale ed educativo, la “rinascita carolina”, per migliorare la preparazione del clero e standardizzare liturgia e testi sacri. Investe risorse e si circonda di studiosi (*schola palatina* – Alcuino, Paolo Diacono, Teodulfo) che lavorano alla correzione dei testi, redazione di grammatiche e diffusione della minuscola carolina. Vengono create scuole presso monasteri e vescovati. Questo movimento pone le basi per lo sviluppo culturale europeo. Carlo, pur interessato al sapere, non impara a scrivere fluentemente. La figura di Carlo Magno diventa un mito rapidamente dopo la sua morte. Meno di trent’anni dopo, si percepisce la perdita della pace e della sicurezza dei suoi tempi a causa della frammentazione dell’impero (trattato di Verdun 843) e delle nuove invasioni (Normanni, Saraceni, Ungari). La sua figura è usata da dinastie successive per legittimare il potere. La dinastia sassone con Ottone I si richiama a Carlo, assumendo la dignità imperiale e il ruolo di difensore della fede. Ottone III persegue un progetto di restaurazione imperiale cristiana con centro a Roma e venera la tomba di Carlo ad Aquisgrana. La santificazione di Carlo, imposta da Federico I Barbarossa nel 1165 tramite un antipapa, è un atto politico per affermare l’autorità imperiale sul papato e contrastare i francesi, portando a un culto locale ad Aquisgrana. Anche i Capetingi in Francia rivendicano un legame con Carlo. Il mito si sviluppa nell’epica (*chansons de geste*), dove Carlo è campione della Cristianità, saggio e circondato dai paladini (*Chanson de Roland*). La sua immagine continua a essere usata in politica e cultura, incluso tra i Nove Prodi. Francia e Germania rivendicano la sua eredità. Figure come Carlo V e Napoleone si richiamano alla sua grandezza. Oggi, l’eredità di Carlo Magno è presente nelle città simbolo dell’Unione Europea nel cuore del vecchio impero. L’Europa moderna emerge anche dalla dissoluzione del suo impero e dalle differenze nazionali. Fede e latino furono pilastri del suo impero, elementi importanti ma non sufficienti per definire l’identità europea attuale. La Cappella Palatina di Aquisgrana è un simbolo di questa eredità complessa.Riassunto Lungo
1. L’Eredità di Roma e l’Ascesa dei Franchi
La fine dell’Impero Romano d’Occidente nel 476 non fu un evento improvviso, ma il risultato di una lunga crisi interna. Tra i problemi c’erano l’eccessivo potere dei grandi proprietari terrieri e l’influenza crescente dell’esercito. A questa situazione si aggiunse la pressione dei popoli germanici. Questi popoli, stabilendosi in Occidente, non volevano distruggere l’impero, ma integrarsi nelle sue strutture.L’Impero Romano d’Oriente
Intanto, l’Impero Romano d’Oriente, con capitale Costantinopoli, continuò a esistere, considerandosi il vero erede di Roma. Nel VI secolo, l’imperatore Giustiniano cercò di riconquistare l’Occidente. Riuscì a riprendere l’Africa e l’Italia, ma fu uno sforzo enorme con risultati che non durarono. L’Italia, infatti, fu presto persa a favore dei Longobardi. L’arrivo dell’Islam nel VII secolo ridusse ulteriormente l’influenza bizantina nel Mediterraneo occidentale.I Nuovi Regni in Occidente e i Franchi
In Occidente, nel frattempo, si formarono i regni romano-barbarici. Tra questi, il regno dei Franchi in Gallia divenne molto importante. La dinastia merovingia, iniziata con Clodoveo, si convertì al cristianesimo romano. Questo aiutò l’integrazione con la popolazione gallo-romana e creò un legame forte con la Chiesa di Roma.L’Ascesa dei Maestri di Palazzo
La dinastia merovingia si indebolì a causa delle lotte interne e della divisione del regno. Questo portò all’aumento del potere dei Maestri di Palazzo. La famiglia arnolfingio-pipinide consolidò il suo controllo, soprattutto con Carlo Martello nell’VIII secolo. Carlo Martello rafforzò il regno, lo espanse e riorganizzò l’esercito. Introdusse il vassallaggio, ricompensando spesso i suoi uomini fedeli con terre prese dalla Chiesa. La sua vittoria, sebbene ridimensionata dagli storici moderni, contro un’incursione musulmana a Poitiers nel 732 contribuì molto alla sua fama e gli permise di estendere il suo dominio sul sud della Gallia.Il Ruolo della Chiesa di Roma
Nello stesso periodo, la Chiesa di Roma si allontanò dall’Impero Bizantino a causa di dispute religiose come l’Iconoclastia. Il Papa, minacciato dai Longobardi in Italia, cercò un nuovo alleato in Occidente. Questa situazione favorì un avvicinamento tra il Papato e i potenti Maestri di Palazzo franchi. Questo legame pose le basi per importanti sviluppi politici futuri in Europa.Se la battaglia di Poitiers è “ridimensionata dagli storici moderni”, come afferma il capitolo, perché le si attribuisce ancora un ruolo così determinante nell’ascesa di Carlo Martello e nell’espansione del regno franco?
Il capitolo introduce un punto cruciale di dibattito storiografico senza però esplorarne le implicazioni. Affermare che la battaglia è “ridimensionata” ma poi usarla come spiegazione per la fama e l’espansione di Carlo Martello crea una lacuna argomentativa. Per colmarla, sarebbe necessario approfondire perché la battaglia è stata ridimensionata (quali erano le vecchie interpretazioni e quali sono le nuove prove o argomentazioni?) e come, nonostante questo ridimensionamento, abbia comunque potuto avere un impatto politico e simbolico significativo. Approfondire la storiografia sulla battaglia e sul periodo merovingio-carolingio, leggendo autori che trattano specificamente la transizione di potere e le campagne militari dell’epoca, come Fouracre o Wickham, può aiutare a comprendere meglio la complessità di questo evento e il suo reale peso storico al di là del mito.2. Dal Maestro al Re: L’Ascesa Franca
Il potere reale nel regno franco si sposta dai re Merovingi ai Maestri di Palazzo, in particolare alla famiglia dei Pipinidi. Pipino III riesce a ottenere la corona, cercando prima l’approvazione del papa sulla legittimità di regnare per chi deteneva il potere effettivo. Ottenuto il consenso papale, Pipino viene scelto come re dai nobili franchi e consacrato con l’unzione, introducendo così una nuova idea di potere sacro, voluto da Dio attraverso la Chiesa. Alla sua morte, il regno viene diviso tra i figli Carlo e Carlomanno. Quando Carlomanno muore, Carlo assume il controllo totale del regno. Da sovrano unico, Carlo punta ad espandere i territori e a rafforzare sempre più il legame con il papato.Le Campagne Militari e l’Espansione del Regno
Su richiesta di Papa Adriano I, che si sentiva minacciato dal re longobardo Desiderio, Carlo interviene in Italia. Conquista il regno longobardo nel 774, aggiungendo al suo titolo quello di re dei Franchi anche quello di re dei Longobardi. Questo rafforza ulteriormente l’alleanza con Roma: Carlo conferma e amplia le terre donate al papa e riceve il titolo di patricius Romanorum, protettore dei Romani. Carlo conduce lunghe e difficili guerre per sottomettere i Sassoni, popolazioni ancora pagane, e convertirle al cristianesimo, non esitando a usare la forza, con massacri e spostamenti forzati di intere comunità. Riesce anche a sottomettere il duca di Baviera Tassilone, unendo il suo territorio al regno franco. Una campagna militare in Spagna, iniziata su richiesta di alcuni capi musulmani locali, non ha successo e si conclude con la famosa imboscata di Roncisvalle. Nonostante questo episodio, il regno franco si ingrandisce notevolmente sotto la guida di Carlo. Diventa così la potenza più importante dell’Europa occidentale, mantenendo un legame forte e privilegiato con la Chiesa di Roma.Ma il legame con il papato e l’idea di potere sacro erano davvero così lineari e privi di tensioni come suggerisce il capitolo?
Il capitolo descrive l’alleanza tra Franchi e papato e l’introduzione del concetto di potere sacro come elementi chiave dell’ascesa di Carlo. Tuttavia, non approfondisce le potenziali complessità, ambiguità e persino conflitti che caratterizzarono il rapporto tra potere temporale e spirituale nel Medioevo, né come l’idea di un potere “voluto da Dio attraverso la Chiesa” potesse essere interpretata o contestata all’epoca. Per comprendere meglio queste dinamiche e le loro implicazioni a lungo termine, sarebbe utile esplorare la storia delle istituzioni ecclesiastiche e politiche altomedievali, la storia del pensiero politico e le relazioni internazionali del periodo. Autori come Marc Bloch o Jacques Le Goff offrono prospettive fondamentali sul contesto feudale e culturale, mentre studiosi come François-Louis Ganshof o R.W. Southern si sono dedicati specificamente all’età carolingia e al rapporto tra impero e papato.3. L’Impero Franco e il suo Artefice
L’espansione del regno franco sotto Carlo Magno avviene attraverso una serie di conquiste e conflitti. Dopo l’annessione di Sassonia e Baviera, i Franchi entrano in contatto con popolazioni nomadi e pagane, tra cui gli Àvari. Questo popolo uraloaltaico, insediato nell’area danubiana, è noto per le razzie e la sua struttura sociale gerarchica, con un capo supremo chiamato Khaghan e una capitale fortificata, il Ring. La loro tattica bellica si basa su attacchi improvvisi e imboscate. Alla fine dell’VIII secolo, gli Àvari mostrano segni di crisi. Una spedizione franca nel 791 incontra difficoltà, ma nel 795 un nuovo attacco guidato da Pipino, figlio di Carlo, porta alla conquista del Ring e all’acquisizione di un vasto bottino. Nonostante alcune rivolte successive, il dominio àvaro scompare definitivamente.L’ascesa imperiale di Carlo Magno
Il regno franco si espande notevolmente, includendo Gallia, Germania occidentale e Italia settentrionale. I rapporti con la Chiesa sono solidi e giocano un ruolo cruciale nell’ascesa di Carlo. A Bisanzio, l’imperatrice Irene acceca il figlio Costantino VI nel 797, creando una situazione percepita come “sede vacante” in Occidente. Contemporaneamente, a Roma, papa Leone III subisce un’aggressione da parte di aristocratici romani nel 799 e chiede l’aiuto di Carlo. Carlo interviene, riabilita il papa e, la notte di Natale dell’800, viene incoronato imperatore a Roma da Leone III. Questo atto segna la rinascita di un impero in Occidente, con un carattere cristiano e latino, ma solleva questioni sul rapporto tra potere temporale e spirituale. Per prudenza verso Bisanzio, Carlo adotta il titolo di “imperator Romanum gubernans imperium”.Gli ultimi anni e la successione
Negli ultimi anni del suo regno, Carlo affronta nuovi conflitti e pianifica la successione. Dopo la morte di alcuni figli, associa al trono l’unico maschio rimasto, Ludovico, incoronandolo imperatore ad Aquisgrana nell’813, senza l’intervento papale. Carlo muore nell’814, lasciando un’eredità duratura.La figura di Carlo Magno
Carlo Magno è descritto come una figura imponente: alto, robusto, con baffi ma senza barba. Predilige i costumi franchi, ma indossa abiti romani a Roma. È un amministratore attento delle proprietà regie, come testimonia il Capitulare De Villis. La sua corte, inizialmente mobile, si stabilisce ad Aquisgrana. La vita familiare è caratterizzata da numerosi figli, educati alle arti liberali. Le figlie non vengono date in sposa per ragioni politiche e rimangono a corte, godendo di una certa libertà.L’invio delle chiavi di Gerusalemme fu davvero il sigillo di un’alleanza o un gesto più ambiguo?
Il capitolo presenta i rapporti con il Califfato Abbaside come un’alleanza rafforzata da scambi simbolici, tra cui l’invio delle chiavi dei Luoghi Santi. Tuttavia, la natura di questa relazione e il significato preciso di tale gesto sono questioni dibattute nella storiografia. Definirla semplicemente un'”alleanza” potrebbe semplificare eccessivamente dinamiche complesse, che coinvolgevano interessi geopolitici divergenti e una comprensione reciproca limitata. Per approfondire, è utile esplorare la storia del Vicino Oriente in quel periodo, le motivazioni politiche e religiose del Califfato Abbaside e le diverse interpretazioni storiografiche sull’episodio delle chiavi. Approfondire autori che trattano la storia carolingia e le relazioni tra Oriente e Occidente nel Medioevo, come Alessandro Barbero o Franco Cardini, può fornire prospettive più sfaccettate.6. Mito e Politica
La figura di Carlo Magno diventa rapidamente un mito dopo la sua morte. Già a meno di trent’anni dalla fine del suo regno, si percepisce la perdita della pace e della sicurezza che lo caratterizzavano. La frammentazione dell’impero, iniziata con le lotte tra i figli di Ludovico il Pio e sancita dal trattato di Verdun nell’843, e le nuove invasioni di Normanni, Saraceni e Ungari, rendono i suoi tempi una sorta di età dell’oro perduta.Dinastie e legittimazione del potere
La figura di Carlo Magno viene usata da dinastie successive per legittimare il proprio potere. La dinastia sassone, con Ottone I, si richiama esplicitamente a Carlo, assumendo la dignità imperiale e riaffermando il ruolo di difensore della fede. Ottone III, in particolare, persegue un progetto di restaurazione dell’impero cristiano con centro a Roma, simboleggiando l’unione di elementi romani e germanici e venerando la tomba di Carlo ad Aquisgrana.Santificazione e culto
La santificazione di Carlo Magno, imposta da Federico I Barbarossa nel 1165 tramite un antipapa, è un atto politico per affermare l’autorità imperiale sul papato e contrastare le rivendicazioni francesi. Questo porta a un culto locale, specialmente ad Aquisgrana. Anche la dinastia Capetingia in Francia rivendica un legame con Carlo attraverso reliquie e leggende.Tradizione epica e cultura
Il mito di Carlo Magno si sviluppa anche nella tradizione epica, in particolare nelle chansons de geste. Carlo è presentato come un campione della Cristianità contro gli infedeli, spesso raffigurato come un sovrano anziano e saggio, circondato dai suoi paladini. La Chanson de Roland è un esempio importante, dove Carlo è un tramite del sacro.Eredità politica e culturale
La sua immagine continua a essere usata in politica e cultura. Viene incluso tra i Nove Prodi, simbolo di virtù cavalleresca. Francia e Germania rivendicano entrambe la sua eredità. Figure come Carlo V d’Asburgo e i re di Francia, fino a Napoleone, si richiamano alla sua grandezza per legittimare il proprio potere.Eredità moderna
Oggi, l’eredità di Carlo Magno è ancora presente, specialmente nelle città simbolo dell’Unione Europea situate nel cuore del vecchio impero. Tuttavia, l’Europa moderna emerge anche dalla dissoluzione del suo impero e dalle differenze nazionali che ne sono derivate. La fede e il latino furono i pilastri del suo impero, elementi che restano importanti ma non sufficienti per definire l’identità europea attuale. La Cappella Palatina di Aquisgrana rimane un simbolo di questa eredità complessa.Non è forse una contraddizione presentare Carlo Magno come simbolo dell’Europa unita, quando il capitolo stesso riconosce che l’Europa moderna è nata dalla dissoluzione del suo impero e dalle differenze nazionali?
Il capitolo illustra efficacemente come la figura di Carlo Magno sia stata plasmata in un mito e utilizzata per legittimare il potere da diverse dinastie e persino associata all’identità europea contemporanea. Tuttavia, l’argomentazione presenta una lacuna nel non esplorare a fondo la tensione tra questa rivendicazione di unità e il fatto, ugualmente sottolineato, che l’Europa attuale affonda le sue radici proprio nella frammentazione post-carolingia e nell’emergere delle identità nazionali. Per affrontare questa complessità e capire come un simbolo di un impero unitario possa coesistere con la realtà degli stati nazionali, sarebbe utile approfondire gli studi sulla costruzione delle identità collettive, sul nazionalismo e sull’uso pubblico della storia. Autori come Ernest Renan o Anthony Smith offrono prospettive fondamentali su come le nazioni e le identità sovranazionali vengano immaginate e costruite, spesso attingendo e reinterpretando il passato in modi selettivi e talvolta contraddittori.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]