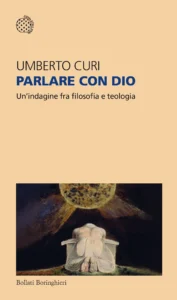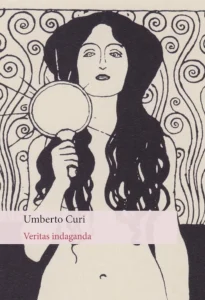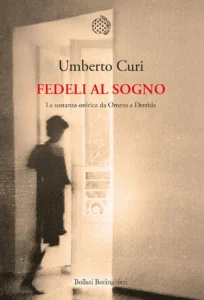1. La misura del tempo e del dolore
La visione di un vasto esercito suscita nel re Serse una profonda riflessione sulla condizione umana. Osservando migliaia di uomini, Serse prova commiserazione pensando alla brevità inevitabile della loro vita. Ogni esistenza è destinata a finire, un destino comune che accomuna tutti. Suo zio Artabano offre invece un punto di vista ancora più severo. Per Artabano, la vita non è solo breve, ma intrinsecamente misera e piena di sofferenze. In questa visione, la morte non è solo una fine, ma diventa un rifugio desiderabile, una liberazione dal dolore quotidiano. Nonostante le loro differenze, entrambe le prospettive concordano su un punto fondamentale: è la morte, con la sua presenza ineludibile, a dare un senso e un significato all’esperienza della vita stessa.La bellezza e il tempo che passa
Questa consapevolezza della fine, del tempo che scorre e porta via ogni cosa, genera turbamento. Ci si confronta con la caducità della bellezza e della vita stessa. Eppure, proprio questa precarietà, questa limitatezza nel tempo, sembra aumentare il valore di ciò che è bello. Le cose effimere acquistano un pregio speciale, una rarità che deriva dalla loro breve durata. La tristezza che proviamo di fronte a questa transitorietà nasce da una sorta di resistenza interiore, una ribellione contro l’idea della perdita e del lutto. In particolare, la guerra rende ancora più acuta questa sensazione di dissoluzione. Di fronte alla distruzione, si tende a svalutare i beni materiali, percepiti come effimeri e destinati a perire. Questo solleva una questione profonda: la brevità delle cose impedisce forse la gioia e il piacere? Oppure, al contrario, è proprio la loro durata limitata a renderle così affascinanti e a dare un senso più intenso alla nostra esistenza?La guerra e la morte
Il modo in cui ci poniamo di fronte alla morte aiuta a comprendere le ragioni profonde che spingono gli uomini alla guerra. Il conflitto armato, con la sua violenza e distruzione, sconvolge il nostro modo abituale di ignorare o allontanare il pensiero della morte. La guerra ci costringe a confrontarci con essa in modo diretto. Si osserva come, in epoche passate, l’uomo avesse una visione ambivalente: la morte del nemico era considerata reale e concreta, mentre la propria veniva in qualche modo negata o ignorata. Questa contraddizione fondamentale, unita alle uccisioni compiute, generava un profondo senso di colpa. La perdita di una persona cara, in particolare, crea un conflitto emotivo lacerante. Non è possibile provare gioia per la morte di un avversario, né accettare serenamente la propria fine o quella di chi amiamo. Questa tensione interiore ha contribuito, nel tempo, alla nascita e allo sviluppo della psicologia, come tentativo di esplorare e comprendere questi abissi emotivi. La guerra, in definitiva, rende impellente la necessità di trovare un nuovo modo, più consapevole e maturo, di rapportarsi al concetto di morte.Affermare che la psicologia sia nata dalla tensione emotiva generata dalla guerra non rischia di semplificare eccessivamente le sue complesse origini?
Il capitolo suggerisce una diretta causalità tra la tensione psicologica derivante dall’esperienza bellica e la nascita della psicologia. Questa prospettiva, tuttavia, potrebbe trascurare le profonde radici filosofiche e i progressi scientifici che hanno storicamente contribuito all’emergere della psicologia come campo di studi autonomo. Per ottenere una comprensione più completa, è fondamentale esplorare la storia della filosofia, in particolare le riflessioni sulla mente e sulla condizione umana, e lo sviluppo delle prime indagini scientifiche sul comportamento. Approfondire il contesto intellettuale e sociale più ampio in cui la psicologia ha preso forma offre una visione più articolata rispetto a un’origine legata prevalentemente al trauma bellico.2. L’intreccio di Vita e Morte nel Principio di Piacere
Nel testo “Al di là del principio di piacere”, viene presentata una nuova e sorprendente visione della vita psichica. Non è più vista solo come guidata dalle pulsioni di vita, che cercano piacere e crescita, ma anche da pulsioni che tendono a ridurre ogni tensione, puntando a un ritorno a uno stato inorganico. Queste ultime sono le pulsioni di morte.L’esempio del gioco del rocchetto
Per capire meglio il rapporto tra queste due forze, vita e morte, viene usato l’esempio del gioco di un bambino con un rocchetto. Il bambino lancia via un rocchetto dicendo “via!” (fort) e poi lo riavvicina dicendo “qui!” (da). Attraverso questo semplice gioco, il bambino riesce a elaborare l’esperienza dolorosa dell’assenza della madre. Trova una forma di piacere nel poter controllare la ripetizione di quell’allontanamento, unendola alla soddisfazione del ritorno. Questo gioco mostra come, anche all’interno della ricerca di piacere, sia possibile affrontare ed elaborare ciò che è spiacevole.La natura complessa delle pulsioni
Il gioco del rocchetto rivela una verità più profonda: il principio di piacere non è una forza unica e semplice, ma possiede una natura doppia e complessa. La pulsione di morte non agisce separatamente dalla pulsione di vita o erotica; al contrario, ne è una parte essenziale e inseparabile. Già nel momento in cui il bambino sperimenta l’allontanamento dicendo “via!”, è presente l’anticipazione e il piacere del ritorno. La dinamica di allontanamento e avvicinamento, che richiama la dualità tra vita e morte, non è una semplice opposizione tra due estremi. È piuttosto un continuo oscillare tra “lontano” e “vicino”, un “via!” che porta in sé il “qui”, una sparizione che implica la ricomparsa. Questo significa che la pulsione di morte non si colloca “al di là” del principio di piacere come qualcosa di esterno o successivo. Essa è già profondamente inserita al suo interno, creando una differenza, una tensione che è parte integrante del funzionamento psichico. Il principio di piacere, che sembra proteggere la vita psichica, in realtà manifesta questa duplicità fondamentale, dove l’amore e la morte non sono forze contrapposte ma aspetti intrinsecamente legati l’uno all’altro.La morte vista dalla tradizione e nella vita
Questa visione della morte come parte intrinseca della vita psichica si contrappone spesso al modo in cui la filosofia tradizionale affronta il tema. Tradizionalmente, si cerca di negare o allontanare la paura della morte, definendola come un semplice “nulla” o come un “passaggio” verso un’altra dimensione o forma di esistenza. Questo approccio tende a separare nettamente l’anima dal corpo e la vita dalla morte, cercando di eliminare la morte dall’orizzonte vitale. Tuttavia, la realtà della morte si impone come qualcosa di inesorabile e ineliminabile, ben diversa da un semplice vuoto o da un passaggio indolore. La domanda fondamentale su cosa sia la morte riceve comunemente l’alternativa “o fine o passaggio”. Ma forse questa dicotomia non è sufficiente a comprenderne la vera natura. Forse la morte non è solo l’una o l’altra cosa, ma è entrambe: è un processo intimo che si svolge all’interno della vita stessa, un elemento che, lungi dall’essere un’opposizione, contribuisce a dare significato all’esistenza.Ma questa “pulsione di morte”, così centrale nel capitolo, è un concetto universalmente accettato o resta un’ipotesi dibattuta?
Il capitolo presenta la pulsione di morte come un elemento fondamentale della vita psichica, ma non chiarisce che si tratta di una delle idee più controverse e meno accettate della teoria psicoanalitica, anche tra gli stessi seguaci dell’autore. Questa mancanza di contesto può far apparire l’argomento come un dato di fatto scientifico, quando invece è oggetto di acceso dibattito. Per approfondire questa controversia e capire le diverse posizioni, è utile studiare la storia della psicoanalisi, confrontando il pensiero dell’autore con quello di altri psicoanalisti e psicologi che hanno criticato o reinterpretato questo concetto. Anche la filosofia può offrire spunti critici sulla validità e l’applicabilità di tale costrutto.3. Sfidare l’Ordine del Kósmos
Le Moire sono divinità potenti che stabiliscono il destino e, in particolare, la durata della vita di ogni essere umano. Sono tre sorelle: Cloto ha il compito di filare il filo della vita, Lachesi lo misura determinandone la lunghezza, e Atropo lo taglia, segnando la fine dell’esistenza. La vita assegnata a ogni mortale è vista come una “parte” fissa e immutabile, decisa irrevocabilmente fin dal momento della nascita. Questa decisione è così assoluta che nemmeno la massima divinità, Zeus, ha il potere di alterare o modificare il destino stabilito dalle Moire. Il percorso della vita umana è quindi predeterminato, senza alcuna possibilità per i mortali di cambiarlo o ribellarsi alla sorte decisa per loro.Apollo tenta di cambiare il destino
Nonostante l’impossibilità di alterare il destino, il dio Apollo cerca di opporsi alla morte che è stata decretata per Admeto, una persona a lui cara. Per cercare di salvare Admeto, Apollo elabora un piano audace: tenta di ingannare le Moire, facendole ubriacare nella speranza che accettino di sostituire Admeto con un’altra persona nel regno dei morti. Tuttavia, questo tentativo di manipolare il destino non è visto di buon occhio dalle altre potenze divine. Le Erinni, dee che puniscono chi viola l’ordine naturale, e Thanatos, la personificazione della morte, accusano Apollo di aver infranto i diritti sacri delle Moire e di aver cercato di sovvertire gli antichi e inviolabili ordinamenti che regolano l’universo.Il Kósmos e l’equilibrio universale
L’azione di Apollo, nel suo tentativo di cambiare il destino di un singolo mortale, viene considerata una minaccia diretta all’ordine fondamentale che regola l’intero universo, un ordine chiamato kósmos. Originariamente, la parola greca kósmos significava semplicemente “ordine” o “ornamento”, qualcosa di ben disposto e armonioso. Con il passare del tempo, il significato si è ampliato fino a indicare l’universo inteso come un tutto organizzato e bello, tenuto insieme non solo da leggi fisiche ma anche da qualità morali essenziali come la giustizia, l’amicizia e la saggezza. L’atto di Apollo, essendo contrario alla giustizia divina e all’ordine stabilito, mette in discussione l’equilibrio perfetto che costituisce il kósmos. Salvare Admeto dalla morte richiede quindi un evento del tutto eccezionale e fuori dall’ordinario, un fatto che serve a sottolineare quanto siano sacre e intangibili le norme che governano il passaggio tra la vita e il regno dei morti.Ma se il destino è così irrevocabile che nemmeno Zeus può cambiarlo, come diavolo fa Apollo a tentare di modificarlo e, soprattutto, come è possibile che Admeto venga salvato?
Il capitolo presenta le Moire e il destino come forze assolute e immutabili, al di là persino del potere di Zeus. Questa premessa forte si scontra però con il racconto del tentativo di Apollo e del salvataggio di Admeto, che il testo stesso definisce un evento “eccezionale”. Questa tensione logica lascia un vuoto argomentativo: se il destino è davvero scolpito nella pietra, come può esistere un’eccezione? Per esplorare questa apparente contraddizione, sarebbe utile approfondire lo studio della mitologia greca, concentrandosi sulle diverse interpretazioni del concetto di destino (Ananke, Moira) e sul rapporto tra le divinità maggiori e queste forze primordiali. Autori come Walter Burkert o Karl Kerényi offrono prospettive preziose sulla complessità del pantheon greco e delle sue leggi non scritte, aiutando a comprendere se l’immutabilità del destino fosse un dogma assoluto o se esistessero margini (divini, non umani) per la sua negoziazione o alterazione in circostanze estreme.Se la filosofia socratica è una “preparazione alla morte”, in che modo questa “cura dell’anima” affronta l’angoscia dell’annientamento, e non è forse essa stessa una forma di “cieca speranza”?
Il capitolo presenta la filosofia come una via per affrontare la morte, concentrandosi sulla prospettiva socratica della separazione anima-corpo. Tuttavia, non viene esplorato a sufficienza come questa visione si ponga di fronte al timore profondo dell’annientamento totale, un’angoscia che potrebbe non essere placata dalla sola idea della sopravvivenza dell’anima. Per comprendere meglio le diverse risposte filosofiche a questa sfida, è utile confrontare la posizione socratica con altre scuole di pensiero antiche, come l’epicureismo o lo stoicismo, e considerare anche le riflessioni di autori moderni che hanno affrontato il tema dell’esistenza e della finitudine.21. Le diverse nature della fine
La morte non è vista solo come la fine della vita biologica, ma come un evento o uno stato che assume diverse forme e significati. Una prospettiva la considera una vera e propria trasformazione, una forma di esistenza dove è possibile trovare compimento, integrata profondamente con la vita stessa. Questa visione si ritrova, ad esempio, in alcune interpretazioni di miti antichi che narrano passaggi e rinascite. Esiste anche l’idea di uno stato intermedio, una condizione in cui un essere non è né completamente vivo né completamente morto, bloccato in una dimensione che sfugge alla comprensione comune e razionale. Questa situazione rappresenta la difficoltà intrinseca dell’essere umano nel concepire o raggiungere una fine definitiva, o al contrario, un ritorno completo alla vita precedente. È una presenza che non si lascia afferrare o definire facilmente, rimanendo in uno stato di sospensione.La responsabilità individuale di fronte alla morte
Affrontare la morte, o un comando che la riguarda direttamente, può richiedere di agire al di fuori delle regole morali considerate universali. Questo indica l’esistenza di una responsabilità assoluta, unica e ineludibile per il singolo individuo che si trova in tale situazione. Questa responsabilità va oltre le norme etiche generali che guidano la condotta quotidiana e si lega a una dimensione differente, forse di natura superiore o divina. In queste circostanze estreme, le regole universali sembrano non applicarsi più allo stesso modo, lasciando l’individuo solo con il peso della sua decisione. Si tratta di un confronto intimo e profondo con il limite ultimo dell’esistenza e con le scelte che esso impone.La visione cristiana della morte
La visione cristiana lega la morte al concetto di peccato originale, ma la considera anche e soprattutto come un passaggio fondamentale e una radicale trasformazione verso una vita eterna. Non è vista come una semplice distruzione o annientamento dell’essere, ma come un cambiamento di stato, un transito necessario per raggiungere una dimensione superiore. Questa prospettiva evidenzia il concetto di continuità spirituale e di rinascita oltre la fine fisica. Queste diverse visioni dimostrano quanto il fenomeno della morte sia complesso e sfaccettato, spesso difficile da comprendere appieno utilizzando unicamente i modi di pensare e le categorie usuali della vita terrena.Se affrontare la morte sospende le regole morali universali, su quali basi si fonda allora la ‘responsabilità assoluta’ invocata dal capitolo?
Il capitolo introduce il concetto di una responsabilità individuale assoluta di fronte alla morte, che trascende le norme etiche comuni. Tuttavia, non chiarisce su quali principi si basi tale responsabilità una volta che le regole universali sono considerate sospese. Questo lascia una lacuna logica nel fondamento di tale responsabilità. Per approfondire questa complessa relazione tra moralità, responsabilità individuale e situazioni estreme, si possono esplorare le discipline dell’etica e della filosofia morale, in particolare le correnti legate all’esistenzialismo. Autori come Kant, Kierkegaard o Sartre offrono prospettive diverse e fondamentali su questi temi.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]