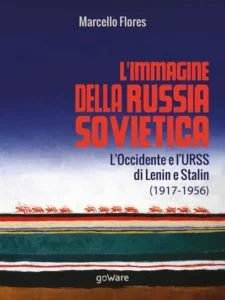1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Verità senza vendetta. Materiali della commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione” di Marcello Flores ci porta dritti nel cuore di uno dei periodi più bui della storia del Sudafrica: gli anni dell’apartheid e la difficile transizione verso la democrazia. Questo libro, basato sui materiali della Commissione Verità e Riconciliazione, esplora le terribili violazioni dei diritti umani commesse tra il 1960 e il 1994 in tutto il paese, da regioni come l’Eastern Cape al Transvaal, incluse aree come Soweto e le homeland. Vediamo la brutalità della repressione statale, con la polizia e le forze di sicurezza che usano tortura, omicidi e forza letale contro l’opposizione, ma anche le violenze commesse dai movimenti di liberazione come l’ANC e l’Inkatha durante il conflitto. Il testo non si ferma solo agli eventi, ma analizza anche come istituzioni come il mondo degli affari, le chiese e il sistema legale abbiano interagito con il regime. È un viaggio crudo e necessario per capire le sofferenze delle vittime dell’apartheid e il complesso percorso intrapreso dal Sudafrica per affrontare il suo passato violento, cercando una verità che possa portare a una vera riconciliazione, non alla vendetta. È una lettura fondamentale per chi vuole comprendere la storia del Sudafrica e il significato profondo della giustizia di transizione.Riassunto Breve
Il Sudafrica tra il 1960 e il 1994 è caratterizzato da un conflitto violento con estese violazioni dei diritti umani. Il governo sudafricano usa il razzismo per etichettare i neri come nemici e l’opposizione come comunista. Le forze di sicurezza dello stato impiegano metodi pubblici come divieti, esilio e esecuzioni legali, e metodi segreti come tortura sistematica e omicidi di attivisti. Si usa forza eccessiva per controllare le manifestazioni, causando morti e feriti. Operazioni militari si svolgono anche negli stati vicini, con attacchi e rapimenti. Anche i movimenti di liberazione, come l’ANC e il PAC, commettono violazioni, incluse azioni che colpiscono civili e abusi contro i propri membri. Le homeland, create per la separazione razziale, sono un altro luogo di violenza, specialmente in KwaZulu dove l’Inkatha usa risorse statali contro gli oppositori. Casi specifici come l’incidente aereo di Samora Machel o le azioni del Mandela United Football Club mostrano la natura della violenza.Dopo il 1990, la violenza aumenta notevolmente, anche durante i negoziati per la democrazia. Molte denunce di omicidio si riferiscono a questo periodo. L’escalation è legata all’intensificazione del conflitto nel KwaZulu/Natal tra IFP e ANC/UDF. La polizia continua a usare forza letale nella gestione dell’ordine pubblico, uccidendo centinaia di persone in incidenti come a Sebokeng o Bisho nel 1992. La detenzione indiscriminata e la tortura da parte della polizia persistono. Molti assassini politici colpiscono membri dell’ANC.Le violazioni si manifestano in diverse regioni. Nell’Eastern Cape si registrano attacchi armati, morti in detenzione (incluso Steve Biko), torture diffuse e scontri (come la strage di Langa nel 1985). In Natal e KwaZulu, molte denunce riguardano omicidi politici e scontri IFP-ANC; la polizia usa la tortura anche per creare collaboratori. Nel Western Cape si verificano maltrattamenti, detenzioni e omicidi, con picchi nel 1976 e 1985/86, la polizia è indicata come principale responsabile (rivolta studentesca 1976, resistenza a Crossroads 1985). Nel Transvaal, il massacro di Sharpville nel 1960 e la rivolta di Soweto nel 1976 mostrano l’uso letale della forza; la tortura è sistematica e le detenzioni di massa sono comuni. La polizia è costantemente identificata come l’autore principale di omicidi, torture e maltrattamenti in tutte le regioni, con impunità che contribuisce al perpetuarsi degli abusi.Comprendere il contesto richiede di esaminare il ruolo di vari settori della società. Molti sudafricani privilegiati hanno giustificato o permesso il sistema. Settori come il mondo degli affari, le comunità religiose, il sistema legale, il settore sanitario e i media hanno interagito con l’apartheid. Le aziende hanno beneficiato del lavoro a basso costo e alcune hanno collaborato con gli apparati di sicurezza. Le chiese spesso riflettevano le divisioni razziali o non supportavano i dissidenti. Il sistema legale applicava leggi ingiuste, sebbene pochi abbiano resistito. Il settore sanitario non ha indagato su abusi medici legati a detenuti o denunciato la segregazione. I media operavano sotto restrizioni e molti sostenevano il governo e promuovevano la superiorità bianca. Le esperienze delle donne, incluse le violazioni dirette e gli abusi sessuali, sono state spesso sottovalutate.Le vittime di queste violazioni hanno diritto a risarcimenti e riabilitazione per le perdite subite. Queste misure sono essenziali per la guarigione, la riconciliazione e per bilanciare l’amnistia concessa. Il governo ha la responsabilità morale di fornire questi risarcimenti, che includono assistenza urgente, sussidi finanziari, misure simboliche, assistenza legale e programmi di riabilitazione. Le gravi violazioni sono state commesse in larga parte dallo stato, in particolare dai suoi apparati di sicurezza, con strategie illegali adottate dalla fine degli anni ’70. Leader come l’ex presidente P. W. Botha e lo State Security Council hanno contribuito a creare un clima che ha facilitato queste violazioni su vasta scala. Le cause sono complesse, legate al contesto politico e alle dinamiche psicologiche di gruppo. I responsabili hanno responsabilità anche se erano parte del sistema. La riconciliazione è un processo complesso e lungo, necessario per una pace duratura. Richiede verità, responsabilità, rispetto reciproco e l’impegno di tutti. Implica affrontare le disuguaglianze economiche e costruire una cultura dei diritti umani. Non comporta necessariamente il perdono, ma la volontà di coesistere e risolvere i conflitti in modo non violento. La conservazione della memoria storica è fondamentale per questo processo.Riassunto Lungo
1. Il Conflitto Sudafricano: Violazioni e Responsabilità (1960-1990)
Il periodo tra il 1960 e il 1990 in Sudafrica è stato segnato da gravi violazioni dei diritti umani, sia all’interno che all’esterno del paese. Questo contesto era fortemente influenzato dal razzismo di stato, dal processo di decolonizzazione in Africa e dalla Guerra Fredda. Il governo sudafricano utilizzava il razzismo per identificare la popolazione nera come “nemica” e definiva l’opposizione politica come “comunista”.Le azioni del governo sudafricano
Le forze di sicurezza dello stato usavano metodi sia visibili che nascosti per fermare chi faceva resistenza. Tra i metodi visibili c’erano l’esilio, il divieto di attività e le condanne a morte decise dai tribunali, spesso per reati politici e con molte vittime tra la popolazione nera. I metodi nascosti includevano l’uso sistematico della tortura sui prigionieri per ottenere informazioni e ammissioni, e l’uccisione di attivisti senza un processo. La polizia usava una forza eccessiva per controllare le manifestazioni, causando morti e feriti. Il governo conduceva operazioni militari anche negli stati vicini, come l’Angola e la Namibia. Queste azioni includevano attacchi a basi, rapimenti, torture e uccisioni di rifugiati e combattenti. Un esempio noto è l’attacco avvenuto a Kassinga nel 1978.Le violazioni commesse dai movimenti di liberazione
Anche i movimenti che lottavano per la liberazione, come l’ANC e il PAC, commisero gravi violazioni. Queste azioni si verificarono durante la lotta armata e colpirono anche persone civili. Ci furono anche abusi contro i loro stessi membri che erano sospettati di essere informatori. Inoltre, i sostenitori dei movimenti commisero violenze durante le proteste di massa, spesso contro persone considerate collaboratori del governo.La situazione nelle “homeland”
Le aree chiamate “homeland”, create per dividere la popolazione in base alla razza, divennero un altro luogo dove avvennero violazioni. Le forze di sicurezza di queste aree erano controllate dal governo sudafricano. La regione del KwaZulu, controllata dal gruppo Inkatha, ebbe il numero più alto di violazioni tra le homeland. L’Inkatha usava le risorse dello stato e riceveva supporto segreto per combattere i suoi oppositori.Esempi specifici di violazioni
Alcuni casi specifici aiutano a capire meglio la gravità di queste violazioni. L’incidente aereo in cui morì il presidente mozambicano Samora Machel sollevò dubbi su un possibile coinvolgimento del Sudafrica, forse tramite un segnale falso per deviare l’aereo. Un altro esempio è il Mandela United Football Club, un gruppo legato a Winnie Madikizela-Mandela, che fu responsabile di aggressioni, rapimenti e uccisioni di giovani nella zona di Soweto.Ma è sufficiente elencare le violazioni di entrambe le parti senza indagare a fondo le dinamiche di potere e le diverse motivazioni che le hanno generate?
Il capitolo, nel presentare le violazioni commesse sia dal governo che dai movimenti di liberazione, solleva un punto cruciale sulla natura del conflitto. Tuttavia, per valutare appieno la portata e la responsabilità di tali azioni, è fondamentale considerare il contesto di potere profondamente diseguale in cui si sono verificate. Un’analisi più approfondita richiederebbe di esplorare le specifiche strategie di oppressione statale e le risposte, anche violente, di chi lottava contro un sistema istituzionalizzato di razzismo e negazione dei diritti. Per approfondire queste tematiche, è utile studiare la storia del Sudafrica, la sociologia dei conflitti e le analisi politiche del periodo. Autori come Mahmood Mamdani offrono spunti critici sulla violenza politica e sui processi di transizione.2. L’ombra della violenza sulla transizione
Le indagini sulle violazioni commesse tra il 1990 e il 1994 presentano notevoli difficoltà, a differenza di quelle relative ai periodi precedenti. La violenza di questi anni assume una natura più anonima e si intreccia strettamente con i negoziati in corso per la transizione democratica. Questo periodo è segnato da una forte escalation della violenza e da gravi violazioni dei diritti umani. Oltre la metà delle denunce di omicidio ricevute dalla Commissione riguardano eventi accaduti in questo arco di tempo. Altre fonti stimano che ci siano state almeno 14.000 morti politiche tra il 1990 e il 1994, suggerendo che i dati raccolti dalla Commissione per questo periodo siano sottostimati.L’escalation del conflitto
La violenza aumenta significativamente negli anni ’90, in particolare a partire dall’intensificazione del conflitto nel KwaZulu/Natal. Lo scontro in questa regione si aggrava drammaticamente, portando a centinaia di morti politiche ogni mese. Questa escalation coincide con la formazione e i tentativi di espansione dell’Inkatha Freedom Party (IFP) e, contemporaneamente, con lo sviluppo di squadre di autodifesa da parte dell’ANC e dell’UDF (United Democratic Front). Molti assassini politici colpiscono membri dell’ANC e delle organizzazioni ad essa alleate.Il ruolo delle forze di sicurezza
Le forze di polizia continuano a fare un uso letale della forza nella gestione dell’ordine pubblico. Centinaia di persone vengono uccise dalle forze di sicurezza durante queste operazioni. Incidenti gravi si verificano in diverse località, come Sebokeng, Daveyton, Alexandra e Vereeniging, dove la polizia apre il fuoco su manifestanti, causando morti e feriti, spesso colpiti alla schiena mentre fuggono. Nonostante in alcuni casi siano state emesse raccomandazioni per processare gli agenti coinvolti, non viene intrapresa alcuna azione legale. La detenzione indiscriminata e la tortura da parte della polizia persistono nei primi anni ’90, colpendo soprattutto i sostenitori dell’ANC e del Movimento democratico di massa, in particolare nelle aree rurali. Le indagini condotte dalla polizia mostrano spesso negligenza, come evidenziato nel caso dell’omicidio Asvat, dove connessioni evidenti tra le testimonianze non vengono adeguatamente esaminate.Gli eventi nelle homeland
Anche le homeland, entità territoriali create durante l’apartheid, vengono influenzate dal ritorno alla legalità dei partiti politici nel 1990. I loro leader partecipano ai negoziati per il futuro del Sudafrica, spesso modificando le proprie posizioni politiche nel corso del processo. Eventi di grande rilevanza si verificano nelle homeland che oppongono resistenza alla loro reincorporazione nel Sudafrica unificato. Un esempio drammatico è il massacro di Bisho nel settembre 1992, dove i soldati sparano su una marcia organizzata dall’ANC, uccidendo trenta persone. Questo tragico episodio, pur portando i negoziati sull’orlo del fallimento, contribuisce in realtà a rafforzare la determinazione di molti leader politici a trovare un accordo pacifico e a completare la transizione.Il capitolo, pur descrivendo la violenza “anonima” e le negligenze della polizia, affronta adeguatamente il potenziale ruolo di elementi statali o di una “terza forza” nell’escalation e nella natura di questa violenza?
Il capitolo evidenzia giustamente le difficoltà investigative e la natura sfuggente della violenza tra il 1990 e il 1994, legandola ai negoziati e agli scontri tra i principali attori politici non statali. Tuttavia, la documentata persistenza dell’uso letale della forza da parte della polizia, la mancanza di procedimenti legali contro gli agenti e le indagini negligenti sollevano interrogativi sul grado di complicità o di deliberata inazione da parte degli apparati statali. Non è del tutto chiaro dal capitolo quanto questi fattori abbiano contribuito attivamente all’escalation o abbiano favorito l’anonimato degli aggressori. Per approfondire questo aspetto controverso, è cruciale esaminare la letteratura storica e politologica che ha analizzato il concetto di “terza forza” in Sudafrica e il ruolo ambiguo di settori dello stato durante la transizione. Studiosi come Tom Lodge o Stephen Ellis hanno esplorato queste dinamiche, offrendo prospettive che vanno oltre la semplice contrapposizione tra partiti politici.3. Voci dalle Regioni del Conflitto
Gravi violazioni dei diritti umani hanno segnato diverse aree del Sudafrica tra il 1960 e il 1994. Queste violazioni sono state documentate in profili specifici per ogni regione, seguendo un ordine che riflette i cambiamenti nel tempo sia nella resistenza contro l’apartheid che nella repressione attuata dal governo.Eastern Cape
Nell’Eastern Cape, una regione dove l’ANC era molto presente, si sono verificati attacchi armati e molte persone sono morte mentre erano detenute, come nel tragico caso di Steve Biko. La tortura era una pratica diffusa e ci sono stati scontri violenti tra diverse fazioni politiche e le forze di sicurezza. Un esempio è la morte di George Botha nel 1972, mentre era sotto custodia della polizia, per la quale non è mai stata stabilita una responsabilità chiara. Un altro evento grave è stata la strage di Langa nel 1985, quando la polizia ha aperto il fuoco su una marcia, uccidendo venti persone. La Commissione d’inchiesta ha ritenuto la polizia responsabile per aver usato una forza eccessiva in questi e altri casi simili.Natal e KwaZulu
Nelle regioni di Natal e KwaZulu, molte denunce hanno riguardato omicidi politici e scontri tra i sostenitori del partito IFP e quelli dell’alleanza ANC/UDF. La polizia usava la tortura non solo per ottenere informazioni, ma anche per costringere le persone a diventare collaboratori. Individui come Leonard Nkosi, che da ex membro dell’MK era diventato testimone per la polizia, sono stati assassinati. La tortura era una pratica comune e sistematica, come dimostrano i casi di Joseph Nduli, Cleopas Ndlovu e Zephaniah Lekoane Mothopeng, che sono stati sottoposti a metodi estremamente violenti durante la loro detenzione.Western Cape
Nel Western Cape, le violazioni includevano maltrattamenti, detenzioni arbitrarie e omicidi. Ci sono stati picchi di violenza nel 1976 e tra il 1985 e il 1986. Le vittime erano in maggioranza giovani uomini legati all’ANC e all’UDF. La polizia sudafricana è stata indicata come la principale responsabile di questi abusi. Eventi come la rivolta studentesca del 1976, che ha causato morti a Langa e tra la popolazione coloured, e la resistenza contro le deportazioni a Crossroads nel 1985, hanno mostrato chiaramente l’uso della forza letale da parte della polizia contro i manifestanti.Transvaal
Nel Transvaal, il massacro di Sharpville nel 1960 ha rappresentato un momento cruciale, portando al divieto dell’ANC e del PAC e a una rapida escalation della violenza. Le leggi sui lasciapassare limitavano severamente la possibilità per i neri di vivere e spostarsi nelle aree urbane. La rivolta di Soweto nel 1976, scoppiata per l’imposizione dell’afrikaans nelle scuole, ha causato centinaia di morti e feriti, molti dei quali erano giovani studenti. In risposta a queste proteste, la polizia ha adottato politiche di “sparare per uccidere”. Il periodo tra il 1983 e il 1989 ha visto il livello più alto di violazioni, con detenzioni di massa, tortura diffusa e scontri estremamente violenti nelle township. La tortura era sistematica e la detenzione senza processo è stata ampliata notevolmente, con la maggior parte dei detenuti che subiva maltrattamenti o torture.Il Ruolo delle Forze dell’Ordine
In tutte le regioni, la polizia è stata costantemente identificata come il principale autore di omicidi, torture e maltrattamenti. Sebbene anche alcuni gruppi di opposizione abbiano commesso violazioni, l’impunità di cui godevano gli agenti di polizia ha contribuito in modo determinante al perpetuarsi degli abusi e alla gravità delle violazioni dei diritti umani documentate in tutto il paese.Come si può discutere della complicità delle istituzioni senza affrontare adeguatamente il tema cruciale della responsabilità e della giustizia nel periodo post-apartheid?
Il capitolo descrive in dettaglio il ruolo di vari settori della società nel sostenere o non opporsi all’apartheid, ma lascia aperta la questione fondamentale di come la società sudafricana abbia poi gestito il peso di questa complicità. La transizione democratica ha necessariamente incluso processi per affrontare il passato, come la Commissione per la Verità e la Riconciliazione (TRC), che ha indagato specificamente sul ruolo delle istituzioni. Ignorare questo aspetto cruciale significa tralasciare una parte essenziale del percorso di un paese verso la giustizia e la guarigione. Per approfondire, è indispensabile studiare i meccanismi di giustizia transizionale e le dinamiche della TRC, consultando le analisi di figure chiave come Desmond Tutu.5. Affrontare il Passato: Risarcimento e Riconciliazione
Durante l’apartheid, la maggioranza dei sudafricani subì la negazione dei diritti fondamentali e una forte repressione. L’opposizione al regime portò a esili forzati, divieti, dispersione violenta delle proteste e migliaia di persone furono incarcerate. Questa repressione generò molta frustrazione e rabbia nella popolazione, alimentando un conflitto violento. Durante questo periodo ci furono abusi dei diritti umani commessi da tutte le parti coinvolte nel conflitto, ma la maggior parte di queste violazioni fu opera dello stato.Il diritto delle vittime al risarcimento
Le persone che subirono queste gravi violazioni hanno diritto a ricevere risarcimenti e assistenza per guarire dalle perdite subite. Queste misure sono fondamentali per aiutare le vittime a riprendersi e per favorire la riconciliazione nel paese. Servono anche a bilanciare l’amnistia concessa a chi ha commesso le violazioni, impedendo alle vittime di fare causa per danni in tribunale. Il governo ha il dovere morale di garantire questi risarcimenti per riparare, almeno in parte, ai torti del passato.Forme di risarcimento e riabilitazione
La politica di aiuto alle vittime prevede diverse forme di sostegno. Include assistenza immediata per chi si trova in condizioni di grave bisogno e sussidi economici individuali per coloro che hanno subito violazioni molto gravi. Ci sono anche misure con un valore simbolico, come la creazione di memoriali o l’istituzione di giornate dedicate alla memoria delle vittime. Vengono offerti supporto legale e amministrativo, programmi specifici per aiutare le comunità più colpite a riprendersi e riforme nelle istituzioni per evitare che simili violazioni accadano di nuovo in futuro. Hanno diritto a questi aiuti le vittime dirette, i loro familiari e le persone che dipendevano da loro, purché si trovino in condizioni di necessità.I responsabili delle violazioni
Le gravi violazioni dei diritti umani furono commesse in larga parte dallo stato sudafricano stesso, specialmente dai suoi apparati di sicurezza. Dalla fine degli anni ’70, lo stato iniziò a usare strategie illegali per contrastare l’opposizione. Queste includevano omicidi senza processo, torture, rapimenti e maltrattamenti sistematici. Figure di spicco del governo di allora, come l’ex presidente P. W. Botha e l’organo chiamato State Security Council, contribuirono a creare un clima che rese possibili queste violazioni su vasta scala, rendendole quasi una prassi.Le cause profonde delle violazioni
Per capire perché accaddero queste violazioni, bisogna considerare il contesto storico e politico di quel tempo. Fattori come la Guerra Fredda, i movimenti anti-coloniali, il razzismo istituzionalizzato e il sistema dell’apartheid crearono un ambiente di forte tensione. A questi si aggiunsero dinamiche psicologiche di gruppo, come la tendenza a obbedire agli ordini superiori senza discutere e una forte ostilità verso i gruppi considerati “diversi” o nemici. Chi commise queste azioni può essere visto in parte come influenzato e plasmato dal sistema in cui viveva, ma questo non cancella la loro responsabilità individuale per le azioni compiute.Il difficile cammino della riconciliazione
La riconciliazione è un percorso lungo e complicato, ma indispensabile per costruire una pace duratura in Sudafrica. Richiede che venga stabilita la verità su quanto accaduto e che i responsabili si assumano le proprie colpe. È fondamentale che ci sia rispetto reciproco tra tutti i cittadini, indipendentemente dal loro passato, e che tutti si impegnino attivamente in questo processo. La riconciliazione implica anche affrontare problemi ancora presenti, come le profonde disuguaglianze economiche, la criminalità diffusa e la corruzione. Non significa necessariamente che le vittime debbano perdonare chi le ha fatte soffrire, ma implica la volontà di convivere pacificamente e di risolvere i conflitti futuri senza violenza. Mantenere viva la memoria storica di quel periodo è un elemento cruciale per il successo di questo processo.Davvero un risarcimento può “bilanciare” l’impossibilità per le vittime di cercare giustizia in tribunale?
Il capitolo accenna al fatto che i risarcimenti servano a bilanciare l’amnistia concessa ai responsabili, impedendo alle vittime di adire le vie legali. Questa è una delle questioni più dibattute e controverse relative ai processi di giustizia di transizione, come quello sudafricano. L’idea che una compensazione economica o simbolica possa sostituire il diritto a un processo e a una sentenza è tutt’altro che universalmente accettata. Per comprendere meglio questa tensione, è utile approfondire gli studi sulla giustizia di transizione, in particolare le analisi critiche del modello della Commissione per la Verità e la Riconciliazione. Autori come Mahmood Mamdani hanno sollevato dubbi significativi sull’efficacia e l’equità di tali compromessi.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]