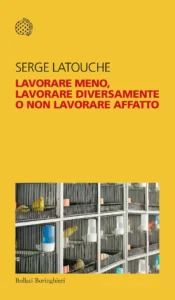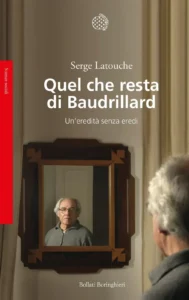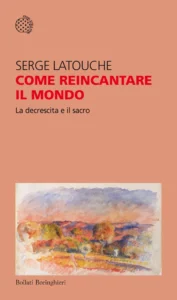Contenuti del libro
Informazioni
“Usa e getta. Le follie dell’obsolescenza programmata” di Serge Latouche è un viaggio illuminante nel cuore del nostro modello economico e di consumo. Il libro ti porta indietro nel tempo, all’inizio del XX secolo, principalmente negli Stati Uniti, per capire come è nata e si è diffusa l’idea di far durare poco le cose che compriamo. Non si parla solo di obsolescenza tecnica, quella “normale” dovuta al progresso, ma soprattutto di quella psicologica, creata dalla pubblicità per farti sentire sempre “out” con quello che hai, e di quella programmata, dove i prodotti sono proprio progettati per rompersi dopo un po’. Latouche smaschera questa strategia industriale che alimenta un consumismo sfrenato e uno spreco enorme, mostrandone le conseguenze devastanti sulla crisi ecologica e le profonde implicazioni etiche di un sistema che sembra considerare persino le persone come “obsolete” di fronte al progresso tecnologico. Ma non è tutto nero: il libro esplora anche le resistenze e le alternative possibili, puntando i riflettori sulla necessità di un cambiamento radicale verso la decrescita, un modello basato sulla durabilità, la riparazione e l’uso condiviso dei beni, per costruire un futuro più sostenibile e umano, lontano dalle “follie dell’obsolescenza programmata”.Riassunto Breve
L’obsolescenza nasce all’inizio del Novecento con gli elettrodomestici moderni, partendo dall’adulterazione dei prodotti per ridurre i costi e aumentare le vendite, una pratica ingannevole considerata un’antenata europea dell’obsolescenza programmata sviluppatasi negli Stati Uniti. Esistono tre forme principali: l’obsolescenza tecnica dovuta al progresso, l’obsolescenza psicologica indotta da pubblicità e moda per spingere al cambio frequente, e l’obsolescenza programmata, che è l’usura artificiale e intenzionale di un prodotto progettato per durare poco. Mentre l’obsolescenza tecnica è un effetto del progresso, quella psicologica e programmata sono deliberate e più recenti. Negli anni Venti negli Stati Uniti si passa all’obsolescenza psicologica manipolando i consumatori, e poi si afferma quella programmata come strategia industriale con difetti predeterminati. Attuare l’obsolescenza programmata è difficile senza monopolio o accordi tra produttori, come nel caso del cartello Phoebus che limitò la vita delle lampadine. L’obsolescenza simbolica, basata sulla persuasione pubblicitaria, rende i prodotti obsoleti anche se funzionanti. Le tre forme si combinano, spingendo i consumatori a sostituire i beni spesso prima che siano rotti, alimentando un ciclo di consumo continuo con poca resistenza. L’obsolescenza programmata, pur avendo radici europee come la moda e la logica del profitto, si sviluppa pienamente negli Stati Uniti, trovando terreno fertile nelle tendenze umane al consumo ostentativo e nelle logiche economiche. Società antiche avevano un’etica del riuso, ma la produzione industriale di massa cambia tutto. Negli anni Venti americani, pubblicità e marketing promuovono il consumo rapido contro l’etica del risparmio. Il modello “usa e getta” inizia con l’igiene, seguito dal “modello Detroit” nell’auto con l’obsolescenza psicologica legata al design. L’obsolescenza progressiva si estende a molti settori, e l’usa e getta si diffonde con la riduzione dei costi e la globalizzazione, arrivando all’obsolescenza alimentare con le date di scadenza e lo spreco. L’ideologia dell’usa e getta permea la società, rischiando di considerare persino l’uomo obsoleto. La moralità dell’obsolescenza programmata è dibattuta: alcuni la vedono necessaria per la crescita economica e l’occupazione, stimolando il consumo continuo. Altri la denunciano come ingannevole, che sacrifica onestà e qualità promuovendo lo spreco. Questa logica dell’effimero mette in discussione il valore umano di fronte all’avanzamento tecnologico e al rischio di obsolescenza dell’uomo stesso, un tema legato al transumanismo. L’obsolescenza programmata è una sfida etica per il futuro. Questo inganno non può durare per sempre a causa dei limiti ecologici e della reazione dei consumatori, come avvenuto negli anni Cinquanta con l’industria automobilistica americana o nella pianificazione urbana. Nonostante ciò, lo spreco continua, aggravando la crisi ecologica con consumo di risorse e rifiuti tossici. Libri e associazioni di consumatori hanno denunciato queste pratiche, ma i risultati sono limitati. La lotta è difficile perché i prodotti sono progettati per non essere riparati. La crisi ecologica mette in discussione il modello di sviluppo, con rischi di autoritarismo per gestire le risorse. Soluzioni come lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare (riciclo, ecodesign, esempi come Kalundborg) cercano di conciliare crescita e ambiente, ma richiedono politiche pubbliche incisive, non solo responsabilità d’impresa. È illusorio credere in una compatibilità spontanea tra produzione e limiti ambientali. Le critiche all’obsolescenza programmata sono antiche, intensificatesi negli anni Sessanta con la società dei consumi. Per un futuro sostenibile, serve una società basata sulla decrescita, che cambi produzione, consumo e pensiero. Bisogna sostituire l’obsolescenza programmata con durevolezza, riparabilità e riciclo, riducendo l’impatto ecologico. Una prosperità senza crescita richiede un piano di discesa produttiva, ispirato ai modelli delle città in transizione. La decrescita non è rinuncia al benessere, ma limitazione dei bisogni per felicità e autonomia, rifiutando la manipolazione consumistica. La frugalità è una scelta consapevole per una vita più piena e conviviale. L’uso condiviso di beni durevoli rafforza la comunità e facilita riparazione e scelte informate. La gestione delle risorse non rinnovabili richiede beni durevoli e riparabili, forse con autorità globali e quote. La decrescita implica un cambiamento nel rapporto con la natura, superando la visione degli oggetti come semplici merci. Riscoprire meraviglia e gratitudine verso natura e oggetti favorisce una decrescita serena, allontanando il rischio di obsolescenza estesa all’umanità.Riassunto Lungo
1. L’Arte dell’Effimero
L’origine dell’obsolescenza
All’inizio del Novecento, con la diffusione degli elettrodomestici moderni, si inizia a parlare di obsolescenza. Inizialmente, questo fenomeno era visto come una pratica ingannevole chiamata “adulterazione dei prodotti”. L’adulterazione consisteva nel ridurre la qualità dei prodotti per abbassarne i costi e, allo stesso tempo, stimolare le persone a comprare di più. Questa pratica europea può essere considerata un precursore dell’obsolescenza programmata, che invece nasce negli Stati Uniti.Le diverse forme di obsolescenza
Esistono tre tipi principali di obsolescenza, che si differenziano per le loro cause e modalità:- Obsolescenza tecnica: è causata dal progresso della tecnologia. Le nuove tecnologie rendono i prodotti più vecchi superati e meno desiderabili, anche se ancora funzionanti.
- Obsolescenza psicologica: è creata dalla pubblicità e dalle mode. Questi fattori spingono le persone a voler cambiare prodotti ancora perfettamente funzionanti solo perché considerati “vecchi” o “fuori moda”.
- Obsolescenza programmata: è la progettazione intenzionale di prodotti con una durata limitata. In pratica, i prodotti sono realizzati apposta per rompersi o diventare inutilizzabili dopo un certo periodo di tempo.
L’evoluzione dell’obsolescenza nel tempo
L’obsolescenza tecnica è una conseguenza inevitabile dello sviluppo industriale e tecnologico. Al contrario, l’obsolescenza psicologica e quella programmata sono strategie più recenti e volute. Negli anni ’20, negli Stati Uniti, si diffonde l’obsolescenza psicologica. Attraverso la pubblicità, si convincevano le persone a sostituire spesso i prodotti, anche se non necessario, per seguire le mode del momento. Successivamente, si è affermata l’obsolescenza programmata come vera e propria strategia industriale. Le aziende hanno iniziato a progettare i prodotti con difetti nascosti, in modo da accelerarne il ciclo di vita e aumentare le vendite.Le difficoltà e le conseguenze dell’obsolescenza programmata
Mettere in pratica l’obsolescenza programmata non è facile a causa della concorrenza tra aziende. Per funzionare, richiede che ci siano monopoli o accordi tra i produttori. Un esempio è il “cartello Phoebus”, un accordo tra aziende produttrici di lampadine che limitò la loro durata a sole 1000 ore. L’obsolescenza simbolica, che si basa sulla forza della pubblicità, rappresenta l’evoluzione più avanzata di questo fenomeno. In questo caso, i prodotti diventano obsoleti nella percezione delle persone anche se non hanno alcun difetto reale.L’impatto dell’obsolescenza sui consumatori
Questi tre tipi di obsolescenza si combinano tra loro, influenzando l’opinione pubblica e spingendo le persone a comprare continuamente nuovi prodotti. Spesso, i consumatori sostituiscono i beni anche quando sono ancora funzionanti. La paura che i prodotti si rompano e la pressione sociale a essere sempre alla moda alimentano questo continuo bisogno di acquistare. I consumatori, ormai abituati a questo sistema, oppongono poca resistenza a questo modello di consumo incessante.Se l’obsolescenza programmata è una strategia industriale consolidata, quali sono le responsabilità etiche delle aziende e le conseguenze ambientali di un modello economico basato sulla continua sostituzione dei prodotti?
Il capitolo descrive efficacemente l’evoluzione dell’obsolescenza, ma tralascia un aspetto cruciale: quello delle implicazioni etiche e ambientali di tali pratiche. Approfondire le opere di autori come Serge Latouche sull’economia della decrescita o studiare i principi dell’economia circolare potrebbe fornire una prospettiva più critica e completa sul tema.2. L’Era dell’Effimero: Ascesa e Diffusione dell’Obsolescenza Programmata
Introduzione all’obsolescenza programmata
L’obsolescenza programmata si manifesta nelle sue forme tecniche e psicologiche. Questa pratica è nata negli Stati Uniti, ma ha radici culturali in Europa. Fenomeni come la moda e l’ossessione capitalistica per la vendita esistevano già prima dell’obsolescenza programmata. Tuttavia, hanno trovato negli Stati Uniti un ambiente ideale per svilupparsi rapidamente.Le origini antropologiche ed economiche
Le basi dell’obsolescenza programmata si trovano in alcune tendenze umane, come il desiderio di consumo appariscente, e in logiche economiche orientate al profitto. Nella storia, le società hanno spesso mostrato una preferenza per il lusso e lo spreco. La morale e la religione hanno cercato di limitare questi comportamenti, soprattutto nelle società preindustriali. In queste società, la tradizione e la necessità promuovevano un modo di vivere basato sul riutilizzo e sulla durata dei beni.L’adulterazione dei prodotti come precedente
Un esempio storico di pratiche simili all’obsolescenza programmata è l’adulterazione dei prodotti. Questa pratica antica consisteva nel ridurre la qualità dei prodotti per abbassare i costi e aumentare le vendite ingannando i consumatori. Con l’arrivo della produzione industriale di massa, l’obsolescenza programmata è diventata una strategia economica centrale.La trasformazione della mentalità negli Stati Uniti degli anni ’20
Negli Stati Uniti degli anni ’20, la mentalità dei consumatori cambia. La pubblicità e il marketing spingono le persone a non risparmiare più e a consumare rapidamente e ripetutamente. L’introduzione di prodotti “usa e getta” per l’igiene personale è un primo passo in questa direzione. Successivamente, l’industria automobilistica con il “modello Detroit” introduce l’obsolescenza psicologica, legata alla moda e al design.Diffusione e conseguenze dell’obsolescenza programmata
L’obsolescenza progressiva diventa una strategia industriale diffusa in molti settori, dagli elettrodomestici all’abbigliamento. L’obiettivo è incentivare le persone a comprare continuamente nuovi prodotti. L’usa e getta si diffonde ulteriormente grazie alla riduzione dei costi di produzione e alla globalizzazione, arrivando fino al cibo con l’obsolescenza alimentare, caratterizzata dalle date di scadenza e dal grande spreco di cibo.L’ideologia dell’usa e getta e il rischio per la società
L’idea dell’usa e getta influenza profondamente la società, estendendosi dai beni materiali ai valori e alle relazioni sociali. Il rischio più grande è che si arrivi a considerare le persone stesse come prodotti da usare e gettare.Se la tendenza allo spreco e al lusso è una costante antropologica, come mai l’obsolescenza programmata esplode solo in un preciso momento storico e geografico, e viene presentata come un fenomeno specificamente statunitense, anziché come una logica intrinseca al capitalismo globale?
Il capitolo sembra suggerire che l’obsolescenza programmata sia una naturale evoluzione di tendenze umane preesistenti, quasi deresponsabilizzando le specifiche dinamiche economiche e politiche che ne hanno favorito l’affermazione. Per comprendere meglio le origini e la diffusione di questo fenomeno, sarebbe utile approfondire la storia economica del capitalismo industriale e le teorie sociologiche sul consumo di autori come Thorstein Veblen e Zygmunt Bauman.3. L’Etica Effimera: Morale e Consumo nell’Era dell’Obsolescenza Programmata
Obsolescenza programmata e necessità economica
Si discute se l’obsolescenza programmata sia morale in un periodo storico in cui l’etica sembra superata dalle logiche economiche. L’obsolescenza programmata viene presentata come necessaria per la crescita dell’economia e per la stabilità della società. Si pensa che questa pratica serva soprattutto per diminuire la disoccupazione nei periodi di crisi economica. Si dice che ridurre di proposito la durata dei prodotti sia essenziale per far aumentare sempre i consumi, che sono la base del sistema economico di oggi. Questa idea è molto diffusa e accettata nel mondo economico e industriale.Il dibattito etico sull’obsolescenza programmata
Anche se ci sono queste giustificazioni economiche, emergono importanti problemi etici. C’è un grande dibattito sulla moralità di creare prodotti che durano poco. Ingegneri e manager hanno opinioni molto diverse su questo argomento. Alcuni pensano che l’obsolescenza sia utile per far progredire la tecnologia e per evitare che il mercato si blocchi perché tutti hanno già tutto. Altri invece criticano questa pratica, dicendo che è disonesta e che rovina i valori importanti come l’onestà e la qualità dei prodotti. Questi critici sostengono che l’obsolescenza programmata spinge le persone a sprecare e a comprare cose nuove continuamente, anche quando non ne hanno bisogno.L’obsolescenza programmata e il futuro dell’umanità
La logica dell’effimero, che è alla base dell’obsolescenza programmata, ci porta a interrogarci sul ruolo e sul valore delle persone. La tecnologia avanza velocemente e ci si chiede se anche l’uomo possa diventare obsoleto, superato dalle capacità delle macchine. Da queste riflessioni nasce il transumanismo, una corrente di pensiero che immagina futuri in cui l’etica e i valori umani sono ancora più a rischio, in un mondo dominato dalla tecnologia e da un consumo sempre più rapido. Quindi, l’obsolescenza programmata non è solo un problema di economia o di tecnica, ma è una sfida etica che riguarda il futuro della società e dell’umanità intera. Questa pratica mette in discussione il nostro modo di vivere e i valori su cui si basa la nostra società.Se l’innovazione tecnologica è spesso accusata di alimentare l’obsolescenza programmata, possiamo davvero confidare nella stessa innovazione per superarla e abbracciare un’economia circolare, o non stiamo semplicemente perpetuando un’ingenua fede nella “bacchetta magica” tecnologica?
Il capitolo presenta una critica lucida all’obsolescenza programmata e propone l’economia circolare come alternativa necessaria. Tuttavia, la transizione verso un modello economico realmente sostenibile è complessa e non priva di ostacoli. Affidarsi unicamente all’innovazione tecnologica per risolvere problemi che sono anche di natura sociale, politica ed economica potrebbe rivelarsi una strategia insufficiente o addirittura fuorviante. Per comprendere appieno le sfide e le opportunità legate all’economia circolare, è utile approfondire studi di economia ambientale, sociologia dei consumi e politiche industriali. Autori come Nicholas Georgescu-Roegen, con la sua critica alla crescita illimitata, o Tim Jackson, che analizza i limiti del consumismo, possono offrire spunti di riflessione preziosi per navigare questa transizione cruciale.5. L’Imperativo della Decrescita
Le origini della critica alla crescita industriale
La rivoluzione industriale ha presto suscitato delle critiche, in particolare riguardo all’obsolescenza programmata. Questa pratica è stata subito vista come un modo di sprecare risorse naturali e di non rispettare il lavoro delle persone. Già negli anni sessanta, queste critiche si sono fatte più forti, analizzando in modo approfondito questo fenomeno che si era diffuso ampiamente con la società dei consumi e il modello di produzione fordista.La necessità di un modello basato sulla decrescita
Per assicurare un futuro all’umanità, è fondamentale costruire una società che si basi sulla decrescita. Questo significa cambiare radicalmente il nostro modo di produrre, di consumare e di pensare. Invece di prodotti fatti per durare poco, bisogna puntare su oggetti che durino nel tempo, che si possano riparare e riciclare. In questo modo, si riduce l’impatto sull’ambiente e si consumano meno risorse naturali. Per arrivare a una società prospera senza crescita economica, serve un piano per ridurre la produzione, prendendo esempio da quelle città che puntano all’autosufficienza energetica e alla capacità di adattarsi ai cambiamenti.Decrescita non significa rinuncia al benessere
La decrescita non vuol dire vivere peggio o tornare indietro a modi di vita primitivi. Al contrario, propone di limitare i bisogni come strada per essere più felici e autonomi. Si tratta di rifiutare di essere manipolati dalla pubblicità e di non dipendere troppo dal mercato e dalla tecnologia. Vivere in modo più semplice non è una rinuncia, ma una scelta consapevole per una vita più ricca e piacevole, che lascia spazio alla creatività e riduce la nostra dipendenza da risorse che stanno finendo.L’importanza dell’uso condiviso e della gestione delle risorse
Condividere l’uso di oggetti che durano a lungo è molto importante per la decrescita. Questo rafforza i legami tra le persone e rende le comunità più forti. In questo modo, possiamo scegliere con più attenzione prodotti di qualità e realizzati in modo etico, e possiamo riparare gli oggetti e farli durare più a lungo. È cruciale usare con attenzione le risorse non rinnovabili. Le industrie devono impegnarsi a produrre oggetti resistenti e riparabili. Forse, per gestire al meglio le risorse di tutto il pianeta, servirebbe un’autorità mondiale e un sistema di quote per l’utilizzo dei beni comuni.Un nuovo rapporto con la natura
La decrescita implica un cambiamento profondo nel nostro modo di vedere la natura. Dobbiamo superare l’idea consumistica che riduce tutto a merce. Riscoprire la bellezza della natura e apprezzare gli oggetti che ci circondano può aiutarci a costruire una società basata sulla decrescita, più serena e lontana dal rischio di un’obsolescenza programmata che si estende all’umanità stessa.Ma se la decrescita è la risposta, perché le società che la perseguono non prosperano, anzi spesso sperimentano povertà e instabilità?
Il capitolo presenta la decrescita come imperativo categorico, ma sorvola sulle sfide pratiche e sulle potenziali conseguenze indesiderate di un simile modello economico. Sarebbe opportuno analizzare criticamente se la decrescita sia un modello sostenibile e desiderabile in tutte le sue forme, o se alcune forme di crescita siano invece necessarie per il benessere umano e la stabilità sociale. Approfondire le opere di economisti come J.M. Keynes o F. Hayek potrebbe offrire una prospettiva più ampia sulle dinamiche economiche e sulle politiche più efficaci per affrontare le sfide contemporanee.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]