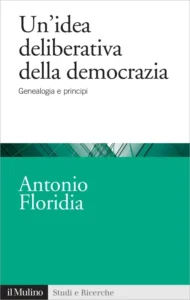1. Dalla Piazza alla Delibera Costituzionale
L’inizio della democrazia partecipativa Negli Stati Uniti, negli anni Sessanta, l’idea di democrazia in cui tutti partecipano attivamente prende piede. Questo accade grazie ai movimenti sociali e al desiderio delle persone di decidere da sé e di essere uguali. Pensatori come Pateman e Macpherson hanno spiegato che partecipare funziona davvero solo se si ha il potere di decidere. La “scala” di Arnstein mostra i diversi modi in cui i cittadini possono essere coinvolti, a seconda di quanto controllo hanno. L’idea principale è che ognuno possa governare sé stesso e crescere come persona. Questa visione viene dalla tradizione americana che dà molta importanza al singolo cittadino nella democrazia. Però, questo modo di vedere le cose guarda soprattutto ai piccoli gruppi o alle città e pensa a una partecipazione diretta che serve ad arrivare subito a una decisione.Nuove idee negli anni Ottanta
Negli anni Ottanta, quando la democrazia partecipativa ha perso un po’ di forza, sono nate nuove idee. Benjamin Barber parla di una “democrazia forte”. Dice che la democrazia rappresentativa, che lui chiama “leggera”, non funziona bene perché le persone non si interessano. Barber pensa che la democrazia sia un modo di vivere insieme che chiede alle persone di partecipare davvero, parlando in pubblico, prendendo decisioni e agendo. Ma capisce anche che bisogna aggiungere modi per partecipare alle regole che già ci sono, senza cambiare tutto. La sua idea, influenzata da pensieri pratici e dall’idea di repubblica, dice che una persona è davvero libera se partecipa a decidere per la comunità.Jane Mansbridge ha studiato come funziona davvero la partecipazione nella realtà. Spiega la differenza tra democrazia dell'”unità”, dove tutti hanno gli stessi interessi e sono d’accordo, e democrazia dello “scontro”, dove ci sono interessi diversi e si decide a maggioranza. Fa vedere che anche nei piccoli gruppi ci sono ancora differenze e litigi e dice che servono sia la democrazia dell’unità che quella dello scontro. La sua analisi sottolinea che è normale avere interessi diversi e che bisogna parlarne e discuterne. Questo è diverso dall’idea di prima che pensava di eliminare i litigi.
La democrazia deliberativa e la Costituzione
Il termine “democrazia deliberativa” viene usato in questo periodo, ma in un ambiente diverso: quello di chi studia la Costituzione americana. Joseph M. Bessette parla di democrazia deliberativa studiando la Costituzione degli Stati Uniti, specialmente le idee di Madison, e dice che è fatta apposta per far discutere le persone. Chi ha scritto la Costituzione voleva non solo controllare chi è la maggioranza, ma anche migliorare le idee di tutti facendo discutere i rappresentanti del popolo. Voleva creare un modo di pensare insieme, ragionato, per tutta la comunità. Cass R. Sunstein porta avanti questa idea, legandola all’idea di repubblica e dicendo che è diversa dal pluralismo, che vede la politica solo come un modo per mettere insieme gli interessi privati. La democrazia deliberativa, vista così, è un modo di fare politica che cambia le idee delle persone parlando insieme e cercando quello che è meglio per tutti, non solo un modo per contare gli interessi che già esistono.Davvero la “deliberazione” garantisce che si arrivi a un “bene comune” e non sia solo un’altra arena per lo scontro di interessi, magari mascherato da ragionamento?
Il capitolo presenta la democrazia deliberativa come un processo che mira a trasformare le preferenze individuali verso un bene comune, distinguendola dall’aggregazione di interessi. Tuttavia, non approfondisce a sufficienza le complesse dinamiche del dibattito pubblico e i rischi che la deliberazione non superi, ma semplicemente riformuli, gli scontri di potere e gli interessi preesistenti. Per esplorare queste sfide, è utile confrontarsi con le diverse correnti del pensiero politico contemporaneo che analizzano i limiti e le critiche ai modelli deliberativi ideali. Autori come Jürgen Habermas, Chantal Mouffe o Iris Marion Young offrono prospettive cruciali su come il conflitto, il potere e le differenze sociali influenzino o distorcano il processo deliberativo, mettendo in discussione l’idea di un facile raggiungimento di un “bene comune” tramite la sola discussione razionale.2. La politica tra mercato e foro: deliberazione e legittimità
Si possono considerare due modi diversi di vedere la politica democratica. Un modo la paragona a un mercato. Qui, le persone hanno le loro preferenze private già definite, e lo scopo della politica è trovare un accordo che metta insieme questi interessi diversi. L’azione più importante in questa visione è il voto segreto. Un altro modo di vedere la politica, legato all’idea di democrazia basata sulla discussione (deliberativa), la paragona a un luogo di confronto pubblico, un foro. In questo caso, l’obiettivo non è semplicemente raccogliere le preferenze già esistenti, ma piuttosto cambiarle e migliorarle attraverso un dibattito aperto e razionale che miri al bene di tutti. La partecipazione delle persone e la discussione pubblica sono fondamentali in questa visione.Il confronto tra le visioni: Jon Elster
Jon Elster mette a confronto queste due idee di politica. Critica l’idea che le preferenze delle persone siano sempre fisse e perfettamente logiche, notando che in realtà possono cambiare, a volte adattandosi a ciò che si può ottenere o, al contrario, diventando più resistenti. Secondo Elster, la politica intesa come foro pubblico dovrebbe puntare a raggiungere un accordo basato sulla ragione, idealmente condiviso da tutti. Questa idea è influenzata dal concetto di “situazione ideale in cui si discute” proposto da Habermas. Tuttavia, Elster riconosce che ottenere l’accordo di tutti è molto difficile e che quindi è comunque necessario trovare un modo per mettere insieme le diverse preferenze. La discussione pubblica, però, mette dei limiti; rende difficile per le persone esprimere solo i propri interessi egoistici e le spinge a considerare il bene comune. Elster critica anche chi pensa che partecipare alla politica sia un obiettivo in sé, sostenendo invece che i benefici per chi partecipa sono un effetto secondario; la politica deve avere uno scopo pratico e concreto.La legittimità nasce dalla discussione: Bernard Manin
Bernard Manin si concentra su come le decisioni democratiche diventano giuste e accettate (legittime). Sostiene che la legittimità non deriva da una volontà comune già esistente nelle persone, come pensano alcune interpretazioni di Rousseau o Rawls. Deriva invece dal processo stesso di discussione a cui tutti hanno il diritto di prendere parte. La discussione è il modo in cui si formano le opinioni e le decisioni, e questo avviene in situazioni in cui non si hanno tutte le informazioni, c’è incertezza e ci sono conflitti tra desideri e valori diversi. Lo scopo della discussione non è necessariamente arrivare a un accordo totale, ma trovare soluzioni che siano ragionevoli e che si possano giustificare con argomenti validi. La legittimità di una decisione nasce dalla combinazione di questo processo di discussione e del principio della maggioranza. Manin considera la presenza di diverse idee e i conflitti come elementi essenziali e vede la discussione come lo strumento per affrontarli in modo ragionato.Il ruolo della discussione nella sfera pubblica: Jürgen Habermas
Jürgen Habermas, nei suoi lavori più recenti, accetta l’idea di Manin che la legittimità si basa sulla discussione a cui partecipano tutti nello spazio pubblico della politica. La discussione non prende decisioni dirette, ma influenza il potere di chi governa, rendendolo legittimo o meno. La politica è vista come un equilibrio difficile tra la comunicazione basata sulla ragione (la discussione) e le azioni strategiche basate sul conflitto di interessi. In questo contesto, la discussione cerca di definire un interesse generale che non è dato in partenza, ma che emerge dal confronto.Ma se la legittimità democratica dipende dalla discussione pubblica, cosa garantisce che tale discussione non sia semplicemente un campo di battaglia distorto da disuguaglianze di potere e interessi prevaricanti?
Il capitolo presenta la discussione come fondamento della legittimità, ma non approfondisce sufficientemente come le dinamiche di potere e le disuguaglianze socio-economiche nel mondo reale possano compromettere l’ideale di un confronto razionale e aperto. Per comprendere meglio queste sfide, sarebbe utile esplorare le teorie critiche della democrazia, le analisi sociologiche sul potere e la stratificazione sociale, e autori che mettono in discussione la possibilità di una sfera pubblica puramente razionale, evidenziando il ruolo ineliminabile del conflitto e degli interessi.3. La democrazia tra procedura ideale e pratica discorsiva
La democrazia deliberativa è vista come un principio politico fondamentale, che non deriva da altri valori come l’idea di giustizia. Si basa sull’idea di un’associazione di persone che si governano attraverso la discussione pubblica, in cui tutti i membri sono considerati uguali. Questo approccio si differenzia da altre teorie, come quella di giustizia proposta da Rawls, perché propone una procedura ideale di discussione come modello da seguire per le istituzioni democratiche, invece di usarla solo come un esperimento mentale per definire principi teorici. Una procedura di discussione ideale non ha vincoli esterni, si fonda sullo scambio aperto di argomenti e ragioni, e garantisce che tutti i partecipanti siano uguali sia formalmente che nella sostanza. L’obiettivo di questa discussione è raggiungere un accordo che sia motivato dalla ragione. Le decisioni prese sono considerate legittime solo se sono il risultato di questo processo. La discussione pubblica ha il potere di trasformare le opinioni e le preferenze individuali, orientandole verso ciò che è considerato il bene comune, che si costruisce proprio attraverso il confronto e il dibattito. L’autonomia dei cittadini si realizza pienamente partecipando attivamente a questo processo di costruzione collettiva.Un modello pratico: il Deliberative Polling
Per cercare di mettere in pratica questo ideale di democrazia basata sulla discussione, è stato proposto un modello chiamato “Deliberative Polling”. Questo strumento seleziona in modo casuale un gruppo di cittadini, che vengono poi informati in modo approfondito su un argomento e hanno la possibilità di discuterne tra loro. Dopo questo processo, le loro opinioni tendono a diventare più informate e ponderate. Lo scopo principale di questo metodo è mostrare quale sarebbe l’opinione dei cittadini se avessero l’opportunità di riflettere con calma e avere accesso a informazioni complete. Si cerca così di superare la distanza che spesso esiste tra le masse poco informate e gruppi più ristretti di persone considerate più competenti.Legami con altre teorie e il significato dei risultati
L’idea alla base del Deliberative Polling si collega al concetto di “comprensione illuminata” proposto da Robert Dahl, che immaginava un “minipopulus”, cioè un piccolo gruppo che rappresentasse l’intera popolazione e che potesse discutere in modo approfondito. Si lega anche alla visione di Bruce Ackerman, che distingue due tipi di momenti nella vita politica: rari periodi di intensa attività politica, spesso legati a cambiamenti importanti, e i momenti normali, caratterizzati da un certo disinteresse dei cittadini per la vita pubblica. Il Deliberative Polling cerca di creare artificialmente questi momenti episodici di discussione “alta”, offrendo ai cittadini l’occasione di superare l’apatia o la mancanza di informazioni che caratterizzano la politica di tutti i giorni. I risultati che emergono da queste discussioni non rappresentano l’opinione pubblica così come è in un dato momento, ma indicano piuttosto cosa potrebbero pensare i cittadini se fossero pienamente informati e attivamente coinvolti nel dibattito.Ma quanto è realistica l’idea che la “chiusa idraulica” trasformi il “potere comunicativo” in decisioni politiche legittime, ignorando le dinamiche di potere e disinformazione che dominano la sfera pubblica reale?
Il capitolo presenta un modello affascinante di come il discorso pubblico dovrebbe influenzare le decisioni politiche, ma lascia aperte questioni cruciali sulla sua effettiva applicabilità e vulnerabilità. La distinzione netta tra potere comunicativo e potere amministrativo, e la fiducia nella capacità del dibattito pubblico di generare legittimità razionale, sembrano non considerare a sufficienza come la sfera pubblica sia costantemente plasmata da interessi economici, manipolazioni mediatiche e profonde disuguaglianze sociali. Per approfondire queste criticità, è fondamentale esplorare la sociologia politica, gli studi sui media e la teoria critica. Autori come Bourdieu, Foucault, o studiosi che analizzano le patologie della comunicazione contemporanea, possono offrire strumenti per comprendere le forze che distorcono il processo deliberativo descritto.6. La Democrazia tra Ideale e Pratica del Discorso
La democrazia deliberativa offre un modo per capire come funziona la democrazia e come potrebbe essere migliorata. Ci sono due modi principali di vederla. Il primo la considera un ideale politico da raggiungere, suggerendo di creare luoghi specifici per discutere o di cambiare l’intero sistema di governo per avvicinarsi a questo ideale. Lo scopo è fare in modo che i cittadini partecipino di più e decidano autonomamente attraverso il confronto e la discussione.La democrazia deliberativa come teoria
Il secondo modo vede la democrazia deliberativa come una teoria che serve a capire e spiegare le democrazie che esistono già. Questa visione analizza come la discussione e la comunicazione siano già presenti nelle democrazie reali. Studia come si formano le idee e le decisioni politiche e come questo processo aiuta a rendere le decisioni accettate e legittime. Questo punto di vista si concentra su quanto sia buona la discussione pubblica e sul suo ruolo all’interno del sistema democratico nel suo complesso.Affrontare le sfide attuali
Questa seconda idea offre una risposta alle difficoltà che la democrazia affronta oggi, come la presenza di tante idee diverse e la complessità della società. Si differenzia da visioni che rifiutano il confronto e la mediazione, come il populismo, che si basa sull’idea di un popolo unito contro le élite, e la tecnocrazia, che pensa che i problemi si risolvano solo con soluzioni tecniche senza bisogno di discussione pubblica.Legittimità attraverso il dialogo
Secondo questa prospettiva, le decisioni democratiche sono legittime non perché imposte dalla forza o trovate con soluzioni tecniche, ma perché nascono da un confronto aperto e inclusivo. La possibilità di un dialogo pubblico dove tutti possono partecipare e le idee vengono discusse in modo razionale è fondamentale. La discussione pubblica è vista come essenziale per affrontare i problemi complicati e mantenere unite società con molte differenze al loro interno.Democrazia rappresentativa e deliberazione
Questo modo di vedere la democrazia deliberativa non è solo un’idea astratta, ma si basa su esperienze concrete e sulle tensioni che esistono tra ciò che è giusto o valido e i fatti reali. La democrazia in cui scegliamo i nostri rappresentanti è per sua natura legata alla deliberazione. La sua efficacia e la sua qualità dipendono da quanto è ricco e aperto il dibattito pubblico e dalla capacità di creare un legame e una mediazione efficace tra i cittadini e le istituzioni che li rappresentano.Come può il “dialogo pubblico dove tutti possono partecipare e le idee vengono discusse in modo razionale” garantire la legittimità democratica quando la realtà è fatta di disuguaglianze di potere, interessi contrapposti e disaccordi irriducibili che vanno oltre la mera “discussione razionale”?
Il capitolo descrive la legittimità democratica come derivante da un confronto aperto e razionale, ma non affronta a sufficienza le sfide concrete che rendono questo ideale difficile da realizzare. La teoria politica contemporanea dibatte intensamente su come le dinamiche di potere, le disuguaglianze sociali ed economiche, e la natura stessa del conflitto politico influenzino o distorcano i processi deliberativi. Per approfondire queste criticità, sarebbe utile esplorare le opere di autori che hanno analizzato il rapporto tra potere e discorso, come Foucault, o coloro che hanno studiato i limiti della razionalità in politica e i conflitti di valore, come Berlin o Mouffe.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]