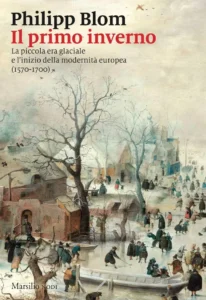Contenuti del libro
Informazioni
Un viaggio italiano” di Philipp Blom non è solo un libro, è un’indagine affascinante che parte da un violino antico per svelare storie dimenticate. Immagina di tenere tra le mani questo strumento e chiederti: chi l’ha fatto? Il libro ti porta in un viaggio storico, seguendo le tracce di un possibile liutaio tedesco, forse dalla famosa scuola di liuteria di Füssen in Baviera, che come tanti artigiani del Settecento, è emigrato in Italia, magari a Venezia. Scopri la vita difficile di questi liutai tedeschi emigrati, il loro viaggio attraverso le Alpi, e come il loro stile si sia fuso con la tradizione italiana, influenzata da maestri come Jacob Stainer o la scuola veneziana di Matteo Goffriller. È una vera detective story storica che usa l’analisi dello strumento, la dendrocronologia e la ricerca d’archivio per ricostruire non solo l’origine del violino, ma anche la vita di un uomo comune, un artigiano storico in una bottega veneziana. Il libro ti fa riflettere sulla storia della musica, sulla solitudine dell’emigrante e su come gli oggetti possano essere ponti verso il passato, portando con sé un “accento straniero” che racconta di viaggi, culture che si incontrano e vite vissute.Riassunto Breve
Un violino fatto all’inizio del Settecento mostra caratteristiche miste, con tecniche che sembrano venire dalla Baviera, forse da Füssen, e una forma e vernice che ricordano la scuola italiana, come quella degli Amati. Füssen, ai piedi delle Alpi bavaresi, era un centro importante per fare strumenti musicali, grazie al legname e alle rotte commerciali verso l’Italia, specialmente Venezia. La povertà spingeva molti giovani a emigrare, e fare strumenti era un modo per trovare lavoro. Gli artigiani di Füssen producevano pezzi semilavorati in casa e li portavano in Italia per montarli, un sistema che li aiutò a vendere in tutta Europa. Eventi come la Guerra dei trent’anni e la peste nel Seicento causarono un declino a Füssen, portando molti liutai a spostarsi, ma la tradizione e l’emigrazione verso l’Italia continuarono, mescolando stili tedeschi e italiani. Molti giovani liutai emigrarono in Italia tra il 1650 e il 1680, spesso molto giovani e seguendo rotte già usate da parenti o altri artigiani. Questi viaggi erano pericolosi, attraversando le Alpi viste come luoghi spaventosi pieni di pericoli naturali e umani. Arrivati in Italia, cercavano botteghe dove magari si parlava la loro lingua, appoggiandosi alle comunità di emigrati. Trovare informazioni precise su questi artigiani comuni negli archivi è difficile. L’analisi di un violino con influenze tedesche porta a Milano o Venezia, centri storici per la liuteria. Gli esperti guardano lo stile, la costruzione e i materiali per capire l’origine, non il suono. Le attribuzioni sono complicate, con ipotesi che cambiano tra diversi maestri o botteghe, come Matteo Goffriller a Venezia o Antony Posch a Vienna. Anche l’analisi scientifica del legno, la dendrocronologia, a volte non riesce a dare risposte certe, indicando solo un periodo di costruzione, come il 1727-1732 per il violino in questione, probabilmente a Venezia. Venezia, nonostante un certo declino, era piena di musica e artigiani, molti dei quali immigrati tedeschi che vivevano e lavoravano insieme. Le botteghe, come quella di Goffriller, erano organizzate con più persone che collaboravano, e spesso gli strumenti non avevano etichette, rendendo difficile capire chi li avesse fatti. La vita di questi artigiani si intravede solo da pochi documenti d’archivio. Fare un violino richiedeva materiali da tutto il mondo, come legni dalle Alpi e dai Balcani, e resine o decorazioni da luoghi lontani, mostrando come questi oggetti fossero legati a scambi globali. Gli artigiani tedeschi in Italia erano a volte visti con sospetto, anche dall’Inquisizione, specialmente se venivano da zone influenzate dalla Riforma. Nonostante le difficoltà e l’incertezza su chi abbia costruito esattamente un certo violino, l’oggetto stesso mostra un “accento straniero”, una mescolanza di stili che racconta la storia del suo creatore emigrato. I luoghi a Venezia dove vivevano e lavoravano i liutai tedeschi, come Calle dei Stagneri o l’area vicino alla chiesa di Santi Apostoli, testimoniano la loro presenza. La ricerca dell’origine di uno strumento antico mostra quanto sia difficile recuperare il passato e l’identità di persone comuni. Anche se non si sa chi fosse esattamente il liutaio, l’oggetto crea un legame con lui attraverso la sua arte e il suo stile. Questo violino è come una “passacaglia”, una musica che continua attraverso i secoli, portando con sé le tracce di un viaggio e di una vita, anche se la verità completa rimane nascosta.Riassunto Lungo
1. Füssen e l’Arte del Legno Migrante
Un violino datato inizio Settecento, fabbricato in Italia da un liutaio tedesco, presenta caratteristiche che indicano una formazione in Baviera, specificamente nell’Algovia, forse nella città di Füssen. Dettagli come la forma delle punte, la linea dei bordi e la posizione delle effe suggeriscono la mano di un artigiano bavarese. Al contrario, la forma e la bombatura della tavola armonica, insieme alla vernice, seguono la scuola italiana, riflettendo lo stile della famiglia Amati. Füssen, situata ai piedi delle Alpi bavaresi, fu per secoli un centro di grande importanza per la fabbricazione di strumenti a corda. La sua posizione garantiva un facile accesso a legname pregiato proveniente dalle foreste alpine. Inoltre, si trovava su importanti rotte commerciali che conducevano verso l’Italia, in particolare verso Venezia. La povertà agricola della regione spingeva molti giovani a cercare lavoro altrove, e la liuteria offriva un’opportunità preziosa.L’Organizzazione del Mestiere
Il mestiere era organizzato in un modo che anticipava l’organizzazione industriale moderna. Si producevano parti semilavorate, come le doghe per i liuti, spesso realizzate in casa durante i mesi invernali. Queste parti venivano poi trasportate in grandi quantità verso centri dove venivano assemblate, soprattutto in Italia. Questo sistema permise ai liutai di Füssen di dominare il mercato europeo degli strumenti per un lungo periodo. Figure come Caspar Tieffenbrucker ebbero un ruolo chiave in questa espansione. Essi stabilirono reti commerciali in città importanti come Lione e Venezia.Sfide e Migrazione
La Guerra dei trent’anni e le epidemie di peste nel diciassettesimo secolo colpirono duramente la città di Füssen. Questi eventi causarono un forte calo demografico e gravi difficoltà economiche. Molti liutai morirono o furono costretti a emigrare in cerca di condizioni di vita migliori. Nonostante queste sfide significative, la tradizione della liuteria continuò. Anche l’emigrazione verso l’Italia non si fermò. Questa migrazione costante portò tecniche e stili tedeschi a mescolarsi con le tradizioni locali, influenzando in modo duraturo la fabbricazione di strumenti a corda in tutta Europa.Ma davvero la produzione di parti semilavorate a Füssen, destinate all’assemblaggio altrove, può essere equiparata all’organizzazione industriale moderna, e fu sufficiente a garantire un effettivo “dominio” del mercato europeo?
Il capitolo presenta un quadro affascinante della liuteria e delle migrazioni. Tuttavia, l’enfasi sul “dominio” di Füssen e il paragone con l’industria moderna rischiano di semplificare eccessivamente una realtà complessa. Per valutare la reale portata del fenomeno descritto nel capitolo, è indispensabile approfondire la storia economica dell’artigianato in età pre-industriale, studiando le diverse forme di organizzazione del lavoro e del commercio che caratterizzavano l’Europa dell’epoca. È altresì cruciale esaminare in modo critico le fonti che attestano l’influenza e la quota di mercato dei liutai di Füssen rispetto ad altri centri di eccellenza, in particolare quelli italiani come Cremona o Venezia, che ebbero un ruolo centrale e duraturo nella storia della liuteria. Approfondimenti sulla storia sociale e economica dell’arte e dei mestieri, magari leggendo autori come Peter Burke o Fernand Braudel, potrebbero fornire il contesto necessario per un’analisi più rigorosa.2. L’Eredità del Liutaio Migrante
La città di Füssen era un centro importante per la costruzione di strumenti musicali. Dopo la Guerra dei trent’anni (1618-1648) e la peste del 1630, la città subì un forte declino. La popolazione diminuì drasticamente. Il commercio di legname pregiato divenne difficile perché le risorse locali si esaurirono. Nuove rotte commerciali evitarono Venezia, che prima era un punto di arrivo cruciale per i prodotti di Füssen. Questo portò la città a diventare molto più povera, con pochi artigiani rimasti. Nello stesso periodo, il modo di fare musica cambiò. Il liuto, pur essendo uno strumento capace di suonare più note contemporaneamente, aveva un volume limitato. Nei teatri d’opera e nei concerti pubblici, dove serviva più suono, gli strumenti ad arco come il violino, la viola e il violoncello presero il suo posto. Questi strumenti vennero standardizzati (quattro corde accordate per quinte), il che li rese più facili da usare per i musicisti in viaggio e favorì la diffusione delle composizioni.
L’Emigrazione dei Liutai Molti giovani artigiani di Füssen, nati tra il 1650 e il 1680, decisero di lasciare la loro città. Cercarono nuove opportunità in Italia, dove il mercato per gli strumenti ad arco era in crescita. Spesso partivano molto giovani, a volte anche a soli dodici anni, spinti dalla necessità economica. Seguivano percorsi già battuti, trovando spesso accoglienza nelle botteghe di parenti o di altri artigiani tedeschi che si erano già stabiliti in Italia. Questi liutai portavano con sé le abilità e le tecniche imparate nella loro terra d’origine, mescolandole con gli stili e le tradizioni italiane. Questo scambio culturale fu fondamentale per lo sviluppo della liuteria in Italia.
La Nascita di un Nuovo Stile Grazie a questi scambi, emersero strumenti che mostravano caratteristiche di diverse scuole. Ad esempio, un violino può presentare elementi tipici sia della scuola tedesca, come quella di Jacob Stainer, sia di quella italiana, come gli Amati. Si notano la qualità del legno e una vernice ambrata che ricorda quella usata in Italia. Dettagli stilistici, come la forma allungata e le “effe” dritte, sono di origine tedesca, mentre la bombatura bassa (la curvatura del piano armonico) è tipicamente italiana. Questo mix suggerisce che lo strumento sia stato costruito da un artigiano molto capace, probabilmente formatosi in area tedesca, forse a Füssen o in Tirolo, che poi si è trasferito e ha lavorato in Italia. Questo tipo di violino rappresenta una nuova forma che si è sviluppata a sud delle Alpi grazie a questi artigiani migranti.
Il Violino e la Percezione Sociale La vita di questi artigiani in viaggio si riflette anche nella percezione sociale del loro tempo. L’immagine della “Danza Macabra” di Füssen, dove uno scheletro suona il violino, è emblematica. Il violino, uno strumento facile da trasportare, era spesso associato ai musicisti itineranti e ai girovaghi. Queste figure erano a volte viste con sospetto, quasi come portatori di disordine o pericolo. La danza macabra stessa, insieme alla forma musicale della passacaglia, simboleggiano il movimento continuo, il viaggio senza fine e l’inevitabilità del destino. Questi temi si legano profondamente all’esistenza errante degli artigiani che lasciavano la loro terra per cercare fortuna altrove. Il violino, quindi, diventa più di un semplice strumento; incarna la storia di questi spostamenti umani e l’eredità culturale che è stata tramandata di generazione in generazione.
Ma siamo sicuri che il declino di una singola città e il cambio di uno strumento musicale spieghino da soli la nascita di un intero nuovo stile di liuteria in Italia?
Il capitolo presenta un quadro affascinante del legame tra crisi economica, migrazione e sviluppo artistico, ma rischia di semplificare eccessivamente un fenomeno complesso. L’emigrazione di artigiani e lo scambio di tecniche tra diverse aree geografiche erano dinamiche comuni nell’Europa del XVII e XVIII secolo, non limitate ai liutai di Füssen diretti in Italia. Per una comprensione più completa, sarebbe fondamentale approfondire la storia economica e sociale dell’epoca, studiando i flussi migratori degli artigiani in un contesto più ampio. È inoltre cruciale esplorare la storia della liuteria non solo in Baviera e in Italia, ma anche in altri importanti centri europei coevi, per capire se lo sviluppo di “stili ibridi” fosse un fenomeno isolato o parte di una tendenza più generale di contaminazione culturale. Approfondire la storia della musica e dell’evoluzione degli strumenti può ulteriormente contestualizzare il ruolo del violino e degli strumenti ad arco in questo periodo di cambiamento.Ma le conclusioni del capitolo resistono al confronto con la realtà complessa?
Il capitolo espone alcune tesi, ma non chiarisce adeguatamente in quali specifici contesti o condizioni esse trovino piena applicazione, né considera possibili eccezioni significative. Per valutare la reale portata e i limiti di queste argomentazioni, sarebbe opportuno confrontarle con studi empirici o approfondire discipline come la sociologia applicata o la storia economica comparata. Autori come Max Weber o Pierre Bourdieu offrono prospettive fondamentali sull’importanza del contesto nell’analisi sociale ed economica.3. L’Accento Straniero dello Strumento
La ricerca dell’origine di un violino si basa sull’analisi stilistica e sul parere di esperti. Una prima ipotesi collega lo strumento a una bottega veneziana. Si pensa in particolare a Matteo Goffriller, considerando le somiglianze stilistiche, il periodo storico e l’origine bavarese del presunto costruttore, “Hanns”. Goffriller, infatti, era originario della zona di Füssen, ma lavorava a Venezia e manteneva legami con la sua terra natale. Tuttavia, attribuire il violino a Goffriller con certezza è complicato. Nessuno dei suoi strumenti conosciuti possiede tutte le caratteristiche del violino in questione, anche se singole peculiarità si ritrovano in diversi esemplari usciti dalla sua bottega.Altre ipotesi di attribuzione
Consultare altri esperti porta a considerare ipotesi differenti. Un esperto suggerisce che il violino possa essere opera di Antony Posch. Posch era un liutaio di Füssen attivo a Vienna intorno al 1700. Questa attribuzione si basa sulla somiglianza dello strumento con una viola attribuita a lui. Un altro esperto, dopo aver confrontato il violino con strumenti di Goffriller, esclude l’origine veneziana legata a quest’ultimo. Conferma invece la teoria che propende per Posch, notando nello strumento uno stile più affine alla scuola tedesca del Sud.La ricerca scientifica
Per cercare una conferma più oggettiva, si ricorre alla dendrocronologia. Questa tecnica scientifica permette di datare il legno analizzando gli anelli di crescita. Un esame di questo tipo era già stato tentato in passato senza successo. Viene quindi ripetuto da uno specialista per avere un risultato più preciso. Purtroppo, anche questo secondo tentativo non riesce a fornire una datazione certa. Il legno del violino presenta un profilo di crescita anomalo. Inoltre, i dati disponibili per il confronto non sono sufficienti per un’attribuzione definitiva. Lo specialista, pur non potendo dare una certezza scientifica, suggerisce come ipotesi personale un’origine veneziana, forse legata a Michele Deconet.La figura di Michele Deconet
La figura di Michele Deconet, attivo a Venezia nella seconda metà del Settecento, è piuttosto discussa tra gli studiosi. Un’indagine storica suggerisce che Deconet potrebbe non aver costruito strumenti direttamente. Si ipotizza invece che acquistasse violini da altri liutai veneziani per poi rivenderli con la sua etichetta. In questo senso, avrebbe agito forse come un “ciarlatano”, inteso nel senso storico del termine come un venditore itinerante. Sebbene il violino in esame mostri alcune somiglianze con strumenti attribuiti a Deconet, il periodo di attività di quest’ultimo è troppo tardo rispetto alla probabile datazione dello strumento.L’idea dell’ “accento straniero”
Nonostante l’incertezza sull’identità precisa del costruttore, nella fattura del violino si percepisce un elemento distintivo. Questo elemento è stato definito un “accento straniero”. Si tratta di una fusione di elementi stilistici tipici della liuteria tedesca e di quella italiana. Questo “accento” artistico riflette probabilmente l’esperienza del costruttore “Hanns” come immigrato tedesco in Italia. La vita degli immigrati nel Settecento era complessa. Comprendeva sfide legate all’integrazione sociale, all’apprendimento di una nuova lingua e alla gestione della vita personale e affettiva in un paese diverso dal proprio.I segni della fusione culturale
L'”accento” artistico si manifesta in dettagli specifici della lavorazione dello strumento. Si nota, ad esempio, nella forma delle punte, nel disegno delle effe e nell’intaglio del riccio. Questi particolari mostrano un amalgama tra la tradizione artigianale del paese d’origine del liutaio e quella del paese in cui si è stabilito. Questo mix crea uno stile personale e unico. È uno stile che porta i segni visibili di un percorso migratorio e di un’identità costruita tra due culture. Lo strumento conserva l’impronta di questa fusione culturale e tecnica, anche se il nome esatto del suo creatore rimane avvolto nel mistero.Ma davvero un vecchio violino basta a colmare il vuoto esistenziale?
Il capitolo propone un legame emotivo molto forte tra l’oggetto antico e un presunto bisogno di riempire un “senso di vuoto esistenziale”. Questa è un’affermazione potente, che merita di essere indagata con maggiore rigore. Per comprendere meglio la complessa relazione tra gli oggetti materiali, la memoria, il significato personale e la ricerca di stabilità, si potrebbero esplorare discipline come la psicologia dell’attaccamento o la sociologia della cultura materiale, e confrontarsi con autori che hanno riflettuto sulla fenomenologia degli oggetti e sul loro ruolo nella costruzione del sé e del significato.8. La Passacaglia del Passato
La ricerca della verità storica sull’origine di un violino mostra quanto sia difficile recuperare il passato. L’identità del liutaio che ha costruito lo strumento, forse un emigrante veneziano di nome Zuanne o Hanns, rimane incerta. Nonostante le indagini e le perizie suggeriscano una data e un’origine precise, come Venezia intorno al 1730 e un artigiano proveniente dall’Algovia, esistono ipotesi diverse sull’epoca, l’autore e la provenienza. La documentazione disponibile è molto scarsa e non basta a illuminare completamente il passato. È come cercare di colmare una “voragine nera dell’oblio” che sembra inghiottire le esperienze vissute. Anche la memoria personale può essere poco affidabile.Le sfide della ricerca
Cercare di ritrovare un luogo d’infanzia basato solo sulla memoria, per esempio, può portare a un vicolo cieco, dimostrando quanto i ricordi possano essere inaffidabili. Allo stesso modo, seguire le tracce della vita di persone comuni nel passato è molto difficile. Nel Settecento a Venezia, le pratiche di sepoltura per le classi popolari spesso non prevedevano tombe individuali. Questo rende quasi impossibile rintracciare la fine della vita di un artigiano come il liutaio del violino. Tutti questi aspetti sottolineano quanto sia arduo ricostruire con certezza il passato.Un legame oltre i fatti
Nonostante tutta questa incertezza storica, un legame con chi ha creato lo strumento esiste comunque. Questo legame non si basa su fatti certi o documenti ritrovati. Nasce invece dalla passione per l’arte e dallo stile del liutaio, che si possono percepire direttamente attraverso l’oggetto. È come se il violino stesso parlasse, raccontando la storia del suo creatore al di là delle prove concrete. Il violino diventa così un ponte che collega epoche diverse. È una sorta di “passacaglia” che risuona attraverso i secoli, portando con sé l’eco del suo creatore.La vita come passacaglia
La vita stessa può essere vista come una passacaglia. È fatta di improvvisazioni che si sviluppano a partire da un tema di base, dato dalle nostre predisposizioni naturali e dalle esperienze che viviamo. Questa visione è diversa dall’idea di una vita intesa come un percorso eroico che porta a una soluzione definitiva o a una verità unica. Nella passacaglia della vita, la verità assoluta può rimanere sfuggente e difficile da afferrare. Tuttavia, il processo stesso della ricerca e l’impegno costante di ogni giorno portano a scoperte di grande valore. Si possono trovare la libertà di esplorare e la bellezza nelle diverse possibilità. Il violino, con le sue origini incerte e le diverse storie possibili, mantiene un equilibrio tra queste narrazioni. Non offre risposte semplici o definitive, ma stimola la ricerca continua. Lascia spazio al mistero e alimenta la passione per la scoperta.Ma se la ricerca storica fatica a trovare prove concrete sull’origine del violino, come si può affermare che l’oggetto stesso “parli” e crei un legame “al di là dei fatti”?
Il capitolo evidenzia con efficacia le difficoltà intrinseche della ricerca storica, specialmente quando la documentazione è scarsa e si tratta di figure non eminenti. Tuttavia, il passaggio dall’incertezza fattuale a un legame percepito attraverso “la passione per l’arte e lo stile” dell’oggetto solleva interrogativi metodologici. Come si distingue questa percezione da una proiezione soggettiva? Quali criteri si usano per interpretare lo “stile” in modo che riveli qualcosa di verificabile o almeno plausibile sul creatore, al di là della mera ammirazione estetica? Per approfondire come gli studiosi affrontano la conoscenza del passato a partire dagli oggetti e dalle tracce frammentarie, e quali sono i limiti di tale interpretazione, può essere utile esplorare le discipline della storia materiale e le metodologie della storiografia, magari leggendo autori come Carlo Ginzburg che hanno riflettuto sull’uso degli indizi.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]