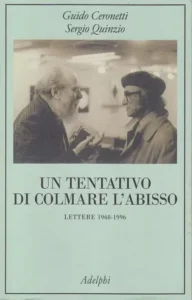1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Un tentativo di colmare l’abisso. Lettere 1968-1996” di Sergio Quinzio è un libro che raccoglie il lungo e intenso carteggio tra l’autore stesso e un amico, Guido. Queste lettere sono il cuore di un dialogo intellettuale profondo che dura quasi trent’anni, dal 1968 al 1996. I due amici si confrontano su temi enormi, partendo spesso da una crisi spirituale personale e da un’interpretazione biblica radicale, specie dell’Antico Testamento, vista quasi come testimonianza della sofferenza e dell’impotenza divina. Discutono di fede, del rapporto tra sacro e profano, di come leggere la Bibbia, della disperazione di fronte al mondo moderno e alla sua violenza, e della ricerca di speranza o salvezza, che sia nella religione, nell’arte o nell’amicizia stessa. Nonostante le differenze di vedute, a volte molto marcate, emerge un legame forte, un’amicizia intellettuale che li sostiene mentre affrontano le difficoltà della vita, l’invecchiamento e un senso condiviso di disillusione verso il mondo. È un confronto onesto e appassionato sulle grandi domande dell’esistenza, filtrato attraverso le vicende personali e la storia di quegli anni.Riassunto Breve
Una corrispondenza intellettuale intensa esplora il fallimento di un percorso spirituale personale, visto come un abisso scavato da una ricerca solitaria della Bibbia. La Scrittura è interpretata non come esaltazione divina, ma come testimonianza della miseria e impotenza di Dio nella storia. Si analizza la figura del filologo biblico, il cui lavoro contrasta con l’interpretazione cristiana tradizionale che vede l’Antico Testamento come prefigurazione di Cristo, portando a distanza dai fondamenti del Nuovo Testamento. L’amicizia tra i protagonisti, pur senza affinità ideologiche, trova un punto di incontro nella boxe, sport violento che illumina la tragicità dell’esistenza, paragonata alla lotta di Israele con un Dio senza volto. Il dialogo affronta il tempo messianico e le catastrofi storiche, percependo un’epoca apocalittica. La teologia della resurrezione è discussa come dogma assoluto o come interrogativo di fronte all’esperienza umana. Emerge l’importanza della sofferenza nel mondo, considerata più rilevante di concetti come colpa, giustizia, verità e bellezza, riconoscendo un punto di incontro nella compassione per l’uomo sofferente, un invito universale a piangere per la condizione umana. La corrispondenza approfondisce divergenze e affinità su cristianesimo, Gesù, speranza messianica e natura del Regno. Si esplora la negazione della storia, preferendo una negazione anti-storica che implica un giudizio attivo. Il dialogo si estende alla traduzione della Bibbia, al rapporto antico/moderno e alla definizione del sacro. Si confrontano concezioni del sacro: una che lo vede separato e inviolabile, appartenente solo a Dio, e un’altra più inclusiva che lo trova anche nel profano. Questa divergenza sul sacro genera disaccordo ma alimenta il dialogo, arricchito da riflessioni personali su malattia, morte e ricerca di significato. Il dibattito centrale verte sull’interpretazione di testi come Ecclesiaste e Giobbe, interrogandosi sulla lettura sacra rispetto a quella profana. Si argomenta che un testo sacro vada letto secondo criteri intrinseci al suo orizzonte sacro, considerando ogni altra lettura profana. Si contesta l’isolamento di Qohelet come uomo qualunque, poiché la sua sacralità deriva dalla Bibbia. L’opposizione tra Qohelet e l’apocalittica è vista come reciproco sbranamento da una minima differenza interna alla tradizione. Si discute sulla parola poetica e sacra e su una possibile gerarchia tra le parole. La questione centrale rimane la diversa percezione del sacro: orizzonte intrinseco o costruzione moderna per riempire l’assenza di significato. Emerge la difficoltà di conciliare fede e ragione, sacro e profano, riconoscendo un abisso incolmabile. Le lettere delineano discussioni teologiche sull’interpretazione biblica, con preferenza per l’Antico Testamento e una visione tragica della fede. Si esplorano temi mistici e religiosi, come l’identificazione di Gesù e Maria nella gnosi e il ruolo di Sofia, confrontando interpretazioni mistiche e storiche. Si percepisce un declino e una superficialità nella letteratura e nella vita intellettuale contemporanea. Preoccupazioni per salute, invecchiamento e difficoltà quotidiane emergono costantemente. Si confrontano diverse prospettive religiose e spirituali. Il ruolo di sofferenza, disperazione e speranza nella fede è ricorrente. Nonostante le divergenze, traspare una solida amicizia e rispetto intellettuale, alimentato da un comune senso di disillusione verso il mondo moderno. La corrispondenza è un dialogo continuo su temi esistenziali e spirituali, sullo sfondo di una realtà percepita come problematica e decadente. Si delinea una profonda divergenza sulla natura della salvezza e della disperazione. Una prospettiva si concentra su una “salvezza povera” radicata nella debolezza e sofferenza della carne, criticando un cristianesimo spiritualizzato e identificando la fede con la croce e la sofferenza gratuita. In contrapposizione, emerge una concezione che valorizza arte e poesia come vie di salvezza, capaci di trasformare la disperazione (“boue” in “or”). Questa prospettiva critica la rigida opposizione tra arte e fede, suggerendo che la poesia possa accogliere e sublimare la disperazione, offrendo consolazione e significato. Il dialogo esplora la tensione tra religione (domanda radicale di salvezza) e arte (risposta che media e trasforma l’orrore), interrogandosi se l’arte possa diventare salvezza, un’oasi che protegge dalla consapevolezza della mancanza di salvezza definitiva, rischiando di divenire idolo. Entrambe le posizioni si confrontano con un mondo violento e minaccioso, segnato da conflitti e paura di catastrofi, sfondo alla riflessione su fede, disperazione e ricerca di significato, interrogando il ruolo del cristianesimo contemporaneo. La discussione tocca pena di morte, violenza, responsabilità morale in relazione alla condizione umana e alla ricerca di redenzione. Le lettere delineano un dialogo prolungato, segnato da inquietudini condivise su invecchiamento, salute precaria e condizione del mondo. Emergono difficoltà fisiche e disillusione crescente verso la società. Le conversazioni toccano prospettive divergenti sulla fede, tra visione cristiana tradizionale e comprensione più complessa, talvolta gnostica. Arte e letteratura sono risposte essenziali alla sofferenza, sebbene il loro valore sia discusso. Vicissitudini personali, preoccupazioni familiari e sfide professionali si intrecciano. L’atto di scrivere diviene centrale, riflettendo l’esigenza di esprimere disperazione e ricerca di significato in un mondo percepito caotico e privo di valori spirituali. Nonostante le divergenze e un pessimismo di fondo, un legame profondo di amicizia e rispetto reciproco permane, alimentato dal riconoscimento condiviso degli orrori del mondo e dalle personali battaglie contro lo sconforto. La corrispondenza è testimonianza della persistente ricerca di senso e consolazione di fronte alle avversità. La corrispondenza tra Guido e Sergio si configura come un dialogo intellettuale e personale di lunga data. Emergono riflessioni su figure letterarie e teologiche come Bloy, analizzato nel contesto del rapporto tra ebraismo e cristianesimo, evidenziando un approccio critico all’antisemitismo. Si manifesta interesse per la politica italiana contemporanea, con giudizi sulla cultura cattolica e le dinamiche politiche. La salute diviene tema centrale, in particolare la malattia di Michèle, introducendo preoccupazione e fragilità. Le difficoltà legate all’età avanzata e alla malattia si intrecciano con riflessioni sulla fatica dell’esistenza e la perdita di energie. Il progetto di archiviare le lettere a Lugano solleva questioni sulla conservazione della memoria e sul valore dello scambio epistolare. Nonostante divergenze e difficoltà, il carteggio testimonia un legame di amicizia duraturo, caratterizzato da reciproco sostegno intellettuale e affettivo di fronte alle sfide della vita e al trascorrere del tempo. La discussione sulla conservazione delle lettere sottolinea l’importanza attribuita alla relazione e il desiderio di preservarne la testimonianza.Riassunto Lungo
1. Abissi e Vertici del Sacro
Un percorso spirituale fallito
Si racconta di uno scambio di lettere molto intenso tra persone colte. Al centro di queste lettere c’è il racconto di un percorso spirituale personale che non ha avuto successo. Questo fallimento è descritto come un baratro profondo, nato dalla ricerca solitaria e radicale di un uomo che studiava la Bibbia. La Bibbia, in questo contesto, non è vista come un libro che celebra Dio, ma piuttosto come una testimonianza della debolezza e dell’impotenza di Dio nella storia degli uomini.La figura del filologo biblico
Viene analizzato il ruolo di un esperto di Bibbia, un filologo. Questo studioso si impegna per correggere quelli che considera gli errori presenti nella parola divina. Questo modo di vedere la Bibbia è diverso dall’interpretazione tradizionale cristiana, che considera l’Antico Testamento come un’anticipazione della venuta di Cristo. Lo studio approfondito della Bibbia porta questo filologo a sentirsi lontano dalle basi del Nuovo Testamento.L’amicizia e la violenza
Tra questi amici intellettuali non c’è grande affinità di pensiero, ma trovano un punto di interesse comune nella boxe. La boxe, uno sport violento, diventa un simbolo della tragicità della vita. La violenza del pugilato viene paragonata alla lotta continua del popolo di Israele con un Dio misterioso, richiamando immagini bibliche di dolore e sacrificio.Tempo messianico e resurrezione
Nelle lettere si parla anche del tempo messianico, cioè del periodo in cui si aspetta l’arrivo del Messia, e delle grandi tragedie della storia. Si trova un accordo nel vedere il periodo storico in cui vivono come un’epoca segnata da eventi terribili, quasi apocalittici. Un altro argomento di discussione è la teologia della resurrezione. Uno dei due la considera un dogma fondamentale e una speranza di salvezza concreta, mentre l’altro si interroga sul significato di questa credenza di fronte alle sofferenze umane.La sofferenza umana
Si riflette molto sulla sofferenza nel mondo, considerandola più importante di concetti come la colpa, la giustizia, la verità e la bellezza. Si trova un punto di accordo nella compassione per l’uomo che soffre, un invito universale a piangere per la condizione umana. Tuttavia, si riconosce anche che il dolore non deve essere l’unico scopo della vita.Dibattito sul cristianesimo e sul sacro
La corrispondenza continua con molte lettere che approfondiscono le differenze e le somiglianze tra i due. Si discute del cristianesimo, del ruolo di Gesù, della speranza messianica e della natura del Regno dei cieli. Si analizza anche il rifiuto della storia, distinguendo tra un rifiuto che ignora la storia e un rifiuto che la combatte attivamente. Quest’ultimo tipo di rifiuto è preferito perché implica un giudizio attivo sulla storia stessa. Il dialogo si allarga poi alla traduzione della Bibbia, al rapporto tra passato e presente, e alla definizione di ciò che è sacro. Si confrontano diverse idee di sacro: una che lo vede come qualcosa di separato e intoccabile, appartenente solo a Dio, e un’altra più aperta che lo riconosce in diverse forme, anche non religiose. Questa diversa comprensione del sacro crea un disaccordo di fondo, ma allo stesso tempo alimenta un dialogo continuo e stimolante. Questo scambio di idee si arricchisce anche di riflessioni personali sulla malattia, sulla morte e sulla ricerca di un significato nella vita.Ma è davvero così sterile questo confronto sul sacro?
Il capitolo sembra presentare un dibattito sul sacro che si conclude con un disaccordo di fondo. Tuttavia, un disaccordo non implica necessariamente sterilità. Per capire se questo confronto è realmente improduttivo, sarebbe utile esplorare più a fondo le diverse concezioni del sacro. Approfondire autori come Durkheim o Eliade, che hanno studiato il sacro da un punto di vista sociologico e antropologico, potrebbe offrire una prospettiva più ampia e chiarire se il disaccordo evidenziato nel capitolo sia un limite o piuttosto un punto di partenza per una comprensione più ricca e complessa del tema.2. Sacro e Profano: Due Modi di Leggere il Testo Biblico
La natura della lettura sacra e profana
Il punto centrale è come interpretare i testi sacri, specialmente l’Ecclesiaste e Giobbe. Ci si chiede se esista una differenza tra leggere un testo in modo sacro oppure profano. Secondo alcuni, un testo sacro va interpretato rispettando le regole proprie del contesto sacro in cui è nato. Ogni altro modo di leggere sarebbe considerato profano e sminuirebbe la sua sacralità. Per questo motivo, si critica l’idea di studiare Qohelet isolandolo dal contesto biblico, quasi fosse un uomo qualunque di cui ricostruire la biografia. Si pensa che la sacralità di Qohelet venga dalla Bibbia stessa, e non viceversa.Qohelet e l’apocalittica: un rapporto di tensione
Si analizza poi il rapporto tra Qohelet e l’apocalittica, non come se fossero due mondi separati, ma come due realtà che si combattono pur nascendo dalla stessa tradizione. Si afferma che un’apocalisse senza l’esperienza di Qohelet sarebbe come un intervento divinoArtificiale eImprovviso. Allo stesso modo, Qohelet non potrebbe esistere senza l’attesa messianica e la delusione che ne consegue. Questa tensione si manifesta come insofferenza e disprezzo reciproco tra l’anima apocalittica e quella qoheletica, due forze che convivono e si scontrano.La parola poetica e la parola sacra
Un altro tema affrontato è la differenza tra la parola poetica e quella sacra, e se ci sia una gerarchia tra di loro. Ci si interroga sull’idea di un Dio che si fa uomo, umiliandosi, e se questo implichi una scala di valore tra le diverse forme di parola, dal sacro al profano. La questione principale rimane la diversa idea di sacro. Per alcuni, il sacro è qualcosa che appartiene al testo biblico stesso. Per altri, invece, il sacro è un’invenzione moderna, un modo per dare un senso a un mondo che ha perso i valori tradizionali. Da tutto ciò emerge quanto sia difficile mettere insieme fede e ragione, sacro e profano, in un dialogo che riconosce la distanza incolmabile tra queste due dimensioni.Ma è davvero utile e sensato insistere su una distinzione così netta tra sacro e profano, quando la stessa definizione di ‘sacro’ sembra essere così sfuggente e soggetta a interpretazioni contrastanti?
Il capitolo sembra dare per scontata una chiara comprensione di cosa costituisca il ‘sacro’, quando in realtà questa nozione è tutt’altro che univoca. Senza una definizione operativa di ‘sacro’ e ‘profano’, il rischio è quello di cadere in una dicotomia sterile che non aiuta a comprendere meglio i testi biblici. Per orientarsi in questo dibattito, sarebbe opportuno approfondire le discipline dell’ermeneutica e della filosofia della religione, che offrono strumenti concettuali utili per analizzare criticamente queste categorie.3. Dialoghi sull’Anima e sul Mondo
Corrispondenza intellettuale e temi teologici
Le lettere mostrano un intenso scambio di idee. Al centro di queste discussioni ci sono temi teologici, in particolare l’interpretazione della Bibbia. Un focus speciale è dato al Cantico dei Cantici e al rapporto tra Antico e Nuovo Testamento. Si nota una preferenza per l’Antico Testamento, che si accompagna a una visione della fede di tipo tragico, diversa da altre interpretazioni più sfumate.Riflessioni sulla mistica e sulla religione
L’analisi si allarga a temi mistici e religiosi. Viene esplorata l’identificazione di Gesù e Maria nella gnosi cristiana, approfondendo il ruolo di Sofia. Si discute anche della differenza tra interpretazioni mistiche e storiche dei concetti religiosi.Preoccupazioni esistenziali e visione del mondo contemporaneo
Un altro aspetto importante è la riflessione sulla letteratura, il giornalismo e la vita intellettuale del tempo. Da queste riflessioni emerge una sensazione di declino e di superficialità generale. Non mancano accenni alle difficoltà quotidiane, alle preoccupazioni per la salute e all’invecchiamento, che diventano temi ricorrenti nelle lettere.Divergenze, amicizia e disillusione comune
Nonostante i diversi punti di vista, si percepisce un forte legame di amicizia e un rispetto reciproco sul piano intellettuale. Questo legame è alimentato da una comune sensazione di disillusione nei confronti del mondo moderno. La corrispondenza può essere vista come un dialogo continuo su questioni esistenziali e spirituali, sullo sfondo di una realtà che viene percepita come sempre più problematica e in declino.Il ruolo della sofferenza e della speranza
Un tema che ritorna spesso è il ruolo della sofferenza, della disperazione e della speranza all’interno della fede. Attraverso le lettere, emergono diversi modi di intendere la religione e la spiritualità, dall’ortodossia al misticismo, fino a posizioni più laiche.Ma in che modo queste “riflessioni di tipo gnostico” arricchiscono o confondono ulteriormente la loro già complessa visione cristiana tradizionale?
Il capitolo menziona “riflessioni di tipo gnostico” senza però specificare in che modo queste influiscano sul loro dialogo. Sarebbe utile chiarire se queste riflessioni rappresentano una vera e propria deviazione dall’ortodossia cristiana, o se si tratta di semplici metafore per esprimere il loro disagio esistenziale. Per approfondire la comprensione delle influenze gnostiche nel pensiero moderno, si potrebbe esplorare il lavoro di autori come Ioan Couliano o approfondire studi sulla storia delle religioni.6. Carteggio di una Vita Intellettuale e Affettiva
Dialogo intellettuale e personale
La corrispondenza tra Guido e Sergio è un dialogo che dura da molto tempo, sia dal punto di vista delle idee che dei sentimenti personali. Tra gli argomenti che vengono discussi, ci sono figure importanti della letteratura e della teologia, come Bloy. Bloy viene analizzato in relazione al rapporto tra ebraismo e cristianesimo, mettendo in luce un modo di vedere l’antisemitismo che è sia critico che teologico. Si nota anche un interesse per la politica italiana del momento, con opinioni espresse su personaggi come Pivetti, Messori e Cardini. Queste opinioni fanno capire come Guido e Sergio analizzano la cultura cattolica e le questioni politiche.Preoccupazioni per la salute e la memoria
Un tema importante nelle lettere è la salute, soprattutto la malattia di Michèle. Questo argomento introduce nel dialogo una nota di preoccupazione e ci ricorda quanto gli esseri umani siano fragili. Le difficoltà che arrivano con l’età avanzata e la malattia si mescolano con pensieri sulla fatica di vivere e sulla perditaProgressiva delle forze. Inoltre, il progetto di conservare le lettere a Lugano fa nascere domande sul ricordo delle cose passate e sull’importanza della loro corrispondenza.Amicizia e sfide della vita
Nonostante a volte non siano d’accordo e nonostante le difficoltà personali, le lettere dimostrano che Guido e Sergio sono amici veri e che il loro legame dura nel tempo. Si aiutano e si sostengono a vicenda, sia con le idee che con l’affetto, mentre affrontano insieme le sfide della vita e il passare del tempo che non si può fermare. Il fatto che discutano su come conservare le loro lettere dimostra quanto tengano al loro rapporto e quanto desiderino che la loro amicizia rimanga testimonianza per il futuro.È realmente utile analizzare figure come Pivetti, Messori e Cardini per comprendere la cultura cattolica e le questioni politiche italiane, oppure si tratta di una lente eccessivamente specifica e potenzialmente fuorviante?
Il capitolo presenta l’analisi di Pivetti, Messori e Cardini come chiave per comprendere la cultura cattolica e la politica italiana, ma non chiarisce se questi autori siano rappresentativi della complessità di tali ambiti. Per una comprensione più ampia e sfaccettata, sarebbe opportuno integrare l’analisi con studi più generali sulla storia del cattolicesimo italiano e sulle dinamiche politiche contemporanee. Approfondimenti su autori come Norberto Bobbio o Giovanni Miccoli potrebbero offrire una prospettiva più ampia e meno limitata a figure specifiche.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]