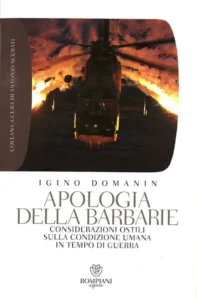1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Un eroe comune. 29 gennaio ’79, il giudice Alessandrini, gli anni di piombo, un romanzo familiare” di Igino Domanin ti porta dentro uno dei periodi più difficili della storia italiana, gli anni di piombo, visti attraverso la vita e la tragica morte del giudice Emilio Alessandrini. Non è solo la storia di un magistrato impegnato a Milano nelle indagini sul terrorismo, sia quello nero legato alla strage di piazza Fontana che quello rosso di gruppi come Prima Linea, ma è anche un viaggio nella memoria familiare, che parte dalla Pescara del boom economico e arriva fino al dramma nazionale della violenza politica. Il libro esplora il contrasto tra la vita apparentemente normale di una città di provincia e la tensione costante che Alessandrini affrontava ogni giorno, mostrando come il terrorismo e la lotta armata abbiano segnato un’intera generazione e lasciato ferite profonde nella storia familiare e collettiva, rendendo difficile capire e ricordare quel tempo di paura e ingiustizia.Riassunto Breve
L’Italia degli anni Sessanta e Settanta è segnata da forte tensione politica e violenza, un periodo chiamato anni di piombo. Città come Milano diventano teatro di scontri tra estrema destra e sinistra. Gruppi neofascisti come le Squadre d’azione Mussolini compiono attentati. In questo clima, il giudice Emilio Alessandrini, arrivato a Milano da una Pescara in rapida trasformazione da città rurale a centro balneare e consumistico, inizia a indagare sull’eversione nera, inclusa la strage di piazza Fontana. Le indagini sono difficili, ostacolate da strutture ereditate dal fascismo e sospetti di depistaggio, come nel caso del trasferimento del processo Piazza Fontana a Catanzaro. La violenza cresce, alimentando paura e sospetti su trame occulte. Parallelamente, la sinistra antagonista si radicalizza, specialmente tra i giovani emarginati e disoccupati, che rifiutano il lavoro e i valori borghesi, praticando azioni illegali e spingendo verso l’eversione di massa. Nascono gruppi come Autonomia Operaia e Prima Linea. Prima Linea si distingue dalle Brigate Rosse per una struttura meno rigida e azioni più tattiche, mirando a colpire le “funzioni” dello Stato e il “riformismo”. L’escalation di violenza include omicidi tra opposte fazioni e attacchi mirati contro rappresentanti dello Stato, come magistrati. Alessandrini indaga su entrambe le forme di terrorismo e su reati finanziari, sviluppando metodi investigativi innovativi e proponendo strategie per isolare i gruppi armati dalla loro base sociale. La sua efficacia e la sua posizione per una magistratura indipendente lo rendono un obiettivo. Dopo il sequestro Moro, Prima Linea intensifica la sua attività, decidendo di colpire un magistrato a Milano. Alessandrini, privo di scorta, viene assassinato il 29 gennaio 1979 da Sergio Segio e Marco Donat-Cattin. L’omicidio, avvenuto pochi giorni dopo l’uccisione del sindacalista Guido Rossa da parte delle BR, evidenzia il nuovo obiettivo del terrorismo: colpire chi opera efficacemente nello Stato democratico e il “cuscinetto riformista”. La morte di Alessandrini provoca forte sdegno e una netta condanna della lotta armata, portando all’isolamento ideologico dei gruppi terroristici. La società cerca un “riflusso” verso la normalità. Le rivelazioni dei primi pentiti, come Patrizio Peci e Roberto Sandalo, e la legislazione premiale diventano strumenti efficaci per smantellare le organizzazioni terroristiche. Marco Donat-Cattin, figlio del politico DC Carlo Donat-Cattin, viene identificato e arrestato, generando uno scandalo politico. Prima Linea si scioglie ufficialmente nel 1983, segnando la fine della lotta armata ma lasciando un’eredità complessa di dolore e difficoltà nel comprendere appieno quel periodo storico.Riassunto Lungo
1. Pescara, Milano e il giudice Alessandrini
Emilio Alessandrini viene da una famiglia tradizionale abruzzese. Suo padre, avvocato, viveva a Penne, un paese di campagna, e vedeva nel fascismo un’idea di ordine. La famiglia visse da vicino gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, un periodo difficile in cui il padre ricoprì anche il ruolo di podestà. Dopo la guerra, la famiglia si spostò a Pescara, dove Emilio trascorse la sua giovinezza. Qui mostrò fin da subito un carattere brillante e versatile, ereditando l’allegria della madre e il forte senso del dovere del padre. Studiò con profitto, viaggiò in Europa e iniziò presto una promettente carriera in magistratura, dove le sue doti professionali furono subito evidenti.La Nuova Pescara
La Pescara in cui Alessandrini cresce è una città in rapido cambiamento. Si trasforma da luogo segnato dalla guerra a vivace centro balneare e di consumo, dove la vecchia società rurale lascia spazio a nuove figure legate alla crescita edilizia e al turismo. La città diventa un simbolo di benessere, di una vita spensierata e apparentemente lontana dalle difficoltà del passato. Nello stesso periodo, vista con gli occhi di un bambino, la vita a Pescara appare concentrata su simboli di modernità e consumo: le automobili nuove, la pubblicità in televisione, i grandi magazzini. L’atmosfera generale è quella di una città in perenne vacanza, quasi ignorando i drammi che si stavano consumando nel resto del paese.L’Impegno a Milano
All’inizio degli anni settanta, ancora giovane, Emilio Alessandrini arriva alla procura di Milano. Trova un ambiente carico di tensione e violenza, segnato profondamente dalla strage di piazza Fontana. Si dedica subito alle indagini sull’eversione nera, immergendosi in un periodo storico di lotta armata e terrorismo diffuso. Il suo lavoro diventa cruciale nel tentativo di comprendere e contrastare le forze che minacciano la stabilità del paese. La città di Milano, cuore economico e spesso teatro di scontri, rappresenta un netto contrasto con la Pescara della sua giovinezza.Una Storia Simbolo
La vita di Emilio Alessandrini unisce mondi diversi: le radici nell’Abruzzo tradizionale, la crescita nella Pescara del boom economico e il ruolo di primo piano nelle indagini sul terrorismo a Milano. La sua vicenda personale e la sua morte nel 1979 sono parte integrante del complesso periodo noto come anni di piombo. Questo è stato un tempo di grande violenza e tensione che ha lasciato un segno profondo nella memoria di chi l’ha vissuto. Comprendere quegli anni e figure come Alessandrini è fondamentale per le generazioni che non li hanno attraversati. La sua storia rimane un esempio dell’impegno civile in un’epoca difficile.Il capitolo non rischia di presentare la transizione dalla Pescara “spensierata” alla Milano degli “anni di piombo” in modo un po’ troppo netto, omettendo sfumature cruciali del contesto nazionale che avrebbero reso più chiara la necessità dell’impegno di figure come Alessandrini?
Il capitolo descrive efficacemente il contrasto tra la Pescara del boom economico e la Milano tesa degli anni Settanta, ma la narrazione potrebbe beneficiare di un approfondimento sul contesto nazionale che legava queste realtà apparentemente distanti. La “spensieratezza” di Pescara, seppur percepita, non esisteva in un vuoto politico e sociale. Per cogliere appieno la portata dell’impegno di Alessandrini a Milano, è utile esplorare la storia politica e sociale italiana degli anni Sessanta e Settanta, comprendendo come le tensioni accumulate abbiano portato all’esplosione della violenza. Approfondire autori come Paul Ginsborg o Giorgio Bocca può fornire il quadro necessario per capire la complessità di quel periodo e il ruolo cruciale della magistratura.2. Tra Violenza Nera e Indagini Difficili
Gli anni Sessanta e Settanta in Italia sono un periodo segnato da una forte tensione politica e da episodi di violenza. Questa situazione crea un clima di paura diffusa e angoscia nella popolazione.L’estrema destra e la violenza
A Milano, in particolare, Piazza San Babila diventa un punto di riferimento per l’estrema destra giovanile. Questi gruppi sono influenzati da idee radicali e sono pronti allo scontro fisico. Da questo ambiente nascono organizzazioni come le Squadre d’azione Mussolini (SAM), gruppi terroristici neofascisti. Queste squadre sono responsabili di attentati dinamitardi che hanno uno scopo di propaganda, prendendo di mira obiettivi legati agli ambienti di sinistra.Le indagini della magistratura
In questo contesto difficile, il giudice Emilio Alessandrini inizia le sue indagini sulle attività eversive. La magistratura opera in un periodo complicato, con eredità del passato che pesano e sospetti sulla sua neutralità. L’inchiesta sulla strage di Piazza Fontana, avvenuta nel dicembre 1969, viene inizialmente gestita a Roma, ma poi trasferita a Milano, coinvolgendo il giudice Alessandrini. Le indagini si concentrano sulla cosiddetta “pista nera”, esplorando i legami con gruppi come Ordine Nuovo e figure come Freda e Ventura. Questo permette di superare i tentativi iniziali di incolpare gli anarchici per la strage.Un clima di paura diffusa
Questo periodo vede un alto numero di vittime a causa degli attentati, alimentando ulteriormente la paura. Nell’aria circolano discorsi su trame occulte e si arriva a parlare di uno “Stato stragista”. Eventi come la morte di Giuseppe Pinelli e il fallito golpe Borghese contribuiscono a questa percezione di instabilità e alla minaccia di un potere autoritario. La paura di un colpo di Stato militare è una presenza costante nelle conversazioni quotidiane, richiamando alla memoria esperienze storiche di violenza subita dalla popolazione. La violenza politica e l’incertezza pervadono così la vita di tutti i giorni, influenzando profondamente le esperienze personali e familiari.Ma si può davvero parlare di “Stato stragista” senza addentrarsi nel labirinto di depistaggi e responsabilità occulte che il capitolo accenna appena?
Il capitolo menziona il clima di paura e la percezione di uno “Stato stragista”, ma questa è una delle questioni più controverse e complesse degli anni Settanta. Affrontarla richiede di andare oltre la semplice constatazione della paura diffusa e di esaminare le prove, le inchieste e le interpretazioni che hanno cercato di fare luce su possibili complicità o inerzie istituzionali nelle stragi. Per farsi un’idea più completa, è indispensabile studiare la storia politica e giudiziaria di quel periodo, analizzando i lavori di autori come Paolo Persichetti o Guido Salvini, che hanno esplorato a fondo le zone d’ombra e le responsabilità non pienamente accertate.3. Memoria fragile e giustizia ostacolata negli anni di piombo
Capire eventi storici complicati, come l’uccisione del giudice Emilio Alessandrini, diventa difficile con il passare del tempo. La realtà del passato è fragile e dipende da come viene vista, e queste visioni cambiano. Anche se i fatti sull’omicidio di Alessandrini sono conosciuti, capire a fondo tutto quello che c’era intorno resta una domanda aperta. I modi in cui i media raccontano questi fatti possono renderli troppo semplici o distorcerli. In Italia, c’è una difficoltà generale a guardare al passato recente, specialmente agli anni di piombo, dove tante storie diverse creano confusione.Ostacoli nel sistema giudiziario
Il sistema della giustizia e della polizia ha mantenuto strutture e regole vecchie, ereditate dal fascismo. Questo ha incluso l’influenza di uffici come l’Ufficio affari riservati, che potevano facilmente sporcare le indagini e mandarle fuori strada. Per i giudici che seguivano i casi, era difficile avere un controllo diretto sulle indagini. Giudici giovani come Alessandrini si impegnavano per cambiare il sistema e rendere lo Stato più credibile e giusto.L’indagine sulla strage di Piazza Fontana
Nell’inchiesta sulla strage di Piazza Fontana, i giudici Alessandrini e D’Ambrosio trovarono prove concrete, per esempio scoprirono dove erano state comprate a Padova le borse usate per gli ordigni. Ma l’indagine incontrò molti ostacoli, tra cui la distruzione di una bomba che non era esplosa e che era una prova fondamentale. La decisione di spostare il processo da Milano a Catanzaro, usando una regola del vecchio codice fascista, fu vista come un atto politico che danneggiò la possibilità di arrivare alla verità.Un clima di tensione e violenza
Quel periodo fu segnato da una forte divisione politica e da molta violenza. L’uccisione del commissario Luigi Calabresi fu interpretata da alcuni come una risposta alla strategia della tensione, trovando appoggio in una parte della società e dei giornali. Questo clima pesante si sentiva anche nella vita di tutti i giorni, influenzando come le persone vedevano eventi nazionali come la crisi dell’energia, le misure per risparmiare, discussioni importanti come il voto sul divorzio e fatti di cronaca come il rapimento del giudice Mario Sossi.Davvero il ‘riflusso’ e l’indebolimento del marxismo furono solo una reazione alla violenza terroristica?
Il capitolo lega in modo piuttosto diretto e quasi esclusivo il fenomeno del “riflusso” e l’indebolimento dell’influenza marxista alla reazione contro la violenza terroristica e alla fine di una specifica stagione politica. Questa lettura, pur cogliendo un aspetto importante, rischia di semplificare eccessivamente processi sociali e culturali ben più complessi. Il desiderio di “normalità” e il distacco dall’ideologia non furono solo una risposta al trauma della violenza, ma furono alimentati anche da profonde trasformazioni economiche, dall’ascesa di nuovi modelli di consumo e di vita privata, e da un cambiamento nel tessuto sociale che andava oltre la sola dimensione politica. Per una comprensione meno superficiale di questo periodo cruciale, è indispensabile esplorare la storia sociale e culturale degli anni Settanta e Ottanta nella sua interezza. Approfondire gli studi di autori che hanno analizzato le molteplici sfaccettature della società italiana di quel decennio, come Paul Ginsborg o Stephen Gundle, può aiutare a cogliere la complessità dei fattori che portarono al mutamento del clima sociale e politico, evitando spiegazioni monocausali.14. Tra violenza e politica: il caso Donat-Cattin
Il 1979 segna per Prima Linea (PL) una fase di violenza che diventa caotica e non più legata a una strategia chiara, ma piuttosto a reazioni impulsive, vendetta e paranoia interna. Un documento circolato all’interno del gruppo cerca di giustificare l’omicidio del magistrato Alessandrini, rivelando una forte insicurezza e mancanza di lucidità. In questo periodo, il Partito Comunista Italiano (PCI) a Torino si impegna attivamente nel contrastare il terrorismo, a volte anche attraverso metodi come questionari che sollevano preoccupazioni per il rischio di favorire la delazione. Un agguato organizzato da PL contro un consigliere del PCI fallisce, portando alla morte di alcuni terroristi e innescando una spirale di rappresaglie sempre più violente che colpiscono anche persone innocenti. In un episodio particolarmente tragico, PL uccide Carmine Civitate, proprietario di un bar, basandosi su informazioni false che lo indicavano erroneamente come un informatore.Il contesto politico cambia
Nel frattempo, il quadro politico nazionale subisce importanti cambiamenti. Nel 1980, la Democrazia Cristiana (DC) definisce una nuova linea strategica attraverso un documento noto come “preambolo”, elaborato da Carlo Donat-Cattin. Questo testo sancisce ufficialmente la fine della politica di solidarietà nazionale che aveva visto la collaborazione con il PCI. La DC si orienta invece verso la ricerca di alleanze più strette con i partiti laici e in particolare con il Partito Socialista Italiano (PSI). Questo riassetto politico avviene mentre il fenomeno del terrorismo continua a rappresentare una minaccia costante per la stabilità del paese e le sue istituzioni.L’impatto dei pentiti
Un punto di svolta cruciale nella lotta contro le organizzazioni terroristiche è segnato dall’emergere dei primi collaboratori di giustizia, i cosiddetti “pentiti”. L’arresto di Patrizio Peci, esponente di spicco di Prima Linea, rappresenta uno dei primi casi significativi. Poco dopo, viene arrestato anche Roberto Sandalo, anch’egli membro di PL. Le rivelazioni di Peci e Sandalo si dimostrano fondamentali e aprono uno squarcio sulla struttura interna e le attività dei gruppi terroristici. I loro racconti e le loro testimonianze iniziano a fornire alle forze dell’ordine e alla magistratura informazioni preziose e concrete, nomi e dettagli operativi che fino a quel momento erano rimasti segreti.Lo scandalo Donat-Cattin
Tra le rivelazioni più esplosive fornite dai pentiti, emerge quella che riguarda Marco Donat-Cattin, figlio del politico democristiano Carlo Donat-Cattin. Viene svelata la sua appartenenza a Prima Linea e il suo coinvolgimento diretto nell’omicidio del magistrato Alessandrini. Questa notizia provoca un terremoto politico che scuote i vertici del governo e dell’establishment. Si solleva uno scandalo enorme, alimentato da accuse di favoreggiamento rivolte in particolare a Francesco Cossiga, all’epoca Presidente del Consiglio, per aver presumibilmente avvisato Carlo Donat-Cattin dell’imminente coinvolgimento del figlio. Nonostante le accese polemiche e il temporaneo ritiro dalla scena politica di Carlo Donat-Cattin, Francesco Cossiga riesce a superare un voto di sfiducia in Parlamento, mantenendo la sua posizione.Gli ultimi colpi e lo scioglimento
Mentre le indagini avanzano grazie alle informazioni dei pentiti, Prima Linea compie ancora atti di violenza. Tra questi, l’omicidio del magistrato Guido Galli, avvenuto per motivazioni simili a quelle addotte per l’omicidio Alessandrini: PL vede nella magistratura riformista un nemico efficace e un pilastro dello Stato da colpire. Le rivelazioni dei collaboratori di giustizia e l’introduzione di una legislazione premiale che incentiva la collaborazione si rivelano strumenti estremamente efficaci per smantellare le organizzazioni terroristiche dall’interno. Marco Donat-Cattin viene infine arrestato a Parigi, decide di collaborare con la giustizia e ottiene uno sconto di pena nella sua condanna. Anche altri membri di Prima Linea vengono arrestati e condannati per il loro ruolo nell’omicidio Alessandrini. Prima Linea si scioglie ufficialmente nel 1983, segnando la fine della sua esperienza di lotta armata e lasciando un’eredità complessa che include un ampio dibattito sul fenomeno del pentitismo e sulla giustizia di transizione.È davvero possibile considerare pienamente efficace la lotta al terrorismo quando i vertici dello Stato sono lambiti da accuse di favoreggiamento, anche solo “presumibilmente”?
Il capitolo descrive lo “scandalo enorme” scatenato dalle rivelazioni sul figlio di Carlo Donat-Cattin e le conseguenti accuse di favoreggiamento rivolte a Francesco Cossiga. Tuttavia, il testo non approfondisce le basi di tali accuse, il dibattito politico e giudiziario che ne seguì, né le reali conseguenze sull’immagine e l’autorità delle istituzioni impegnate nella lotta al terrorismo. Per cogliere la portata di questo episodio e le sue implicazioni sulla percezione dell’integrità dello Stato, è necessario approfondire la complessa interazione tra politica, magistratura e servizi di sicurezza negli anni di piombo. Utile a tal fine è lo studio di autori che hanno analizzato la crisi politica italiana e il fenomeno terroristico, come ad esempio Sergio Flamigni o Agostino Giovagnoli, e la documentazione relativa ai processi e ai dibattiti parlamentari dell’epoca.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]