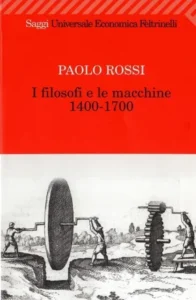1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Un breve viaggio e altre storie. Le guerre, gli uomini, la memoria” di Paolo Rossi ti porta dentro temi che fanno pensare un sacco. Il libro esplora come gli intellettuali italiani hanno fatto i conti col loro passato legato al fascismo nel dopoguerra Italia, parlando di quella strana memoria storica un po’ cancellata. Ma non è solo storia passata, si butta anche sulla natura della pace e guerra, chiedendosi se la natura umana sia più incline all’altruismo o alla violenza, e come si costruisce la pace vera, non solo a parole. Si parla di come sono cambiate le guerre, del ruolo dei diritti umani contro la sovranità assoluta degli stati, e si criticano certi tipi di pacifismo troppo semplici. Il libro tocca anche il conflitto politico Italia, specialmente negli anni difficili, e riflette sulla differenza tra storia e memoria, su come i luoghi come Città di Castello e l’identità si legano. È un viaggio tra idee complesse, figure come Enzo Paci o Danilo Zolo, e la ricerca di un senso in un mondo pieno di contraddizioni, dove nonostante tutto, i legami umani e certi valori resistono.Riassunto Breve
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti italiani, inclusi gli intellettuali, hanno cercato di nascondere il loro passato legato al fascismo. Questa tendenza a cancellare le tracce del regime riguarda anche la storia nazionale. Si discute la tesi del “nicodemismo”, secondo cui alcuni antifascisti si nascondevano all’interno del sistema fascista, ma questa visione a volte serve a giustificare l’adesione passata. Il confine tra fascismo e antifascismo era spesso poco chiaro, specialmente negli ultimi anni del regime e per i giovani. Molti che hanno partecipato alla Resistenza provenivano da un’educazione fascista. Il passaggio dal fascismo all’antifascismo per molti giovani non è stato un lungo viaggio meditato, ma un rapido abbandono di un sistema percepito come fallimentare per aderire a nuove speranze, spesso in modo confuso. Il caso del filosofo Enzo Paci illustra questa complessità, con un impegno politico nel fascismo e idee che sembrano persistere anche dopo il suo avvicinamento al marxismo e alla fenomenologia. Molti intellettuali con un passato fascista hanno scelto il silenzio dopo il 1945. Questa amnesia collettiva è stata favorita anche dalla politica del Partito Comunista di recupero verso chi si era schierato con Mussolini. Per molti il passaggio all’antifascismo è avvenuto con naturalezza, indicando una continuità culturale e psicologica di fondo, una fedeltà a una visione del mondo cercata prima nel fascismo e poi nell’antifascismo, piuttosto che una vera rottura. La pace non è una condizione naturale tra gli uomini o tra gli Stati; deve essere istituita e costruita. La natura umana non è intrinsecamente pacifica; l’aggressività e la tendenza alla violenza coesistono con l’altruismo e la solidarietà, che si manifesta inattesa anche in contesti di pericolo estremo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la coscienza europea ha sviluppato una forte avversione per la guerra tra paesi del continente e ha visto affermarsi il primato dei diritti umani sulla sovranità statale, promuovendo una legalità sovranazionale. Le guerre recenti mostrano una tendenza a minimizzare le proprie vittime e ad attribuire quelle nemiche a errori, un marcato contrasto con il vanto per le uccisioni nelle guerre passate. Critiche vengono mosse a forme di pacifismo che usano slogan semplicistici ignorando esempi storici in cui l’uso della forza è stato determinante per contrastare regimi oppressivi. L’intervento armato per prevenire atrocità di massa, pur doloroso, è considerato necessario e non necessariamente dettato da puro altruismo, ma anche da interessi strategici. La costruzione della pace richiede il superamento della sovranità assoluta degli Stati e l’istituzione di forme di ordine legale sovranazionale, come si osserva nel processo di integrazione europea. L’espansione globale della democrazia e la diminuzione della pena di morte rappresentano ragionevoli speranze per il futuro. La storia non segue un percorso predeterminato, ma è un processo complesso e imprevedibile in cui si alternano conflitto e cooperazione. L’Italia manifesta una propensione al conflitto politico che può degenerare in violenza, come evidenziato dagli episodi degli anni Settanta e Ottanta. L’avversario politico viene spesso considerato un nemico da sconfiggere. Esiste una tradizione culturale e filosofica che ha glorificato la guerra, presentandola come necessaria o come un momento etico. L’educazione, in certi periodi storici come il fascismo, ha promosso ideali militaristici. La guerra esercita un fascino, creando un senso di unità. Tuttavia, la pace non si ottiene solo con buoni sentimenti, ma richiede azioni concrete: la disponibilità al compromesso, la repressione della violenza da parte di un’autorità legittima e l’esistenza di forze di polizia. L’obiettivo è espandere le aree di convivenza regolata. Una pace stabile si fonda sul riconoscimento dell’aggressività umana, non sulla ricerca di utopie che giustifichino la violenza presente in nome di un futuro ideale. È essenziale abbandonare la logica amico/nemico e adottare prudenza, pazienza e scetticismo. La storia mira a un’interpretazione critica, mentre la memoria è emotiva e parziale. Testimonianze personali e storie locali rivelano il costo umano dei conflitti. Il Novecento ha visto tentativi di cancellare la memoria di eventi e vittime. Alcuni pensatori propongono visioni del mondo diverse: Alberto Asor Rosa vede un conflitto assoluto tra Bene e Male, criticando il massacro dei deboli, mentre Norberto Bobbio critica questo approccio. Danilo Zolo rifiuta l’intervento militare esterno anche contro gravi violazioni dei diritti umani, critica l’universalità dei diritti umani come imposizione occidentale e vede il terrorismo globale come reazione all’egemonia occidentale, spostandosi verso l’idea di una guerra giusta dei deboli. Il suo relativismo culturale è messo in discussione di fronte a pratiche che violano diritti umani fondamentali. Accanto a queste analisi, si osserva l’importanza della memoria e dei luoghi per l’identità personale. La memoria non è un deposito fedele, ma è un processo creativo. I luoghi in cui si vive diventano parte della propria identità. Avere un luogo di riferimento costante fornisce un senso di continuità essenziale. Negli ultimi decenni si sono verificati profondi cambiamenti nella vita materiale e sociale, superando condizioni di povertà e alta mortalità del passato, anche se disuguaglianze persistono a livello globale. Nonostante questi mutamenti, in alcuni luoghi si mantengono valori umani e legami comunitari, visibili nel rispetto tra le generazioni. Questa persistenza di relazioni e tradizioni in un luogo specifico contribuisce a un senso di radicamento e continuità, fondamentale per l’identità.Riassunto Lungo
1. Il passato nascosto degli intellettuali italiani
Molti italiani, inclusi coloro che facevano parte del mondo intellettuale, cercarono di nascondere i legami avuti con il fascismo dopo la fine della guerra. Questa volontà di cancellare le tracce del regime riguardava non solo le storie personali, ma anche il racconto della storia nazionale stessa. Comprendere questo periodo richiede uno sforzo per non applicare le distinzioni nette che abbiamo oggi alle scelte fatte allora. Le decisioni in quel tempo erano spesso segnate da incertezza ed esitazione. È fondamentale riconoscere le sfumature di un’epoca complessa.La complessità delle scelte
Il confine tra l’adesione al fascismo e l’opposizione ad esso era spesso poco definito, specialmente negli ultimi anni del regime e tra i giovani. Molti di coloro che in seguito parteciparono alla Resistenza provenivano da un’educazione ricevuta durante il fascismo. Per molti giovani, il passaggio da un’idea all’altra non fu un percorso lungo e meditato. Fu piuttosto un rapido abbandono di un sistema che sentivano fallito per abbracciare nuove speranze, spesso in modo confuso e senza una chiara visione futura. Questo rapido cambiamento dimostra quanto fosse difficile orientarsi in un periodo così turbolento.Diverse interpretazioni del passato
Dopo il 1945, molti intellettuali che avevano avuto un passato legato al fascismo scelsero il silenzio. Questa sorta di amnesia collettiva fu in parte favorita anche dalla politica del Partito Comunista, che cercò di recuperare chi si era schierato con il regime. Esiste un’interpretazione chiamata “nicodemismo”, secondo cui alcuni intellettuali antifascisti si nascondevano all’interno del sistema fascista, usando le sue pubblicazioni per diffondere idee non allineate. Questa visione è però dibattuta e a volte usata per giustificare l’adesione passata. Per molti il passaggio all’antifascismo avvenne con naturalezza, un’idea sostenuta dallo storico Renzo De Felice. Questa prospettiva suggerisce una continuità culturale e psicologica di fondo, quasi una fedeltà a una visione del mondo cercata prima nel fascismo e poi nell’antifascismo, più che una vera e propria rottura interiore.Il caso di Enzo Paci
L’esperienza del filosofo Enzo Paci è un esempio di questa complessità. Paci ebbe un impegno politico nel fascismo fin dal 1933. Credeva in un fascismo che si opponeva alla borghesia e puntava su idee collettiviste, disprezzando la democrazia e il liberalismo. Aderì anche a concetti sulla decadenza dell’Occidente e persino a tesi razziste. Dopo la guerra, Paci divenne un filosofo stimato e si avvicinò al marxismo e alla fenomenologia. Tuttavia, alcune idee di base, come il legame stretto tra pensiero e azione e l’idea di costruire la storia, sembrano essere rimaste presenti nel suo pensiero. La sua storia personale illustra i percorsi difficili e a volte contraddittori che caratterizzarono la vita di molti intellettuali in quel periodo.Ma davvero il passaggio dal fascismo all’antifascismo fu solo una “naturale” ricerca di una visione del mondo, come suggerisce una certa storiografia, o non si rischia così di edulcorare scelte politiche e morali ben più nette?
Il capitolo presenta l’idea, sostenuta da alcuni storici, di una continuità quasi “naturale” nel passaggio di molti intellettuali dal fascismo all’antifascismo. Tuttavia, questa prospettiva, pur utile a cogliere le sfumature di un’epoca complessa, può apparire riduttiva se non integrata con un’analisi più profonda delle rotture politiche, etiche e ideologiche che la fine del regime e la Resistenza comportarono. Per esplorare a fondo questa tensione tra continuità e rottura, è fondamentale confrontarsi con le diverse interpretazioni storiografiche del periodo, leggendo non solo gli autori che enfatizzano la continuità (come Renzo De Felice) ma anche coloro che hanno messo in luce la radicalità della scelta antifascista e le responsabilità individuali. Approfondire la storia politica e intellettuale del Ventennio e del dopoguerra è essenziale.2. La Pace Costruita e l’Altruismo Inatteso
La pace tra le persone e tra i paesi non esiste in natura, ma deve essere creata e mantenuta con impegno. La natura umana non è solo pacifica; dentro di noi convivono la tendenza all’aggressività e alla violenza, ma anche la capacità di aiutare gli altri e di essere solidali. Un esempio forte di questa capacità di altruismo si è visto durante la Seconda Guerra Mondiale. In quel periodo di grande pericolo e di rifiuto di combattere, persone che non si conoscevano hanno offerto riparo e aiuto a chi ne aveva bisogno. Questo dimostra che la generosità umana può emergere anche nelle situazioni più difficili e inaspettate, superando la paura e l’interesse personale.Dopo la Guerra: Nuove Idee di Pace e Diritti
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in Europa è nata una forte volontà di evitare altre guerre tra i paesi del continente. Si è capito che i diritti fondamentali di ogni persona sono più importanti della sovranità assoluta di uno Stato. Questo ha portato alla creazione di leggi che vanno oltre i confini nazionali, promuovendo un ordine legale che lega insieme i paesi. Questa nuova mentalità ha gettato le basi per la costruzione di una pace duratura in Europa, basata sul rispetto reciproco e sulla collaborazione tra Stati che accettano di limitare la propria sovranità per un bene comune più grande. Si è diffusa l’idea che la sicurezza e il benessere di un paese siano legati a quelli degli altri, favorendo l’integrazione.Le Guerre di Oggi: Come Sono Cambiate
Le guerre più recenti, chiamate a volte “neoguerre”, mostrano caratteristiche diverse rispetto al passato. Oggi si tende a sminuire il numero delle proprie vittime e ad attribuire la responsabilità di quelle nemiche a errori o incidenti. Questo è molto diverso da prima, quando i soldati si vantavano delle uccisioni in battaglia come segno di valore. Si nota anche un cambiamento nel modo in cui vengono trattati i sostenitori del nemico e i civili coinvolti. C’è una tendenza crescente ad applicare alle azioni militari principi simili a quelli usati dalla polizia civile, cercando di minimizzare i danni collaterali e di agire con maggiore precisione. Questi cambiamenti riflettono una maggiore sensibilità, almeno apparente, verso le conseguenze umane dei conflitti, pur non eliminando la violenza.Critiche al Pacifismo Semplice
Alcune idee pacifiste vengono criticate quando usano slogan troppo semplici, come “senza se e senza ma” o “la guerra non risolve mai nulla”. Queste frasi non tengono conto della storia, dove in alcuni casi l’uso della forza è stato necessario per fermare governi che opprimevano il loro popolo e impedivano i diritti fondamentali. Ignorare questi esempi storici rende il pacifismo meno efficace nel dibattito pubblico e nella ricerca di soluzioni concrete. Alcuni modi di pensare la pace finiscono per assomigliare all’idea di “guerra giusta”, riprendendo concetti antichi legati alla lotta tra classi sociali o al desiderio di cambiare un sistema considerato ingiusto con la forza. Questo mostra che il dibattito sulla pace e sulla guerra è complesso e non ammette risposte facili o universali, richiedendo una riflessione più profonda sulle diverse situazioni e sulle loro specificità.Intervento Armato per Proteggere
L’intervento militare per fermare violenze terribili contro intere popolazioni, anche se è una scelta difficile e dolorosa, a volte è considerato necessario. L’obiettivo è proteggere i diritti umani fondamentali quando uno Stato non può o non vuole farlo, intervenendo per prevenire massacri e atrocità. Questa decisione non è sempre guidata solo dall’altruismo puro, ma può anche dipendere da interessi strategici dei paesi che intervengono, il che non la rende meno necessaria in certi contesti. Criticare questi interventi solo perché non avvengono ovunque nel mondo o perché a volte possono peggiorare la situazione è considerato un argomento debole, che non affronta la gravità delle atrocità in corso e la necessità di agire. La realtà è che affrontare situazioni di violenza di massa richiede decisioni complesse, dove l’uso della forza, pur con tutte le sue conseguenze negative, può essere visto come l’unica opzione per cercare di salvare vite umane e fermare il male.Costruire la Pace e Guardare al Futuro
Per costruire una pace stabile e duratura, è importante superare l’idea che gli Stati abbiano un potere assoluto e creare forme di legge e ordine che vadano oltre i confini nazionali. L’istituzione di una legalità sovranazionale è fondamentale per gestire i rapporti tra paesi e prevenire i conflitti. L’integrazione europea è un esempio di questo processo, dove i paesi hanno scelto di collaborare e di limitare la propria sovranità per costruire un futuro comune basato sulla pace e sulla prosperità condivisa. Nonostante le difficoltà e le tendenze negative che si possono osservare nel mondo, ci sono anche motivi per avere “ragionevoli speranze” per il futuro. L’espansione della democrazia in diverse parti del mondo e la diminuzione del numero di paesi che applicano la pena di morte sono segnali positivi di un progresso verso una maggiore tutela della vita umana. La storia non segue un percorso semplice o già scritto, ma è un processo complicato e imprevedibile. In questo processo, momenti di conflitto si alternano a periodi di cooperazione e progresso, mostrando che il futuro della pace dipende dalle scelte che vengono fatte ogni giorno.La presunta “maggiore sensibilità” delle “neoguerre” descritta nel capitolo non rischia di nascondere la brutalità immutata dei conflitti moderni?
Il capitolo accenna a un cambiamento nelle guerre recenti, parlando di “maggiore sensibilità” o azioni simili a quelle della polizia. Tuttavia, questa descrizione sembra ignorare la realtà di molti conflitti contemporanei, caratterizzati da un elevatissimo numero di vittime civili, l’uso di tecnologie che rendono la violenza più distante e “pulita” per chi la esercita ma non per chi la subisce, e strategie che mirano deliberatamente a terrorizzare le popolazioni. La retorica sulla precisione o sulla minimizzazione dei danni può essere una forma di propaganda per legittimare l’uso della forza. Per comprendere meglio le dinamiche delle guerre attuali e la loro rappresentazione, sarebbe utile approfondire gli studi sulla guerra asimmetrica, la sociologia dei conflitti e l’analisi critica dei media. Autori come M. Kaldor o H. Zinn offrono prospettive che mettono in discussione le narrazioni ufficiali sui conflitti.3. La Difficile Conquista della Pace
In Italia, il conflitto politico spesso rischia di diventare violenza. Gli anni Settanta e Ottanta, con i loro attentati e omicidi, ne sono un esempio chiaro e drammatico. Questa tendenza a considerare chi la pensa diversamente come un nemico da sconfiggere sembra radicata. Eppure, nonostante questa forte tensione, la storia italiana mostra anche momenti di umanità e gesti di riconciliazione tra persone che stavano su fronti opposti, dimostrando che la convivenza è possibile.Le Idee che Hanno Glorificato la Guerra
Nella cultura e nella filosofia, esiste una lunga tradizione che ha esaltato la guerra, presentandola come qualcosa di necessario per la vitalità dei popoli o come un momento etico fondamentale per superare l’egoismo individuale. Pensatori influenti come Hegel e Nietzsche, insieme a movimenti artistici e culturali come il Futurismo, hanno contribuito in modo significativo a diffondere questa visione. Inoltre, l’educazione, in certi periodi storici come quello fascista, ha attivamente promosso ideali militaristici, raffigurando la guerra non solo come un valore positivo, ma anche come una prova inevitabile e quasi desiderabile.Cos’è la Pace e Cosa Richiede
La guerra può avere un suo fascino, creando un forte senso di unità tra le persone e, per alcuni, offrendo un modo per dare un senso alla vita confrontandosi con l’idea della morte. Tuttavia, è fondamentale capire che la pace non si costruisce solo con buoni sentimenti o speranze, ma richiede azioni concrete e precise. Servono la disponibilità a trovare compromessi, la capacità di un’autorità riconosciuta di fermare la violenza e l’esistenza di forze di polizia che garantiscano l’ordine. L’obiettivo vero è allargare sempre di più gli spazi dove le persone possono vivere insieme secondo regole condivise. È vero che la natura umana include anche pulsioni aggressive, e una pace che duri nel tempo si basa sul riconoscimento di questa realtà, non sulla ricerca di mondi perfetti che poi finiscono per giustificare la violenza di oggi in nome di un futuro ideale. Per costruire una convivenza stabile, è essenziale abbandonare l’idea di dividere il mondo in ‘amici’ e ‘nemici’; dobbiamo invece agire con prudenza, avere pazienza e mantenere un sano scetticismo verso le soluzioni troppo semplici.Guardare al Passato: Storia e Memoria
Quando guardiamo al passato, la storia e la memoria ci offrono prospettive molto diverse. La storia cerca un’interpretazione basata sui fatti e sull’analisi critica. La memoria, invece, è più legata alle emozioni, è personale e spesso incompleta. Le testimonianze dirette delle persone e le storie dei luoghi specifici rivelano il costo umano dei conflitti, un aspetto che le grandi narrazioni storiche a volte trascurano. Il Novecento, in particolare, ha visto tentativi di cancellare completamente il ricordo di certi eventi e delle loro vittime.[/membership]Abbandonare l’idea di ‘amici’ e ‘nemici’ basta davvero a costruire la pace, o è solo un pio desiderio che ignora la natura stessa del conflitto politico?
Il capitolo suggerisce che per una convivenza stabile sia essenziale abbandonare l’idea di dividere il mondo in ‘amici’ e ‘nemici’. Ma questa dicotomia non è forse, per alcuni, il cuore stesso della politica e del conflitto? Ridurre la pace a regole e autorità, pur necessario, non rischia di trascurare le radici profonde e spesso ideologiche dello scontro, come quelle che hanno caratterizzato gli anni citati nel capitolo? Per esplorare questa tensione, si potrebbero approfondire le riflessioni sulla natura del politico e del conflitto. Un punto di partenza fondamentale è l’opera di Carl Schmitt, che ha posto la distinzione amico/nemico al centro della sua teoria. Anche il pensiero di Thomas Hobbes, sulla necessità dell’autorità per superare lo stato di natura, offre spunti rilevanti sulla gestione della conflittualità umana.4. Radici e Visioni del Mondo
Alberto Asor Rosa propone di guardare oltre l’Occidente, usando l’Apocalisse come chiave di lettura. Secondo lui, il conflitto tra Bene e Male, che in passato era relativo, oggi è diventato assoluto, portando a una situazione quasi apocalittica. Non critica la guerra in sé, ma condanna il massacro, inteso come la guerra combattuta da chi è più forte militarmente contro i più deboli. Questa visione porta a distinguere tra popoli che combattono e popoli che sono destinati a essere sconfitti. Norberto Bobbio ha espresso critiche su questa impostazione, chiedendo quale fosse l’alternativa concreta all’Occidente e sottolineando che la storia è un intreccio complesso di aspetti positivi e negativi, non una lotta assoluta tra bene e male.Diverse Viste sul Conflitto e i Diritti Umani
Danilo Zolo ha sviluppato una posizione che inizialmente promuoveva un pacifismo basato sull’isolamento dei contendenti. Rifiuta l’intervento militare esterno anche quando ci sono gravi violazioni dei diritti umani, definendole “controversie interne”. Critica l’idea che i diritti umani siano universali, vedendola come un’imposizione tipica del pensiero occidentale. Interpreta il terrorismo globale come una reazione all’egemonia di Stati Uniti ed Europa e suggerisce che la soluzione sia eliminare questo dominio. Questa visione lo porta a considerare una sorta di “guerra giusta” combattuta dai deboli contro i forti. Le sue idee sono influenzate dal pensiero realista e, in passato, dal marxismo, che puntava a trasformare radicalmente le istituzioni statali. Tuttavia, il suo approccio basato sul relativismo culturale, che considera ogni civiltà un mondo a sé stante, solleva interrogativi quando si confronta con pratiche che violano diritti umani fondamentali, che non possono essere considerati negoziabili.L’Importanza della Memoria e dei Luoghi
Accanto a queste analisi sulle visioni del mondo, emerge quanto siano importanti la memoria e i luoghi per costruire l’identità di una persona. La memoria non è un semplice archivio di fatti passati, ma un processo attivo e creativo che dà forma a chi siamo. I luoghi in cui viviamo e a cui siamo legati diventano una parte integrante della nostra identità. Avere un luogo di riferimento stabile e costante, come può essere Città di Castello per chi vi è cresciuto, offre un senso di continuità nel tempo che è fondamentale per sentirsi radicati.Cambiamenti Sociali e Persistenza dei Valori
Negli ultimi decenni, la vita materiale e sociale ha subito cambiamenti profondi. Si sono superate condizioni di povertà diffusa e alta mortalità che caratterizzavano il passato, anche se le disuguaglianze economiche e sociali persistono ancora a livello globale. Nonostante queste grandi trasformazioni, in alcuni luoghi specifici si è riusciti a mantenere valori umani importanti e forti legami comunitari. Questo è visibile, ad esempio, nel rispetto reciproco tra le diverse generazioni. Questa capacità di conservare relazioni significative e tradizioni in un luogo preciso contribuisce in modo sostanziale a quel senso di radicamento e continuità che è così importante per l’identità personale e collettiva.Ma se i diritti umani universali sono solo un’imposizione occidentale, quali atrocità diventano giustificabili come semplici ‘controversie interne’?
Il capitolo presenta una posizione che, nel criticare l’universalismo dei diritti umani e l’intervento esterno, definisce gravi violazioni come “controversie interne”. Questa prospettiva, influenzata dal relativismo culturale, solleva seri interrogativi sulla possibilità di condannare pratiche che la maggior parte delle culture considera inaccettabili. Per confrontarsi con questa visione e comprenderne le implicazioni, è fondamentale esplorare i dibattiti in etica e diritto internazionale, leggendo autori che hanno argomentato a favore della universalità dei diritti o che hanno analizzato criticamente i limiti del relativismo, come Martha Nussbaum o Amartya Sen.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]