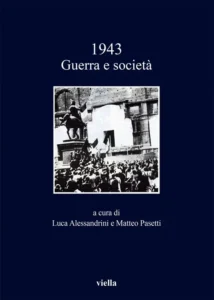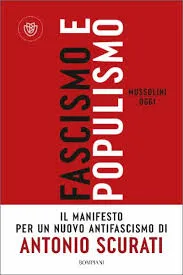1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Tiranni e tirannide nel Trecento italiano” di Autori Vari ti catapulta nella complessa realtà delle città italiane del Trecento, un periodo cruciale dove la questione della tirannide non era solo un problema di regimi signorili, ma riguardava la qualità stessa del governo, anche nei comuni. Questo libro esplora come la percezione di cosa fosse un tiranno si sia evoluta, passando da una visione morale e religiosa a una più politica e giuridica, influenzata dal pensiero aristotelico e da giuristi come Bartolo da Sassoferrato, che distinse tra tirannia per mancanza di titolo e per esercizio ingiusto del potere. Scoprirai come l’ascesa delle signorie, spesso legittimate da poteri universali, abbia mutato il panorama politico e generato un acceso dibattito ideologico, specialmente a Firenze contro l’espansionismo visconteo, fissando l’immagine della libertà repubblicana contrapposta alla tirannide. Il volume analizza anche come la Chiesa usasse l’accusa di tirannia per colpire i signori e come le cronache dell’epoca descrivessero queste figure, attingendo a modelli narrativi classici e medievali, e persino il potente simbolismo della bestialità e dell’antropofagia usato per rappresentare il tiranno che “divora” la comunità, mostrando la violenza politica e sociale di quel tempo. È un’immersione affascinante nella storia politica Italia medievale e nel concetto di tirannia nel Trecento italiano.Riassunto Breve
Il concetto di tirannia diventa centrale nel Trecento italiano, emergendo non solo nelle signorie ma anche nei governi comunali corrotti. Inizialmente non c’è una netta separazione tra comune e signoria; la differenza sta nella qualità del governo, se agisce per il bene comune o per interesse privato. Il termine “tiranno” si usa quando un governante perde il consenso agendo egoisticamente. Un momento chiave è l’inizio del Trecento, quando titoli imperiali e papali legittimano i signori, rendendo il loro potere più autoritario e meno legato al consenso cittadino. Il pensiero di Tommaso d’Aquino, basato su Aristotele, definisce la tirannia moralmente e politicamente come il governo che cerca il bene privato. Bartolo da Sassoferrato aggiunge una definizione giuridica, distinguendo chi governa senza titolo, chi abusa del potere legittimo e chi agisce in modo nascosto, manipolando le istituzioni. Egli osserva la difficoltà di un governo sempre giusto. Più tardi, figure come Coluccio Salutati a Firenze contrappongono la libertà repubblicana alla tirannia signorile, influenzando la narrazione storica. La questione principale riguarda il rapporto tra governanti e governati e la gestione della complessità politica.L’idea di tiranno si sviluppa dal pensiero antico e teologico, che lo vede come ingiusto e contro la volontà divina. Gregorio Magno descrive diverse forme di tirannia. Con l’arrivo di Aristotele, la tirannia è vista come una possibile degenerazione di qualsiasi regime, spesso causata dalla discordia interna, e si misura sulla capacità di garantire il bene comune e la pace. Diventa l’effetto di una crisi politica. Bartolo sistematizza legalmente la figura del tiranno, distinguendo chi non ha titolo legittimo da chi abusa di un titolo. La tirannia può essere palese o nascosta, violando leggi e principi fondamentali. Il consenso ottenuto con la forza non legittima il potere. L’esperienza pratica mostra la tirannia come una categoria per descrivere governi autoritari, a volte considerati necessari per mantenere l’ordine in città divise. La necessità della pace può giustificare forme di potere che altrimenti sarebbero viste come tiranniche.Alcuni signori, come i Visconti, usano strategicamente il termine “tiranno” con il suo significato più antico di signore forte per difendersi dalle accuse. Il trattato di Bartolo rende il termine più negativo. Bartolo identifica la “tirannia velata”, un potere esercitato senza titolo manifesto o manipolando le istituzioni comunali esistenti, agendo nell’ombra. Esempi storici mostrano come il potere signorile si consolidi gradualmente controllando le magistrature cittadine dall’interno prima di manifestarsi apertamente, rappresentando una fase intermedia e ambigua.La Chiesa usa il termine “tirannia” per descrivere il potere che turba la pace e perseguita i fedeli. Inizialmente colpisce gli imperatori, poi molti signori italiani. Sotto papa Giovanni XXII, l’accusa di tirannia si lega a quella di ribellione ed eresia. I documenti pontifici descrivono i signori come malvagi, violenti, sacrileghi, legati all’occulto, che opprimono il clero e profanano luoghi sacri. Nonostante queste accuse, i signori spesso rimangono attivi politicamente e ottengono riconoscimenti dal papato. Le signorie finiscono in modi diversi: con la violenza, come l’eccidio dei Chiavelli, o con accordi negoziati. Le signorie più autoritarie lasciano spesso solo la rivolta violenta come via d’uscita. Il termine “tirannia” diventa comune nel linguaggio popolare per descrivere un governo che limita la partecipazione e agisce per interesse personale.I cronisti italiani del basso Medioevo descrivono il tiranno usando diversi modelli narrativi. Alcuni riprendono aneddoti da propaganda anti-imperiale o testi classici. L’Anonimo Romano descrive Cola di Rienzo usando modelli dalla letteratura latina, paragonandolo a figure come Cesare o imperatori corrotti. Giovanni Villani vede la tirannia come un castigo divino, caratterizzata dall’uso ingiusto della giustizia. Applica il termine a figure del Trecento come i Visconti o Gualtieri di Brienne. La sua descrizione del governo di Gualtieri a Firenze diventa un punto di riferimento per gli storici fiorentini successivi. Le cronache spesso rielaborano interpretazioni e aneddoti già esistenti.La figura del tiranno è strettamente legata all’idea di bestialità e antropofagia, con radici antiche nel mito greco. Il tiranno è visto come un lupo che divora il suo gregge. È caratterizzato da vizi come superbia, avarizia, lussuria, gola e ira, che lo rendono selvatico e privo di ragione, agendo in modo bestiale. Le descrizioni fisiche spesso riflettono questa natura. L’attitudine antropofaga si manifesta metaforicamente nell’abuso di potere che divora la libertà e i beni dei cittadini. Questa bestialità è vista come innaturale. La reazione a questa oppressione può portare a una vendetta cruenta, a volte con atti di cannibalismo rituale del tiranno o dei suoi rappresentanti. Questo rappresenta un contrappasso simbolico: chi ha divorato la comunità viene a sua volta divorato, degradando il potente e ristabilendo l’ordine sociale, spesso visto come una punizione divina.Riassunto Lungo
1. La Tirannide oltre la Forma di Governo
Le città nel Trecento si confrontano con il problema della tirannide. Questo fenomeno non riguarda solo i governi dei signori, dove il potere forte allenta il legame con la comunità, ma si manifesta anche all’interno dei governi cittadini che mostrano problemi simili. Si diffonde la sensazione di trovarsi di fronte a una nuova difficoltà politica, legata ai grandi cambiamenti nel modo in cui le città sono governate. Le vecchie interpretazioni storiche mettevano in forte contrasto il governo cittadino, visto come libero, con il governo dei signori, considerato dispotico e tirannico. Queste interpretazioni dicevano che la crisi dei governi cittadini era dovuta alle lotte interne e che l’arrivo dei signori segnava la fine della libertà. Studi più recenti superano questa visione, mostrando che il passaggio tra i due tipi di governo non fu così netto e difficile come si pensava. Le città italiane presentano un quadro politico complesso con la presenza di molti soggetti diversi.Cosa significava tirannide
Le ricerche mostrano che già dalla metà del Duecento non c’era una netta opposizione tra il governo cittadino e quello del signore. Entrambi erano modi possibili di governare, spesso con strutture che mescolavano elementi dell’uno e dell’altro. La differenza che le persone del tempo percepivano riguardava il modo in cui il governo veniva esercitato: il governo cittadino si basava sulla partecipazione e sull’elezione, mentre quello del signore si basava sulle sue decisioni personali. Il termine “tiranno” o “tirannide” veniva usato quando il governo, fosse esso cittadino o signorile, non agiva per il bene di tutti ma per interesse personale, perdendo così l’appoggio della comunità. Questa idea di tirannide si arricchisce grazie al pensiero di filosofi come Tommaso d’Aquino ed Egidio Romano, diffuso nel Trecento. Essi definiscono la tirannia come quel governo, esercitato da una persona, da poche o da molte, che cerca il proprio vantaggio invece del bene comune. Questa definizione, che unisce aspetti morali e politici, influenza chi scriveva cronache e chi pensava alla politica, portandoli a vedere la tirannide non come un tipo specifico di governo, ma come un modo sbagliato e corrotto di governare. A metà del Trecento, Bartolo da Sassoferrato offre una definizione dal punto di vista del diritto. Egli distingue la tirannia di chi governa senza averne il diritto, quella di chi pur avendo il diritto usa il potere in modo ingiusto, e quella “nascosta” che si presenta sotto un aspetto legale. Bartolo nota quanto sia difficile per un governo agire sempre per il bene comune e sottolinea la debolezza dei poteri superiori (come l’Imperatore o il Papa) nel garantire la giustizia.Un cambiamento importante nel Trecento
Gli anni intorno al 1310 rappresentano un momento di svolta. Prima di questo periodo, il potere dei signori era spesso meno stabile e più legato all’approvazione della comunità cittadina. Tuttavia, il fallimento della spedizione dell’Imperatore Enrico VII in Italia porta l’Imperatore e il Papa a concedere ai signori dei titoli ufficiali, chiamati vicariati. Questi titoli danno una nuova legittimità al potere dei signori, liberandoli dal bisogno del consenso della comunità cittadina. Ciò modifica profondamente il modo di governare dei signori, rendendolo più autoritario e meno basato sulla condivisione. Questo cambiamento nel potere signorile viene percepito come una rottura pericolosa rispetto al passato.Lo scontro tra idee diverse
In seguito, in città come Firenze, pensatori come Matteo Villani e Coluccio Salutati sviluppano idee forti sulla libertà repubblicana. Essi agiscono anche in risposta all’espansione e alla crescente potenza di signori come quelli della famiglia Visconti. I loro scritti creano un forte contrasto tra l’idea di una repubblica libera e il governo di un signore visto come tiranno. Questo scontro di idee contribuisce a creare la narrazione storica che mette in netta opposizione i governi cittadini e quelli signorili. La questione centrale che rimane aperta in tutto questo periodo è la qualità del rapporto tra chi governa e chi è governato e come gestire la vita politica delle città che diventa sempre più complicata.Davvero la legittimazione autoritaria dei signori nel Trecento si spiega unicamente con il fallimento di una spedizione imperiale?
Il capitolo presenta il fallimento della spedizione di Enrico VII come il momento chiave che porta Imperatore e Papa a concedere i vicariati, legittimando così un potere signorile più autoritario e meno legato al consenso cittadino. Questa spiegazione, pur valida, potrebbe apparire riduttiva. La transizione verso forme di potere più stabili e meno dipendenti dalla comunità fu probabilmente influenzata da una pluralità di fattori, non solo politici ma anche economici e sociali, che resero il consenso cittadino meno centrale o più difficile da ottenere per i governi signorili. Per comprendere meglio questo complesso passaggio, sarebbe utile approfondire la storia economica e sociale delle città italiane del primo Trecento, oltre alla storia delle istituzioni e delle relazioni tra poteri locali e sovralocali. Autori come Gene Brucker o John Larner possono offrire prospettive più ampie sul contesto dell’epoca.2. Il tiranno tra diritto e necessità politica
L’idea antica e medievale del tiranno
La figura del tiranno ha radici profonde nel pensiero antico, ma si sviluppa in modo significativo nel Medioevo, influenzata dalla teologia e dal diritto. All’inizio, il tiranno è visto principalmente in termini morali e religiosi. È colui che governa senza giustizia, agendo contro la volontà divina, spesso spinto dalla superbia. Figure come Agostino e Gregorio Magno descrivono il tiranno come chi non rispetta le leggi e cerca il potere per sé stesso, non per servire un fine superiore. Gregorio Magno, in particolare, estende il concetto di tirannia, vedendola non solo nel governo di uno stato, ma anche in ambiti più piccoli e persino nel desiderio interiore di dominare gli altri. Questa visione iniziale pone l’accento sulla deviazione morale e spirituale del governante.La svolta con Aristotele e le città comunali
L’arrivo del pensiero di Aristotele e l’esperienza concreta delle città comunali portano a una trasformazione nella comprensione della tirannia. Tommaso d’Aquino, ad esempio, inizia a considerare la tirannia non solo come la corruzione della monarchia, ma come una possibile degenerazione di qualsiasi forma di governo, inclusi quelli collettivi. Questa degenerazione è spesso vista come causata dalla discordia interna alla comunità. La qualità di un governo viene misurata sempre più in base alla sua capacità di promuovere il bene comune e garantire la pace. La tirannia, in questa nuova prospettiva, diventa l’effetto di una crisi politica e sociale, non più soltanto una questione di immoralità individuale del governante.La definizione giuridica e le sue sfumature
Questa evoluzione porta a una sorta di “normalizzazione” o, meglio, a una sistematizzazione giuridica del concetto. Bartolo da Sassoferrato è fondamentale in questo processo, distinguendo in modo netto chi detiene il potere senza un titolo legittimo (il tiranno “ex defectu tituli”) da chi, pur avendo un titolo valido, ne abusa nell’esercizio del potere (il tiranno “ex parte exercitii”). La tirannia può manifestarsi in modo evidente o nascosto, violando non solo le leggi scritte ma anche principi giuridici fondamentali non scritti. Anche il consenso popolare non è sufficiente a legittimare un potere se è stato ottenuto con la violenza o incute paura, rendendo comunque quel potere tirannico ai sensi del diritto.L’esperienza delle signorie e la necessità politica
L’instabilità politica e le lotte interne che caratterizzano le città nel Trecento, con l’emergere delle signorie, mostrano come la tirannia diventi una categoria usata per descrivere governi autoritari. A volte, questi governi sono persino percepiti come necessari per ristabilire e mantenere l’ordine e la pace in comunità profondamente divise e conflittuali. Giuristi e cronisti iniziano a utilizzare il termine “tiranno” in modo più flessibile, talvolta applicandolo anche a governanti che, pur usando metodi autoritari, si dimostrano efficaci nel garantire la stabilità. La necessità di preservare la comunità e assicurare il bene fondamentale della pace può, in certi contesti, sembrare giustificare forme di potere che, secondo una visione morale e tradizionale, sarebbero considerate tiranniche.Ma se la “necessità politica” può rendere un tiranno un garante della pace, non si svuota di significato il concetto stesso di tirannia?
Il capitolo introduce l’idea che l’esperienza delle signorie nel Trecento abbia portato a considerare governi autoritari, talvolta definiti “tirannici”, come potenzialmente necessari per ristabilire l’ordine. Questa prospettiva solleva un interrogativo fondamentale sulla natura della tirannia: se l’efficacia nel garantire la stabilità può, in certi contesti, sembrare giustificare metodi autoritari, come si concilia questa visione pragmatica con le definizioni morali e giuridiche precedentemente esposte? Per approfondire questa tensione tra necessità, legittimità e abuso di potere, è utile esplorare la filosofia politica del Rinascimento, in particolare il pensiero di autori come Machiavelli, e studiare la storia politica e giuridica del periodo delle Signorie, confrontando le analisi dei giuristi con le cronache dell’epoca.3. Il Potere Nascosto e le Parole del Dominio
Alla metà del Trecento, dopo la morte dell’arcivescovo Giovanni Visconti, i suoi nipoti Matteo, Bernabò e Galeazzo lo ricordano con un epitaffio che lo chiama “grande e potente tiranno”. Questa scelta di usare la parola ‘tiranno’ è importante, perché in quel periodo si discuteva molto e si criticavano i signori che governavano le città.Il Doppio Significato di “Tiranno”
La parola ‘tyrannus’ aveva un significato antico con due facce: poteva voler dire semplicemente ‘re’ o ‘signore forte’, come spiegavano studiosi del passato come Isidoro di Siviglia e Uguccione da Pisa, ma poteva anche indicare un governante ingiusto e crudele. I Visconti, forse ispirati da Petrarca, usano questa doppia natura del termine per dargli un significato nuovo, legandolo all’idea di forza e di un potere legittimo, non di un governo ingiusto. Era un modo per difendersi dalle accuse che venivano da fuori.La Legge Definisce il “Tiranno”
Verso la fine del Trecento, le cose cambiano. Bartolo da Sassoferrato, un importante giurista, scrive un testo intitolato De tyranno. Qui, Bartolo dà una definizione precisa e legale di tirannia. Distingue tra chi governa senza avere un diritto riconosciuto e chi invece esercita il potere in modo ingiusto, anche se magari avrebbe un titolo valido. Questa distinzione rende il confine più netto e la parola ‘tiranno’ inizia ad avere quasi solo un significato negativo. Per questo, la propaganda dei Visconti smette di giocare sul doppio senso della parola e preferisce esaltare l’idea di pace e ordine portati dal loro governo.Il Potere Nascosto: La “Tirannide Velata”
Bartolo da Sassoferrato individua anche un tipo di tirannia meno visibile, che lui chiama “tirannide velata”. Questo potere non si mostra apertamente, non ha un titolo chiaro, ma si esercita manipolando dall’interno le istituzioni e le regole che già esistono nelle città. Questo tipo di tiranno agisce nell’ombra, rendendo difficile capire chi detiene davvero il potere.Esempi di Governo Nascosto
Nella storia ci sono esempi di questa forma di potere. I Trinci a Foligno, per esempio, rafforzano il loro controllo sulla città mantenendo in apparenza le vecchie strutture comunali. Anche Lalle Camponeschi all’Aquila governa di fatto la città, pur essendoci formalmente altre autorità, sia del re che del Comune. Questi casi mostrano che il potere dei signori spesso non nasce all’improvviso, ma si afferma piano piano, controllando le cariche pubbliche della città dall’interno, prima di dichiararsi apertamente. Rappresentano una fase di passaggio, un momento incerto tra il governo dei Comuni e l’affermazione delle Signorie.Davvero l’analisi dei soli modelli narrativi esaurisce il ruolo politico delle cronache sulla tirannia?
Il capitolo illustra efficacemente come i cronisti medievali attingessero a modelli preesistenti per descrivere la figura del tiranno, mostrando le diverse fonti e strategie narrative impiegate. Tuttavia, concentrarsi prevalentemente sui “modelli narrativi” rischia di sottovalutare la funzione attiva e l’impatto politico di queste cronache. Non erano semplici descrizioni passive, ma strumenti potenti utilizzati nel vivo delle lotte politiche per legittimare o delegittimare il potere, influenzare l’opinione pubblica e giustificare azioni. Per comprendere appieno questo aspetto, è cruciale integrare l’analisi retorica con lo studio della storia politica e sociale del periodo, indagando il contesto di produzione e ricezione di questi testi. Approfondire la storia del pensiero politico medievale e il ruolo degli intellettuali nelle dinamiche comunali e signorili, consultando autori che si sono dedicati a questi temi, può offrire una prospettiva più completa sul peso reale di queste narrazioni.6. La Bestia e il Banchetto
La figura del tiranno nel Trecento è vista come strettamente legata all’idea di bestialità e antropofagia. Questa associazione affonda le sue radici in miti antichi, come quello greco di Licaone, che venne trasformato in lupo per aver osato offrire carne umana al dio Giove. Il tiranno è perciò immaginato come un lupo, una figura insidiosa che divora e opprime il suo “gregge”, ovvero i sudditi posti sotto il suo dominio.La natura bestiale del tiranno
Il tiranno è caratterizzato da vizi che lo rendono “salvatico” e privo di ragione, spingendolo ad agire in modo bestiale. Tra questi vizi si annoverano la superbia, l’avarizia, la lussuria, la gola e l’ira. Questi istinti perversi lo allontanano dalla natura umana e lo rendono simile a una bestia. Le descrizioni fisiche dei tiranni spesso riflettono questa natura interiore, raffigurandoli come figure brutali, talvolta pelose, o con ventri enormi. Questi tratti fisici simboleggiano i loro appetiti smodati, che non si limitano al cibo, ma si estendono in modo insaziabile al potere e alla lussuria, divorando tutto ciò che incontrano sul loro cammino.La vendetta del popolo: il contrappasso
L’attitudine del tiranno a “divorare” si manifesta in modo metaforico nel suo abuso di potere, che consuma la libertà e le sostanze dei cittadini. Questa “bestialità” è considerata innaturale e contraria all’ordine stabilito, poiché l’uomo che cede a tali istinti si allontana dalla ragione. La reazione a questa oppressione sfrenata può culminare in una vendetta cruenta da parte del popolo. In diversi episodi storici del Trecento, la folla si rivolta contro il tiranno o i suoi rappresentanti, arrivando a compiere atti di cannibalismo rituale. Esempi di questa reazione includono la folla che a Montepulciano divora parti del corpo di Giacomo del Pecora, o quella che a Firenze fa lo stesso con Guglielmo d’Assisi, o ancora il caso di Tommaso da Tortona a Ferrara. Questi atti non sono pura violenza, ma assumono il significato di un contrappasso: il tiranno che ha “divorato” la comunità viene a sua volta divorato da essa. Questo rovesciamento simbolico degrada il potente, riducendolo a mera materia animale e rivelando così la sua vera natura bestiale, un atto che viene spesso interpretato come una punizione voluta dal cielo per ristabilire l’ordine sociale violato.Ma l’interpretazione del cannibalismo popolare come mero “contrappasso” simbolico non rischia di semplificare eccessivamente la complessità storica di tali atti estremi?
Il capitolo offre un’interpretazione affascinante e potente degli episodi di cannibalismo rituale come diretta risposta simbolica alla “bestialità” e al “divorare” del tiranno, configurandoli come un contrappasso quasi teologico o morale. Tuttavia, atti di violenza popolare così radicali, per quanto intrisi di simbolismo, affondano spesso le radici in un contesto storico, sociale ed emotivo ben più stratificato. Presentare il contrappasso come l’unica o principale chiave di lettura potrebbe trascurare altre motivazioni cruciali, come la rabbia accumulata, il desiderio di umiliazione totale del nemico, la riaffermazione violenta del controllo popolare sul corpo politico (e fisico) del potere rovesciato, o persino elementi di ritualità arcaica o di giustizia sommaria non riducibili esclusivamente al simbolismo del “divorare”. Per cogliere appieno la portata di questi eventi, sarebbe utile approfondire la storia sociale delle rivolte urbane nel Trecento italiano, esplorare studi di antropologia storica sulla violenza e sui rituali punitivi, e confrontarsi con storici che hanno analizzato specificamente questi episodi nel loro contesto immediato, al di là della pur valida lettura simbolica offerta dal capitolo.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]