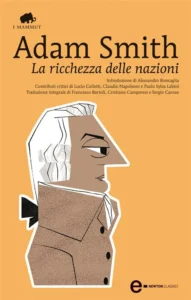Contenuti del libro
Informazioni
“Teoria dei sentimenti morali” di Adam Smith è un libro pazzesco che cerca di capire come facciamo a distinguere il bene dal male. Non è una storia con personaggi, ma un viaggio nella mente umana e nelle nostre interazioni sociali. Smith dice che tutto parte dalla simpatia, quella capacità di metterci nei panni degli altri e sentire qualcosa di simile a quello che provano loro. È come avere uno specchio sociale. Il nostro giudizio morale nasce confrontando quello che sentiamo noi con quello che sentono gli altri, o meglio, con quello che sentirebbe uno spettatore imparziale dentro di noi. Questo giudice interiore ci aiuta a capire se le nostre passioni e azioni sono appropriate. Il libro esplora virtù come la giustizia e la benevolenza, il senso del dovere, l’importanza dell’autocontrollo e come anche cose come l’utilità o la consuetudine influenzino i nostri giudizi. È una filosofia morale che ti fa pensare a come la società ci modelli e a cosa significhi davvero essere virtuosi.Riassunto Breve
Il giudizio morale nasce dalla capacità umana di partecipare ai sentimenti altrui, un processo chiamato simpatia. Questa partecipazione immaginaria, sebbene non replichi l’intensità dell’emozione originale, permette di concepire qualcosa di simile. L’appropriatezza delle passioni altrui si valuta confrontando l’emozione originale con l’emozione simpatetica dello spettatore: la concordanza porta all’approvazione, la dissonanza alla disapprovazione. Questo richiede uno sforzo reciproco di immedesimazione e moderazione. Diverse passioni suscitano gradi diversi di simpatia; quelle sociali godono di simpatia raddoppiata, quelle asociali dividono, quelle corporee ne ottengono poca. La simpatia per la gioia è più forte di quella per la sofferenza, spingendo a ostentare la prosperità e nascondere la miseria, il che può portare a valorizzare lo status esteriore più della virtù. Il merito e il demerito delle azioni dipendono dai sentimenti che esse suscitano in uno spettatore imparziale, basati sulla simpatia per la gratitudine del beneficiato o il risentimento della vittima, a condizione che i motivi dell’agente siano approvati. La beneficenza è una virtù libera e non coercibile, mentre la giustizia, che impedisce il danno, è essenziale per la società e la sua violazione merita punizione. Le conseguenze effettive delle azioni influenzano il giudizio di merito o demerito, anche se le intenzioni erano le stesse, un’irregolarità che però serve a dirigere l’azione e la punizione verso danni reali. Giudicare la propria condotta implica guardarsi con gli occhi degli altri, mettendosi nei panni di uno spettatore imparziale. Si desidera essere degni di lode, non solo riceverla, e l’autoapprovazione deriva da questo senso di dignità. L’immaginario spettatore imparziale agisce come giudice interiore, correggendo l’amor di sé e spingendo a sacrificare interessi personali per quelli maggiori altrui. Le regole morali generali si formano osservando ciò che suscita approvazione o disapprovazione e il rispetto per queste regole costituisce il senso del dovere, rafforzato dalla religione. L’utilità contribuisce all’approvazione di oggetti e sistemi, e questa ammirazione per l’adeguatezza dei mezzi stimola l’industria umana. Anche caratteri e azioni sono valutati per la loro utilità, ma l’approvazione morale deriva primariamente dall’appropriatezza. La consuetudine e la moda influenzano i giudizi morali, modificando il grado di approvazione per certe qualità, ma non possono corrompere completamente i principi fondamentali. La benevolenza segue un ordine naturale, dando priorità a sé, poi alla famiglia, agli amici, alla patria e infine all’umanità. La virtù richiede il dominio delle passioni, che lo spettatore imparziale giudica per la loro appropriatezza. Diverse teorie identificano la virtù con l’appropriatezza, la prudenza o la sola benevolenza. L’origine del principio che porta al giudizio morale è dibattuta, ma sembra derivare da un sentimento immediato, basato sulla simpatia, piuttosto che unicamente dall’amor di sé o dalla ragione. Le regole pratiche della moralità si dividono tra l’etica, che descrive le virtù in modo generale, e la giurisprudenza, che cerca regole precise, specialmente per la giustizia.Riassunto Lungo
1. La Simpatia come Specchio del Giudizio Morale
Gli esseri umani possiedono una naturale capacità di partecipare alle fortune e alle sventure altrui, un sentimento chiamato simpatia. Questa capacità deriva dall’immaginare sé stessi nella situazione dell’altra persona, replicando mentalmente le sensazioni che si proverebbero. Sebbene l’esperienza diretta delle emozioni altrui sia impossibile, l’immaginazione permette di concepire qualcosa di simile, anche se di intensità minore. Il giudizio sull’appropriatezza delle passioni altrui si basa sulla concordanza tra l’emozione originale e l’emozione simpatetica dello spettatore. Quando i sentimenti di un individuo corrispondono a ciò che lo spettatore sentirebbe nella stessa situazione, essi appaiono appropriati e giusti. Al contrario, una dissonanza porta alla disapprovazione. Questa corrispondenza si ottiene attraverso uno sforzo reciproco: lo spettatore cerca di immedesimarsi, mentre la persona coinvolta modera la propria passione per renderla condivisibile. È attraverso questo delicato equilibrio che si forma l’approvazione o la disapprovazione morale.Come la simpatia varia per diverse passioni
Diverse passioni suscitano gradi diversi di simpatia. Le passioni legate al corpo, come la fame o il dolore fisico, ottengono poca simpatia perché non è facile replicare la sensazione fisica negli altri. Le passioni legate all’immaginazione, come l’amore o l’ambizione, ne ottengono di più, essendo più accessibili alla condivisione mentale. Le passioni asociali, come l’odio o il risentimento, sono sgradevoli e la simpatia che suscitano è spesso divisa o riluttante. Al contrario, le passioni sociali, come la benevolenza o l’amicizia, sono piacevoli e godono di una simpatia raddoppiata, rafforzando i legami tra le persone.Simpatia, Apparenza Sociale e Rischio Morale
La simpatia per la gioia è generalmente più forte e completa di quella per la sofferenza. È più facile per gli altri condividere la felicità di una persona rispetto al suo dolore profondo. Questa tendenza naturale porta gli individui a ostentare la ricchezza e nascondere la povertà. La prosperità attrae simpatia e attenzione positiva da parte degli altri, mentre la miseria può suscitare disprezzo o indifferenza. Il desiderio di essere ammirati e approvati, che si manifesta spesso nel perseguimento di ricchezza e potere, diventa così una causa significativa di corruzione morale. Questo accade perché si tende a valorizzare lo status sociale e le qualità esteriori più della virtù interiore e del merito reale di una persona.Ma la simpatia è davvero il fondamento ultimo del giudizio morale, o non è piuttosto solo uno dei tanti fattori in gioco?
Il capitolo presenta la simpatia, intesa come la capacità di immedesimarsi nelle emozioni altrui, come la base su cui si costruisce l’approvazione o la disapprovazione morale. Tuttavia, questa visione potrebbe non considerare adeguatamente altre possibili fonti del giudizio etico. Per approfondire questa questione, sarebbe utile esplorare diverse teorie etiche che pongono l’accento sulla ragione, sul dovere o sulle conseguenze delle azioni, piuttosto che sulla sola risposta emotiva o simpatetica. Discipline come la filosofia morale e la psicologia dello sviluppo morale offrono prospettive alternative e complementari. Autori come Immanuel Kant, ad esempio, propongono un’etica basata sulla ragione e sul dovere, offrendo un forte contrasto con un approccio fondato sulla simpatia. Approfondire questi studi può aiutare a comprendere se la simpatia sia effettivamente il motore primario del giudizio morale o solo uno degli elementi che contribuiscono a formarlo.2. Sentimenti, Giustizia e l’Impronta del Caso
Come giudichiamo le azioni: Merito e Demerito
Il modo in cui giudichiamo le azioni, decidendo se meritano lode o biasimo, dipende dai sentimenti che queste azioni suscitano in chi le osserva in modo imparziale. Un’azione è considerata meritevole di ricompensa se genera una gratitudine che uno spettatore esterno può comprendere e condividere. Al contrario, un’azione merita punizione se provoca un risentimento che lo stesso spettatore imparziale può sentire come giusto e condivisibile. La capacità di provare simpatia per la gratitudine di chi ha ricevuto un beneficio si manifesta pienamente solo se approviamo le ragioni e le intenzioni di chi ha compiuto l’azione. Se i motivi non ci sembrano giusti o appropriati, la gratitudine che sentiamo e il merito che attribuiamo all’azione diminuiscono. Allo stesso modo, la nostra simpatia per il risentimento di chi ha subito un danno si attiva completamente solo se disapproviamo con forza le ragioni di chi ha causato quel danno. Se invece i motivi dell’agente ci sembrano in qualche modo giustificati o appropriati, il risentimento che proviamo e il demerito che attribuiamo all’azione non sorgono o sono molto attenuati. Quindi, il senso che un’azione sia meritevole nasce dalla nostra approvazione per le intenzioni di chi agisce e dalla nostra condivisione della gratitudine di chi ne trae beneficio. Il senso che un’azione sia demeritevole deriva dalla nostra disapprovazione per le intenzioni di chi agisce e dalla nostra condivisione del risentimento di chi ne è vittima.Beneficenza e Giustizia: Due Virtù Distinte
Esiste una differenza fondamentale tra l’agire per fare del bene, che chiamiamo beneficenza, e l’astenersi dal fare del male, che è il campo della giustizia. La beneficenza è una virtù che si manifesta liberamente, non può essere imposta con la forza sugli individui. La sua assenza, infatti, non provoca un danno diretto e tangibile a nessuno; al massimo, può suscitare disapprovazione, ma non merita una punizione vera e propria. La giustizia, al contrario, è considerata essenziale per la sopravvivenza e la stabilità della società. Violare i principi di giustizia significa causare un danno concreto e positivo agli altri, e per questo motivo tale violazione merita risentimento e, di conseguenza, punizione. È per questo che la forza può essere legittimamente impiegata per garantire il rispetto della giustizia e impedire che si arrechi danno, mentre non è accettabile usarla per costringere qualcuno a compiere atti di beneficenza.L’Influenza del Caso nelle Nostre Valutazioni
C’è un aspetto particolare e, a prima vista, non del tutto logico nel modo in cui giudichiamo le azioni umane: spesso, il nostro senso di quanto un’azione sia meritevole o demeritevole viene influenzato dalle conseguenze effettive che essa produce, anche se le intenzioni di chi ha agito erano le stesse. Ad esempio, un tentativo sincero di fare del bene che, per sfortuna, non riesce a produrre il risultato sperato, tende ad essere considerato meno meritevole rispetto a un’azione analoga che invece ha successo. Allo stesso modo, chi tenta di fare del male ma fallisce nel suo intento, suscita un senso di demerito inferiore rispetto a chi causa effettivamente un danno concreto, anche se l’intenzione di nuocere era identica in entrambi i casi. Questa dipendenza dalla fortuna, o dal caso, nel giudizio morale può apparire ingiusta. Tuttavia, essa sembra rispondere a uno scopo preciso e naturale: spinge gli individui a non limitarsi alla buona intenzione, ma a impegnarsi attivamente affinché le loro azioni benefiche abbiano successo. Inoltre, dirige la nostra indignazione e la nostra volontà di punire principalmente verso quelle azioni che non solo sono motivate dall’intenzione di nuocere, ma che causano o tentano seriamente di causare un danno reale e tangibile. Questo meccanismo contribuisce a proteggere la società, focalizzando l’attenzione e la reazione su ciò che produce effetti negativi concreti e, al tempo stesso, insegna agli individui a essere prudenti e attenti alle possibili conseguenze dei loro atti. È per questo motivo che, nel sistema delle leggi umane, non sono le mere intenzioni malvagie ad essere punite, ma unicamente le azioni che si traducono in un danno effettivo o in un tentativo concreto di provocarlo.È davvero accettabile che il giudizio morale dipenda dalla fortuna, o dovremmo giudicare le azioni unicamente in base alle intenzioni di chi agisce?
Il capitolo, pur riconoscendo l’apparente illogicità e ingiustizia, giustifica l’influenza delle conseguenze effettive sul giudizio morale con ragioni pratiche legate alla protezione della società e all’incentivo ad agire con efficacia. Tuttavia, questo solleva un problema classico della filosofia morale: la “fortuna morale”. Se il valore morale di un’azione è intrinsecamente legato all’intenzione, come possono fattori esterni e incontrollabili alterare il nostro giudizio di merito o demerito? Per esplorare questa tensione, è utile confrontare l’approccio qui presentato, che sembra dare peso sia alle intenzioni (approvazione/disapprovazione) sia alle conseguenze (effetti reali), con teorie etiche che privilegiano nettamente l’uno o l’altro aspetto. Approfondire il pensiero di autori come Immanuel Kant, che pone l’intenzione e il dovere al centro della morale, o studiare le diverse forme di consequenzialismo, può aiutare a comprendere i termini del dibattito. Inoltre, leggere filosofi contemporanei che hanno affrontato specificamente il problema della fortuna morale può fornire ulteriori prospettive su questa apparente irrazionalità nel nostro modo di giudicare.3. L’occhio interiore e le regole del comportamento
Giudicare la propria condotta e i propri sentimenti avviene guardandosi con gli occhi degli altri. Questo processo si basa sulla capacità di mettersi nei panni di uno spettatore imparziale. La società è fondamentale per sviluppare questa capacità, fungendo da specchio che rivela l’appropriatezza o meno delle nostre passioni e azioni. Questo spettatore immaginario, l’uomo interiore, agisce come giudice della nostra condotta. È lui che corregge la naturale tendenza dell’amor di sé a sopravvalutare i propri interessi, mostrandoci la piccolezza del nostro io rispetto agli altri e spingendoci a sacrificare i nostri interessi per quelli maggiori altrui.
Il desiderio di essere degni
Si desidera non solo ricevere lode, ma essere degni di lode, cioè essere un oggetto naturale e appropriato di approvazione. Questo desiderio di essere degni è un principio distinto e spesso più forte del semplice desiderio di lode. L’autoapprovazione deriva dal sentirsi degni di lode, anche senza riceverla effettivamente. Al contrario, il timore di essere degni di biasimo, il rimorso, è un tormento interiore potente, indipendente dal biasimo esterno.
La formazione delle regole morali
Le regole generali della moralità si formano osservando quali azioni negli altri suscitano approvazione o disapprovazione. Queste regole non sono la base originaria del giudizio, ma derivano dall’esperienza di tali reazioni. Una volta stabilite, queste regole guidano il senso del dovere e aiutano a correggere l’autoinganno, specialmente nel momento dell’azione, quando le passioni distorcono la prospettiva. Il rispetto per queste regole generali costituisce il senso del dovere, un principio essenziale per una condotta affidabile. La religione rafforza questo senso, presentando le regole morali come comandi divini, promettendo ricompense e punizioni in una vita futura.
Dovere e virtù diverse
L’influenza del senso del dovere varia a seconda della virtù. Per le virtù benevole come gratitudine e carità, l’azione dovrebbe scaturire anche dall’affezione stessa, con il dovere che funge da guida o limite. Per le passioni negative come il risentimento o gli interessi egoistici ordinari, il dovere è il principio principale. Le regole della giustizia sono precise e richiedono una stretta aderenza basata sul dovere. Le regole di altre virtù sono meno precise, richiedendo un senso di appropriatezza più che una rigida osservanza. Agire per un senso del dovere errato, la cosiddetta falsa coscienza, può portare a gravi errori, ma l’intenzione di seguire il dovere mantiene un certo rispetto, sebbene l’azione non sia approvabile.
Ma se nessuna delle antiche risposte sulla virtù è completa, come possiamo sperare di comprenderla oggi senza una sintesi o uno sguardo alle sfide contemporanee?
Il capitolo presenta efficacemente diverse prospettive storiche sulla virtù, ma l’analisi delle limitazioni di ciascuna teoria lascia aperta la questione di come si possa giungere a una comprensione più completa. Per colmare questa lacuna, sarebbe utile esplorare i tentativi di sintesi o le nuove definizioni di virtù emerse nella filosofia morale contemporanea. Approfondire autori che hanno rivitalizzato la virtù etica o l’hanno posta in dialogo con altre correnti di pensiero, come MacIntyre o Nussbaum, o considerare le prospettive della psicologia morale, può offrire strumenti per affrontare la complessità del concetto nel mondo attuale.7. Le Origini del Giudizio Morale e le Regole della Condotta
Ci si chiede spesso quale sia il motivo per cui approviamo o meno i comportamenti delle persone, distinguendo ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Su questo punto, sono state proposte principalmente tre spiegazioni. Alcuni pensano che dipenda dall’amore per noi stessi, altri dalla ragione, e altri ancora da un sentimento immediato che proviamo.Le teorie sull’origine del giudizio morale
Una teoria, sostenuta da pensatori come Hobbes, dice che approviamo le azioni che ci garantiscono sicurezza e benessere nella società. Vediamo la virtù come qualcosa di utile per l’ordine sociale, che alla fine ci avvantaggia. Però, questa idea non spiega perché approviamo azioni virtuose fatte molto tempo fa o in luoghi lontani che non ci toccano direttamente. In questi casi, l’approvazione sembra nascere da una forma di simpatia per chi ha ricevuto un beneficio. La simpatia, che ci porta a metterci nei panni degli altri e a sentire con loro, non è un sentimento egoistico.Un’altra teoria sostiene che la ragione sia lo strumento che ci permette di distinguere il giusto dall’ingiusto. La ragione è certamente fondamentale per creare regole morali generali basate sull’esperienza. Tuttavia, le prime volte che sentiamo di approvare o disapprovare qualcosa in situazioni specifiche, questo nasce da un senso o sentimento immediato. La ragione può farci capire che un oggetto è utile, ma solo il sentimento ci fa provare piacere o dispiacere per esso in sé.Anche le teorie basate sul sentimento si dividono. Alcune parlano di un “senso morale” specifico, come se fosse un senso fisico, capace di percepire le qualità morali. Questa idea presenta delle difficoltà, perché i sentimenti morali stessi vengono giudicati come buoni o cattivi. Inoltre, l’approvazione di diverse virtù genera emozioni molto differenti, non una sola sensazione particolare. Un’altra spiegazione basata sul sentimento usa il concetto di simpatia, estendendolo anche all’utilità delle azioni.Le regole pratiche della moralità
Quando si parla di regole pratiche per comportarsi in modo morale, ci sono due modi di affrontare la questione. I pensatori antichi descrivevano le virtù in modo generale, concentrandosi sul sentimento interiore e sul comportamento tipico di una persona virtuosa. Questo approccio è chiamato etica e ha lo scopo di ispirare le persone. I casisti e i giuristi naturali, invece, cercano di stabilire regole morali precise.Le regole che riguardano la giustizia sono precise, ma quelle relative ad altre virtù sono più difficili da definire con esattezza. La casistica è nata dalla pratica della confessione e cercava di dare regole esatte per guidare la coscienza, soprattutto per quanto riguarda la giustizia, la castità e la sincerità. La giurisprudenza si occupa delle regole che possono essere applicate per legge. Spesso la casistica non riesce a fornire regole precise dove solo il sentimento può dare un giudizio, risultando inutile e a volte dannosa. L’etica e la giurisprudenza naturale sono considerate le parti più utili della filosofia morale.Il capitolo non trascura forse che la moralità non è solo questione di ‘sentimento’ o ‘ragione’, ma anche il prodotto di millenni di evoluzione e condizionamento sociale?
Il capitolo presenta le origini del giudizio morale attraverso un dibattito filosofico classico, concentrandosi su ragione, sentimento e interesse personale. Tuttavia, l’argomentazione appare limitata se non si considera come le nostre capacità morali si siano sviluppate nel tempo e come siano plasmate dall’ambiente culturale. Per ottenere una visione più completa, sarebbe utile esplorare le prospettive offerte dalla psicologia evoluzionista e dall’antropologia, che studiano le basi biologiche e culturali del comportamento morale. Autori come Jonathan Haidt o Frans de Waal offrono spunti fondamentali per capire come le nostre intuizioni morali e i nostri sistemi etici siano radicati nella nostra storia naturale e sociale.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]