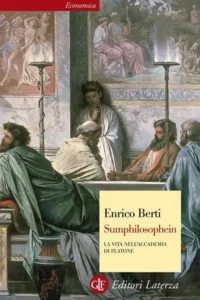Contenuti del libro
Informazioni
“Sumphilosophein. La vita nell’Accademia di Platone. Ediz. illustrata” di Enrico Berti ci porta nel cuore della filosofia greca antica, esplorando l’Accademia di Platone ad Atene. Questo libro non è solo una storia di idee, ma racconta la vita quotidiana, gli studi e i dibattiti che animavano questa scuola unica. Scopriamo come Platone fondò l’Accademia, un luogo di grande libertà intellettuale frequentato da menti brillanti come Aristotele, Speusippo e Senocrate, e persino donne come Lastenia e Assiotea. Il testo approfondisce temi centrali come la complessa dottrina delle Idee, le sfide che essa poneva e le diverse posizioni interne alla scuola, inclusa l’identificazione delle Idee con i numeri da parte di Senocrate e le critiche di Aristotele. Vediamo l’importanza della matematica greca e dell’astronomia antica, con i modelli cosmologici di Eudosso e le idee innovative di Eraclide Pontico per “salvare i fenomeni”. Il libro esplora anche i principi fondamentali della realtà secondo Platone (l’Uno e la Diade Indefinita) e le visioni alternative di Speusippo. Un aspetto affascinante è il dibattito etico sul piacere, con le posizioni di Eudosso e Speusippo. Infine, il testo evidenzia il forte impegno politico dell’Accademia, i tentativi di influenzare governanti a Siracusa e in Macedonia, e la rivalità con la scuola di Isocrate per la formazione dei leader. È un viaggio appassionante nella vita intellettuale e politica di un’epoca cruciale per la storia del pensiero.Riassunto Breve
Platone fonda la sua scuola ad Atene, nell’area dell’Accademia, un luogo pubblico con palestra e aree verdi. La scuola accoglie studenti e colleghi come Speusippo, Senocrate e Aristotele, inclusa la partecipazione di donne, cosa insolita per l’epoca. All’interno dell’Accademia c’è molta libertà di pensiero, permettendo ai discepoli di sviluppare idee proprie e criticare quelle del maestro. La successione alla guida della scuola avviene per elezione. L’Accademia non è solo un centro di studio ma ha anche legami politici, influenzando eventi a Siracusa e mantenendo rapporti con la corte macedone. Le attività principali si concentrano sulla matematica, vista come preparazione alla filosofia, e sulla formazione politica, con l’obiettivo di preparare futuri governanti. Lo studio della matematica include aritmetica, geometria e astronomia; in quest’ultima, Platone pone il problema di spiegare i moti apparenti dei pianeti con movimenti uniformi. Descrive l’universo come un animale sferico con la Terra immobile al centro e i corpi celesti che si muovono con moti complessi, misurabili matematicamente. I discepoli sviluppano modelli per spiegare questi moti, come quello di Eudosso basato su sfere concentriche, modificato poi da Callippo e Aristotele, che considera le sfere come corpi fisici. Nonostante questi modelli, sorgono problemi, come la mancata spiegazione delle variazioni di distanza dei pianeti. Vengono proposte alternative, come la rotazione della Terra sul proprio asse o l’orbita di Venere e Mercurio attorno al Sole. Un concetto centrale è la dottrina delle Idee, realtà universali, eterne e separate dal mondo sensibile, considerate la vera realtà e modelli per le cose sensibili. Le Idee sono viste come necessarie per la conoscenza e i valori, ma presentano difficoltà nel rapporto di “partecipazione” con le cose sensibili e problemi logici come il “terzo uomo”. All’interno dell’Accademia si dibatte sull’esistenza e la natura delle Idee; alcuni le rifiutano del tutto, altri le identificano con i numeri matematici. Platone identifica un principio supremo, l’Idea del Bene, fonte di tutto, e successivamente introduce i principi di Limite e Illimitato. Testimonianze orali parlano di due principi supremi: l’Uno e la Diade Indefinita, origine delle Idee e della realtà. Speusippo propone principi diversi per livelli distinti di realtà, negando l’identificazione dell’Uno con il Bene. Senocrate recupera i principi platonici, divinizzandoli e unificando la realtà. Aristotele critica le teorie a due principi e introduce materia, forma e privazione, oltre a quattro cause e un motore immobile come principio primo. Un altro dibattito interno riguarda il piacere e se sia il bene supremo; Eudosso lo afferma, Speusippo lo nega, mentre Platone e Aristotele propongono posizioni più sfumate, vedendo il piacere legato all’attività o come un bene ma non il supremo. L’Accademia si impegna attivamente nella politica, cercando di applicare le idee platoniche ad Atene e Siracusa, sebbene con risultati difficili. C’è una competizione con la scuola di Isocrate, che privilegia la retorica per la formazione politica, mentre l’Accademia insiste sulla filosofia e la scienza come base per il buon governo. Questa rivalità si estende all’influenza sui sovrani, mostrando il costante impegno politico dell’Accademia.Riassunto Lungo
1. La fondazione e la vita nell’Accademia di Platone
Al ritorno dai suoi viaggi, Platone decide di fondare la sua scuola ad Atene, scegliendo un’area chiamata Accademia. Questo luogo è un ginnasio situato appena fuori dalle mura della città, noto per la presenza di molti alberi. L’area dell’Accademia è molto vasta, di proprietà pubblica fin da tempi antichi, e include luoghi importanti come aree dedicate al culto e una palestra. Si trova precisamente a nord-ovest rispetto al centro di Atene. Platone stabilisce la scuola all’interno del ginnasio e sembra che abbia anche acquistato un terreno nelle vicinanze, dove costruisce un edificio che potrebbe essere stata la sua abitazione.Le persone che frequentavano l’Accademia
La scuola accoglie un gruppo variegato di persone, composto sia da studenti che da colleghi di Platone. Tra le figure più conosciute che hanno frequentato l’Accademia ci sono Speusippo, che era nipote di Platone e divenne il suo successore alla guida della scuola, e Senocrate, che succedette a Speusippo. Anche Aristotele trascorre un lungo periodo nell’Accademia, circa vent’anni, prima di fondare una sua scuola indipendente. Altri membri importanti sono Eraclide Pontico, Dione di Siracusa, ed Ermodoro. È interessante notare che l’Accademia era frequentata anche da donne, come Lastenia e Assiotea, che partecipavano alle attività in un modo considerato non convenzionale per l’epoca.Libertà di pensiero e confronto intellettuale
All’interno dell’Accademia si respirava un’atmosfera di notevole libertà di pensiero. Gli studenti erano incoraggiati a sviluppare le proprie idee, anche quando queste si discostavano dal pensiero di Platone. Ad esempio, Speusippo non accettava la dottrina delle Idee, e Aristotele criticava apertamente alcuni aspetti della filosofia platonica. Questa apertura al confronto intellettuale e la possibilità di sviluppare pensieri originali distinguevano l’Accademia da altre scuole del tempo. Nonostante le sue critiche su alcuni punti, Aristotele mantenne sempre un profondo rispetto per il suo maestro Platone.La successione alla guida e i legami esterni
Dopo la morte di Platone, la scelta del nuovo capo della scuola avveniva attraverso una sorta di elezione tra i membri. L’Accademia non era solo un centro di studio e discussione filosofica, ma aveva anche importanti legami politici esterni. Questo è evidente dal coinvolgimento di alcuni dei suoi membri nelle vicende politiche di Siracusa o dai rapporti che l’Accademia manteneva con la corte macedone. Questi collegamenti mostrano come l’influenza dell’Accademia andasse oltre il puro ambito filosofico e intellettuale.Se l’Accademia accoglieva donne in modo ‘non convenzionale’, cosa significa esattamente e perché il capitolo non spiega il contesto sociale che rendeva questa partecipazione così insolita?
Il capitolo accenna alla presenza di donne come Lastenia e Assiotea, definendone la partecipazione ‘non convenzionale’, ma non fornisce il necessario contesto storico-sociale. Per comprendere appieno la portata di questa affermazione, sarebbe fondamentale esplorare la condizione delle donne nell’antica Atene e le norme che regolavano la loro partecipazione alla vita pubblica e intellettuale. Approfondire la storia sociale greca e leggere autori che si occupano di studi di genere nell’antichità classica può aiutare a colmare questa lacuna.2. Le Attività dell’Accademia e il Cosmo di Platone
L’Accademia di Platone si concentra principalmente sullo studio della matematica e sulla preparazione alla vita politica. Le attività legate alla matematica comprendono discipline come l’aritmetica, la geometria, l’ottica e la meccanica. Platone propone problemi complessi che stimolano i matematici, come Eudosso, a cercare soluzioni, portando a significativi progressi in campi come la geometria e l’analisi matematica. Esiste una regola non scritta che impedisce l’accesso all’Accademia a chi non possiede conoscenze geometriche di base. Parallelamente, la formazione politica è uno scopo centrale, in linea con le idee esposte nella Repubblica. Molti discepoli di Platone si impegnano attivamente nella vita pubblica, diventando legislatori, strateghi o consiglieri di re, dimostrando l’importanza data alla preparazione di futuri governanti.Lo studio del cosmo
Un problema fondamentale posto da Platone riguarda l’astronomia: trovare modelli matematici basati su movimenti uniformi e ordinati che possano spiegare i moti apparenti e spesso irregolari dei pianeti. Questo obiettivo, noto come “salvare i fenomeni”, spinge la ricerca e porta alla nascita delle prime importanti teorie astronomiche nel mondo greco. Platone stesso descrive l’universo come un grande animale sferico e vivente, con la Terra immobile al suo centro. Il cielo, dove si trovano le stelle fisse, ruota intorno alla Terra con un movimento circolare regolare ogni giorno. Il Sole, la Luna e gli altri cinque pianeti visibili hanno movimenti aggiuntivi che sono più lenti e complessi, apparendo a volte irregolari. Nonostante siano descritti poeticamente come una sorta di “danza” celeste, Platone li considera movimenti misurabili attraverso calcoli matematici avanzati, accessibili solo a pochi esperti.L’educazione completa nell’Accademia
Le diverse attività svolte nell’Accademia, che vanno dalla classificazione logica delle idee alle indagini matematiche e alla formazione politica, si inseriscono in un unico progetto educativo. La matematica serve come preparazione essenziale per affrontare la filosofia, intesa come dialettica, che a sua volta è vista come la preparazione fondamentale per l’arte di governare la città. Per Platone, lo studio della matematica deve concentrarsi sulle realtà astratte e intelligibili, e non deve essere finalizzato alla risoluzione di problemi pratici o meccanici.Ma “salvare i fenomeni” da un cosmo geocentrico basta davvero a cogliere la realtà ultima?
Il capitolo individua correttamente nel “salvare i fenomeni” uno degli obiettivi centrali dell’astronomia platonica. Tuttavia, concentrarsi esclusivamente sulla creazione di modelli matematici che predicano le osservazioni, partendo da una struttura geocentrica, solleva interrogativi sulla finalità filosofica: si tratta solo di predizione, o di comprensione della realtà sottostante? Questo approccio, pur dominante per secoli, fu poi messo in discussione da modelli alternativi. Per approfondire questa tensione e il successivo cambiamento di paradigma, è utile esplorare la storia dell’astronomia e la filosofia della scienza. Figure chiave da considerare includono Aristotele (che perfezionò il modello geocentrico), Tolomeo (il cui sistema rappresentò l’apice del “salvare i fenomeni”), e figure successive come Copernico, Keplero e Galileo, il cui lavoro portò a una radicale ridefinizione della struttura cosmica e dello scopo stesso dell’indagine astronomica.3. Spiegare il cielo con le sfere e oltre
Eudosso di Cnido propose un modo per descrivere come si muovono gli astri nel cielo. Immaginò una serie di sfere, una dentro l’altra, tutte con la Terra ferma al centro. Per spiegare i movimenti del Sole e della Luna, pensò a tre sfere per ciascuno. Per i pianeti, che hanno moti più complessi, ne usò quattro. Ogni sfera ruotava su un proprio asse e con una velocità specifica. Mettendo insieme questi movimenti circolari, si potevano spiegare i percorsi visti nel cielo, inclusa la retrogradazione dei pianeti, che disegnano una forma chiamata “ippopede”. Nel sistema di Eudosso, c’erano in tutto 26 sfere per i sette corpi celesti che si potevano vedere a occhio nudo: Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno.I modelli basati sulle sfere concentriche
Callippo riprese il modello di Eudosso e lo rese più preciso per farlo corrispondere meglio a quello che si osservava. Aggiunse altre sfere: portò a cinque quelle per il Sole e la Luna, e anche per Mercurio, Venere e Marte. Mantenne invece quattro sfere per Giove e Saturno. Con queste aggiunte, il numero totale di sfere nel suo modello salì a 33. Aristotele, pensando a queste sfere non solo come strumenti matematici ma come veri e propri corpi fisici nel cielo, integrò ulteriormente queste teorie. Per assicurare che il movimento di un pianeta non disturbasse i movimenti dei pianeti più vicini alla Terra, introdusse delle sfere aggiuntive “retrograde” tra i gruppi di sfere di ogni astro. Questo portò il numero totale di sfere nel suo sistema a 47 o addirittura 55, a seconda di come si contava. Aristotele considerava l’astronomia una scienza importante che usava la matematica per studiare le sostanze eterne che componevano il cielo.Nonostante la complessità e l’ingegnosità di questi modelli basati sulle sfere concentriche, c’era un problema che non riuscivano a risolvere. Non spiegavano perché la luminosità e la dimensione apparente dei pianeti cambiassero nel tempo. Questo cambiamento suggeriva chiaramente che la distanza dei pianeti dalla Terra non era sempre la stessa, cosa impossibile in un sistema dove tutti i corpi si muovono su sfere perfette con la Terra immobile al centro.
Ipotesi alternative e nuove prospettive
Di fronte a queste difficoltà, emersero idee diverse. Eraclide Pontico, per esempio, propose un modo alternativo per spiegare il movimento quotidiano del cielo: suggerì che fosse la Terra stessa a ruotare sul proprio asse. Alcune fonti antiche suggeriscono anche che Eraclide potesse aver ipotizzato che Venere e Mercurio non girassero direttamente attorno alla Terra, ma piuttosto attorno al Sole, il quale a sua volta girava attorno alla Terra. Queste idee offrivano spiegazioni differenti per gli stessi fenomeni celesti e dimostrano che, già in quel tempo, si esploravano diverse ipotesi per cercare di “salvare i fenomeni”, cioè descrivere e prevedere accuratamente i movimenti osservati nel cielo.Se la politica si fonda sull’opinione e la retorica, come propone Isocrate, non rischia di diventare un mero gioco di persuasione privo di una solida base di giustizia o verità, a differenza della visione platonica?
Il capitolo descrive le differenze tra le scuole di Platone e Isocrate, ma non approfondisce il dibattito filosofico sulla natura della conoscenza politica e le implicazioni di fondare la leadership sull’opinione e la persuasione piuttosto che sulla conoscenza. Per esplorare a fondo questo cruciale contrasto, è utile approfondire la filosofia politica e l’etica, leggendo direttamente le opere di Platone, Aristotele e Isocrate.11. La gara per formare i re
Esiste una forte competizione tra l’Accademia fondata da Platone e la scuola di Isocrate, entrambe impegnate nell’educazione e nel tentativo di influenzare la vita politica del tempo. Questa rivalità non è solo accademica, ma rappresenta una vera e propria “gara per formare i re”, mirando a plasmare le menti di chi detiene il potere. Le due istituzioni si contendono il ruolo di guida intellettuale e morale, cercando di definire quale tipo di formazione sia la migliore per chi deve governare e guidare le città. Questa contesa riflette visioni del mondo e approcci all’educazione profondamente diversi. Entrambe le scuole aspirano a formare i futuri leader, ma propongono percorsi formativi e obiettivi politici distinti.Due vie all’educazione dei governanti
L’Accademia ritiene che la filosofia sia fondamentale per formare legislatori capaci e giusti. Anche discipline apparentemente teoriche come la geometria e l’astronomia sono considerate essenziali, perché aiutano a comprendere l’ordine del mondo e a legiferare in armonia con la natura e la verità. Secondo questa visione, solo una mente formata dalla saggezza filosofica può garantire la vera felicità della città. Isocrate, invece, pur riconoscendo un certo valore formativo a queste discipline, le considera solo una preparazione iniziale. Per lui, la retorica è lo strumento principale per la vita pratica e politica, indispensabile per persuadere e agire efficacemente negli affari pubblici.La lotta per l’influenza sui potenti
Questa competizione non rimane confinata alle aule scolastiche, ma si estende al tentativo di influenzare i sovrani e i potenti del tempo. La rivalità si manifesta chiaramente nei confronti dei sovrani di Cipro, a cui Isocrate dedica alcune delle sue orazioni più importanti. In risposta, Aristotele, allievo di Platone e membro dell’Accademia, indirizza a uno di questi sovrani il suo Protreptico, un’opera che è una forte esortazione a seguire la filosofia. Inizialmente, Aristotele critica duramente la retorica di Isocrate, arrivando a considerarla pura adulazione priva di sostanza, una critica che si riflette in un suo dialogo perduto intitolato Grillo. Tuttavia, Aristotele stesso inizia poi a insegnare retorica all’interno dell’Accademia, dimostrando che anche questo strumento può essere usato in modo filosoficamente fondato, in diretta concorrenza con l’approccio di Isocrate. La gara per l’influenza si estende anche ai re Macedoni, come Filippo e Alessandro. Discepoli diretti di Platone, come Speusippo e Senocrate, mantengono stretti rapporti con la corte macedone. Essi cercano di promuovere l’ideale accademico di formazione dei governanti, basato sulla saggezza filosofica, e talvolta prendono posizione su questioni politiche, criticando Isocrate o difendendo l’autonomia delle città greche di fronte al crescente potere macedone. L’Accademia dimostra così un impegno politico costante, mirando a formare leader capaci di guidare con saggezza e verità.Ma la contesa tra Accademia e Isocrate si riduce davvero a una semplice “gara per formare i re”?
Il capitolo descrive efficacemente la competizione per l’influenza politica, ma la narrazione potrebbe beneficiare di un’analisi più approfondita delle motivazioni intellettuali e filosofiche alla base delle diverse proposte educative. La distinzione netta tra l’approccio basato sulla filosofia e le scienze e quello incentrato sulla retorica, pur presente, meriterebbe di essere esplorata nelle sue implicazioni più profonde, al di là della mera efficacia pratica o della capacità di adulazione. Per cogliere la complessità di questa rivalità, è essenziale studiare direttamente le opere di autori come Platone, Isocrate e Aristotele, comprendendo le loro visioni del sapere, della virtù e del ruolo del cittadino nella polis.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]