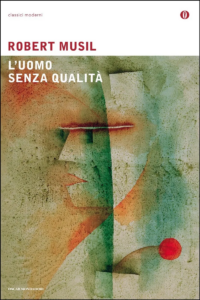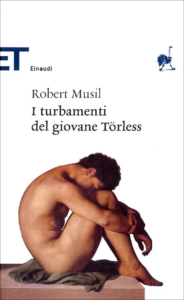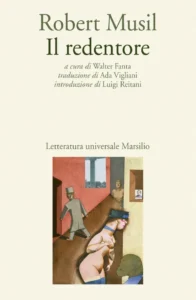Contenuti del libro
Informazioni
“Sulle teorie di Mach” di Robert Musil non è un romanzo, ma un testo dove Musil si confronta in modo super intelligente con le idee di Ernst Mach, un fisico e filosofo che ha un po’ scosso il pensiero scientifico del suo tempo. Questo libro esplora a fondo la visione di Mach sulla scienza, vista non tanto come una ricerca della verità assoluta, ma come uno strumento pratico, quasi “economico”, per organizzare i fatti e risparmiare fatica mentale. Musil analizza come Mach consideri i concetti fondamentali della fisica, tipo la massa o la causalità, non come realtà profonde, ma solo come modi utili per descrivere quello che osserviamo, quasi come delle scorciatoie. Viene fuori l’idea affascinante, ma anche un po’ strana, che il mondo sia fatto solo di “sensazioni” e che le leggi naturali siano più che altro delle nostre costruzioni per mettere ordine. Ma Musil non si limita a raccontare le teorie di Mach; le mette sotto la lente d’ingrandimento, cercando di capire se reggono, se ci sono punti deboli o contraddizioni, specialmente quando si parla della validità della conoscenza scientifica o della “necessità” in natura. È un viaggio nel cuore della filosofia della scienza e dell’epistemologia, dove si discute su cosa sia davvero la conoscenza e come funzionano i concetti scientifici, mostrando il dibattito intellettuale dell’epoca sulle fondamenta della fisica.Riassunto Breve
La scienza è considerata un fenomeno di adattamento economico e psicologico legato alla conservazione della vita, il cui scopo principale è organizzare i fatti per superare i limiti della memoria individuale. Questo processo, inizialmente pratico, si evolve verso interessi teorici che restano comunque riconducibili a bisogni biologici. L’applicazione dell’idea di evoluzione alla scienza implica che essa operi secondo i principi di continuità ed economia. La coscienza funziona economicamente fin dall’origine, reagendo a molti fatti in modo simile a gruppi affini per risparmiare sforzo, dando inizio alla vita concettuale. Successivamente, adatta le rappresentazioni esistenti ai nuovi fatti con il minimo cambiamento necessario, rispettando continuità e differenziazione sufficiente. Questi principi si applicano al pensiero scientifico, plasmando ipotesi, metodi e risultati come concetti e leggi, che condensano lavoro e informazioni. Tuttavia, considerare la scienza solo da questo punto di vista può portare a un’interpretazione scettica dove la verità è relativa e convenzionale. I principi di economia e continuità da soli non fondano la validità scientifica; sono criteri secondari per confrontare teorie già considerate vere. La fisica meccanica e i suoi concetti non hanno valore esplicativo intrinseco, ma servono come strumenti economici per organizzare i fatti osservabili. Le teorie sono mezzi, non fini. Le ipotesi sono descrizioni indirette basate su analogie, utili ma contenenti elementi superflui che possono portare a contraddizioni. Lo sviluppo scientifico tende a eliminare questi elementi, puntando a una descrizione diretta dei fatti. Concetti come massa, energia, spazio, tempo e movimento devono derivare il loro significato unicamente dall’esperienza e dalle relazioni osservabili; concetti assoluti non hanno base empirica. La scienza tradizionale cerca cause ultime, ma nella realtà non esistono ripetizioni esatte e la causalità isola arbitrariamente elementi da sistemi complessi. Le relazioni tra fenomeni sono molteplici e complicate, spesso reciproche e simultanee. Nelle scienze naturali avanzate, il concetto di causa ed effetto viene sostituito da quello di funzione, che descrive la dipendenza reciproca e misurabile tra gli elementi dei fenomeni tramite equazioni. Concetti come forza e sostanza vengono ridefiniti funzionalmente: la forza è una circostanza misurabile, la sostanza è la persistenza di gruppi di dipendenze funzionali. I concetti scientifici sono strumenti per organizzare le esperienze basati su queste relazioni funzionali. La necessità riconosciuta è solo quella logica, spesso intesa come abitudine psicologica derivata dall’esperienza; non esiste una necessità naturale o fisica. Spiegare un fenomeno significa ricondurlo a fatti noti per ordinarlo mentalmente in modo efficiente. Le leggi naturali sono strumenti pratici, idealizzazioni che introducono precisione e regolarità non presenti nella realtà sensibile; la necessità nelle leggi deriva dall’idealizzazione. Il mondo è composto unicamente da “elementi”, che sono sensazioni. Corpi o cose sono complessi stabili di queste sensazioni, utili abbreviazioni del pensiero. La distinzione tra fisico e psichico dipende dal tipo di connessione tra questi elementi, in relazione al nostro corpo. Gli elementi in sé sono neutri. Tuttavia, la negazione della necessità naturale sembra confondere la necessità interna ai modelli concettuali idealizzati con la regolarità osservata nei fatti stessi. La pratica scientifica spesso presuppone una regolarità e prevedibilità che contraddicono la negazione della necessità. La riduzione dei concetti scientifici a meri complessi di sensazioni è problematica, poiché i concetti fisici sono astratti e idealizzati, non direttamente sensibili. La distinzione tra sensazione e oggetto, e tra sensazioni proprie e altrui, appare radicata nell’esperienza stessa. Il sistema che tenta di eliminare la necessità naturale e ridurre la scienza a un’organizzazione economica delle sensazioni mostra contraddizioni interne.Riassunto Lungo
1. L’Economia della Scienza e la Questione della Verità
La scienza viene vista come un fenomeno di adattamento economico e psicologico, profondamente legato alla necessità di conservare la vita. Il suo scopo principale è mettere ordine nei fatti che osserviamo, superando così i limiti della memoria individuale. Questo processo, che inizia con esigenze pratiche, si sviluppa poi verso interessi più teorici, i quali tuttavia rimangono collegati a bisogni biologici fondamentali. Applicare l’idea di evoluzione alla scienza significa riconoscere che essa opera seguendo i principi di continuità ed economia.Come Funzionano i Principi nella Coscienza e nella Scienza
La coscienza stessa funziona come uno strumento economico fin dalle sue origini. Quando si trova di fronte a molti fatti simili, reagisce raggruppandoli, risparmiando così sforzo mentale; questo è il primo passo verso la formazione dei concetti. In seguito, la coscienza adatta le conoscenze che già possiede ai fatti nuovi con il minor cambiamento possibile, rispettando il principio di continuità o permanenza e aggiungendo solo la differenziazione sufficiente. Questo adattamento avviene sia confrontando pensieri e fatti (per riprodurre e anticipare la realtà) sia correggendo i pensieri tra loro per raggiungere un migliore equilibrio interno. I principi di economia e continuità si ritrovano anche nel pensiero scientifico più evoluto. La creazione di ipotesi, l’uso di strumenti matematici, i metodi di ricerca basati sulla variazione e il confronto, e i risultati stessi della scienza (concetti, leggi, teorie) mostrano chiaramente questo carattere economico. Le leggi naturali, ad esempio, ci evitano di dover conoscere ogni singolo evento, fornendo schemi generali, mentre i concetti condensano in sé molto lavoro e molte informazioni.Economia e la Ricerca della Verità
Tuttavia, considerare la scienza unicamente da un punto di vista storico, evolutivo, psicologico ed economico può portare a posizioni indifferenti o scettiche riguardo al concetto tradizionale di verità. L’interpretazione indifferente vede questi principi economici semplicemente come una descrizione del funzionamento della scienza, che esiste accanto alla ricerca sui veri criteri della verità. L’interpretazione scettica, invece, suggerisce che la conoscenza sia determinata solo da queste prospettive economiche o biologiche, implicando che la verità sia qualcosa di relativo e basato su convenzioni.I principi di economia e continuità, presi da soli, non bastano a garantire la validità della conoscenza scientifica. Essi non assicurano quell’univocità e quella determinatezza che la scienza stessa richiede per essere affidabile. L’idea di una “differenziazione sufficiente” o di un “adattamento sufficiente” implica necessariamente un accordo con i fatti osservati e l’assenza di contraddizioni interne, il che corrisponde esattamente alla nozione tradizionale di verità. L’economia diventa quindi un criterio utile, ma secondario, che serve a confrontare tra loro teorie che sono già state considerate vere, ma non può essere il fondamento su cui si basa la verità scientifica stessa.
Ma l’economia del pensiero garantisce davvero la “verità” nel senso tradizionale, o semplicemente l'”efficacia”?
Il capitolo, pur riconoscendo il rischio di scetticismo, sembra risolvere troppo rapidamente la tensione tra una visione economica/adattiva della conoscenza e la nozione tradizionale di verità. L’affermazione che una “differenziazione sufficiente” o un “adattamento sufficiente” implichi necessariamente l’accordo con i fatti e l’assenza di contraddizioni interne merita un approfondimento critico. Per esplorare questa complessa relazione, è utile confrontarsi con diverse correnti della filosofia della scienza e dell’epistemologia. Si possono approfondire le opere di autori come Ernst Mach, per comprendere meglio l’origine del principio di economia, e confrontarle con le posizioni del pragmatismo, ad esempio quelle di William James, che lega strettamente la verità all’utilità e all’efficacia pratica. Anche la lettura di Karl Popper può offrire una prospettiva diversa sul rapporto tra teoria, esperienza e criterio di verità scientifica.2. La Fisica dei Fatti e i Limiti dei Concetti
I concetti usati nella fisica, specialmente quella meccanica, non spiegano la realtà in modo profondo. Sono piuttosto strumenti pratici che ci aiutano a mettere in ordine e descrivere quello che vediamo. Per questo, l’obiettivo della conoscenza cambia: le teorie non sono il fine ultimo, ma solo un modo per gestire e comprendere i fenomeni che osserviamo.Un Cambiamento nella Scienza
Nel corso della storia della scienza, c’è stato un passaggio importante. All’inizio, si cercava di spiegare la realtà nascosta dietro i fenomeni osservati, come faceva ad esempio Huygens. Poi, l’attenzione si è spostata: si è iniziato a vedere le ipotesi scientifiche più come immagini o descrizioni utili e semplici, come nel caso di Maxwell e Hertz. Questo cambiamento è avvenuto perché le vecchie teorie basate sulla meccanica diventavano sempre più complicate e non riuscivano più a spiegare i nuovi fatti che venivano scoperti. Ernst Mach si trova proprio in mezzo a questa evoluzione del pensiero scientifico. Lui sostiene che diverse ipotesi, anche se sembrano contraddirsi tra loro, possono comunque spiegare gli stessi fatti osservabili. Questo rende impossibile dire quale sia l’ipotesi “vera” in assoluto.
Ipotesi e Descrizioni Dirette
Le ipotesi scientifiche sono un modo per descrivere le cose in maniera indiretta, spesso usando paragoni o analogie con quello che già conosciamo. Sono utili perché ci aiutano a collegare diverse conoscenze tra loro e a capire dove cercare nuove scoperte. Però, le ipotesi a volte includono dettagli che non sono davvero indispensabili per descrivere i fatti che vediamo. Questi dettagli extra possono creare confusioni o portare a contraddizioni. La scienza, nel suo progresso, cerca di eliminare questi elementi non necessari. L’obiettivo è arrivare a quella che viene chiamata “descrizione diretta”: un modo di esprimere i concetti che si basa solo sugli elementi essenziali e osservabili dei fatti.
Il Significato dei Concetti Fisici
Mach rivolge la sua attenzione critica a molti concetti fondamentali della fisica, come la massa, l’energia, lo spazio, il tempo e il movimento. Secondo lui, il significato di queste idee deve venire solo da quello che possiamo sperimentare e dalle relazioni che osserviamo tra le cose. Concetti come uno spazio assoluto o un tempo assoluto, che esistono indipendentemente da ciò che accade, non hanno una base che possiamo verificare con l’esperienza. Usarli significa andare oltre i limiti di ciò che possiamo davvero conoscere. La massa, per esempio, non è una proprietà misteriosa di un oggetto; per Mach, si definisce solo osservando come i corpi si accelerano l’un l’altro in certe situazioni.
I Limiti della Visione di Mach
Questa visione porta a pensare che i concetti scientifici debbano fermarsi a quello che possiamo verificare con l’esperienza diretta. Però, la critica di Mach sembra anche suggerire che non possiamo proprio creare o pensare concetti che vadano oltre quello che sentiamo o percepiamo subito con i sensi. Questa idea, che è più estrema e vicina al “sensismo”, non è dimostrata solo dal fatto che in passato alcune teorie scientifiche hanno fallito. Le difficoltà e i fallimenti del passato non significano automaticamente che sia impossibile creare concetti più astratti in futuro. L’idea di Mach diventa più convincente solo se la si considera all’interno della sua visione filosofica più generale.
Ma se i concetti scientifici si fermano all’esperienza diretta, come possiamo spiegare ciò che non vediamo?
Il capitolo presenta la visione di Mach, che lega strettamente il significato dei concetti fisici all’esperienza osservabile, criticando le nozioni astratte come lo spazio o il tempo assoluti. Tuttavia, il testo stesso riconosce che l’idea più estrema di Mach, vicina al sensismo, che sembrerebbe precludere concetti che vanno oltre la percezione immediata, non è necessariamente dimostrata dai fallimenti passati. Questo solleva un punto cruciale: la scienza moderna fa ampio uso di concetti che si riferiscono a entità o strutture non direttamente osservabili (come particelle subatomiche, campi quantistici, buchi neri). Come si concilia l’efficacia predittiva e esplicativa di queste teorie con una visione rigorosamente empirista come quella di Mach? Per approfondire questo dibattito fondamentale sul ruolo dell’osservazione, della teoria e dell’astrazione nella conoscenza scientifica, è essenziale esplorare la filosofia della scienza. Autori come Ernst Mach (per comprendere a fondo la sua posizione), Karl Popper, Pierre Duhem e Bas van Fraassen offrono prospettive diverse e complementari su questi temi.3. Il mondo come rete di funzioni
La scienza ha cercato a lungo di spiegare i cambiamenti naturali trovando cause ultime e immutabili. Questa ricerca si basava sull’idea che, in situazioni identiche, i risultati sarebbero sempre gli stessi. Questa impostazione cercava di isolare un singolo fattore come responsabile di un determinato effetto. Si credeva che ogni evento avesse una causa specifica e identificabile. Questo approccio ha guidato gran parte della ricerca scientifica per molto tempo.Perché la causalità non basta
Nella realtà, però, non esistono mai ripetizioni perfettamente identiche delle situazioni. L’idea di causa ed effetto implica di separare artificialmente alcuni elementi da un insieme molto più vasto e complesso di fatti interconnessi. Un’analisi più attenta dimostra che quella che chiamiamo causa è in realtà solo una parte di un sistema più ampio che contribuisce a determinare l’effetto osservato. Le relazioni tra i fenomeni naturali sono intricate e multiple, non semplici collegamenti isolati e lineari. Considerare solo una causa singola semplifica eccessivamente la complessità del mondo.Il concetto di funzione
Per questo motivo, nelle scienze naturali più avanzate, il concetto di causa ed effetto viene progressivamente sostituito dall’idea di funzione. Le funzioni servono a descrivere la dipendenza reciproca e misurabile che esiste tra i diversi elementi dei fenomeni studiati. Non si cerca più una causa unica, ma si analizza come le diverse grandezze si influenzano a vicenda. Questo approccio permette di cogliere la complessità delle interazioni in modo più preciso. Si passa da un modello lineare a uno basato sulle relazioni e interdipendenze.Le funzioni nella fisica
Molte relazioni fondamentali nella fisica sono reciproche e si verificano nello stesso istante, non in una sequenza temporale di causa che precede l’effetto. Ad esempio, quando due masse si attraggono, le loro accelerazioni si determinano reciprocamente nello stesso momento. Le equazioni fisiche esprimono proprio queste dipendenze funzionali, permettendo di calcolare il valore di una grandezza conoscendo quello di un’altra. Queste relazioni sono viste come collegamenti puramente logici, che descrivono come le cose stanno insieme, piuttosto che come una cosa ne provoca un’altra nel tempo. Questo superamento del concetto di causa lineare è fondamentale per comprendere i sistemi dinamici complessi.Ridefinire forza e sostanza
Anche concetti tradizionali come forza e sostanza vengono rivisti in questa prospettiva funzionale. La forza non è più vista come una causa nascosta che spinge le cose, ma come una circostanza misurabile, definita ad esempio come il prodotto di massa e accelerazione. La sostanza non è considerata qualcosa di fisso ed esistente di per sé, ma piuttosto la persistenza di specifici gruppi di dipendenze funzionali. Si tratta della costanza nel modo in cui osserviamo le reazioni e le interazioni. Quella che comunemente chiamiamo “cosa” è un’astrazione utile per indicare un insieme di relazioni relativamente stabili nel tempo.Strumenti scientifici e realtà
I concetti scientifici sono intesi come strumenti pratici per organizzare le nostre esperienze in modo efficace, basandosi su queste relazioni funzionali espresse in equazioni. Le equazioni stesse sono considerate come una forma abbreviata per indicare esperienze che sono state ordinate e comprese. Tuttavia, l’idea che le sole equazioni funzionali possano descrivere completamente la realtà è parziale. Alla connessione logica presente nelle equazioni corrisponde una dipendenza che esiste realmente nella natura stessa. Anche se i concetti tradizionali come causa e sostanza necessitano di essere ripensati, la base di fatti che suggerisce l’esistenza di qualcosa di persistente o di dipendenze con una direzione chiara e non sempre reciproca non può essere ignorata. I fenomeni osservati mostrano caratteristiche che suggeriscono l’esistenza di strutture o direzioni stabili, nonostante il mondo sia in continuo cambiamento e le relazioni siano complesse.[/membership]Se il mondo è una rete di funzioni, come si spiegano le ‘cose’ che persistono e le dipendenze non sempre reciproche che il capitolo stesso ammette?
Il capitolo descrive efficacemente il passaggio da un modello causale lineare a uno funzionale basato sulla dipendenza reciproca. Tuttavia, il riconoscimento finale che i fenomeni osservati mostrano caratteristiche di persistenza (le ‘cose’) e dipendenze con una direzione chiara, non sempre reciproca, crea una tensione logica. Come si concilia un modello puramente funzionale con queste osservazioni? Per esplorare questa apparente contraddizione e approfondire il dibattito sulla natura della realtà fisica e i limiti delle descrizioni scientifiche, è utile confrontarsi con autori che si occupano di filosofia della scienza, epistemologia e fondamenti della fisica, che discutono i concetti di causalità, emergenza e la relazione tra modelli matematici e realtà osservata.4. La Natura Senza Necessità e il Mondo di Sensazioni
Per Mach, non esiste una necessità naturale o fisica. La necessità che riconosciamo è solo logica, spesso vista come un’abitudine psicologica che deriva dall’esperienza. Spiegare un fenomeno significa ricondurlo a fatti semplici che conosciamo già. Questo processo scompone il fatto, rendendolo più facile da capire mentalmente. Non si tratta di scoprire cause profonde, ma di organizzare la nostra esperienza in modo pratico ed efficiente.La visione di Mach: Leggi e Elementi
Le leggi naturali sono considerate strumenti pratici. Possiamo pensarle come tabelle riassuntive o regole che ci permettono di riprodurre fatti che abbiamo osservato. Il loro valore è soprattutto pratico ed economico, perché aiutano a organizzare la memoria e a facilitare i calcoli. I concetti e le leggi scientifiche nascono da un processo in cui i fatti complessi vengono semplificati e resi ideali. La precisione e la regolarità perfette esistono solo in questi modelli concettuali idealizzati, non nella realtà che percepiamo con i sensi. La necessità che sembra presente nelle leggi è quindi qualcosa che introduciamo noi con l’idealizzazione, non è una proprietà intrinseca della natura stessa.Il mondo, secondo questa visione, è fatto unicamente di “elementi”. Questi elementi non sono altro che sensazioni: colori, suoni, pressioni e così via. Quello che chiamiamo corpi o cose sono semplicemente insiemi stabili di queste sensazioni, che usiamo come utili abbreviazioni nel nostro pensiero. La differenza tra ciò che consideriamo fisico e ciò che consideriamo psichico dipende da come questi elementi sono collegati tra loro. In particolare, dipende dalla loro relazione con gli elementi che formano il nostro corpo. Gli elementi in sé, presi singolarmente, sono considerati neutri, non sono né fisici né psichici.
Le difficoltà della teoria di Mach
La teoria di Mach, tuttavia, incontra diverse difficoltà. Negare la necessità naturale sembra confondere la necessità che troviamo dentro i modelli concettuali idealizzati con la regolarità che osserviamo nei fatti stessi. Inoltre, la pratica scientifica di Mach, e anche le sue stesse affermazioni, spesso presuppongono una regolarità e una prevedibilità nella natura. Questo va contro l’idea che non esista una necessità naturale. Questa contraddizione interna indebolisce la coerenza del suo sistema.Un altro punto debole è la riduzione dei concetti scientifici a semplici gruppi di sensazioni. I concetti usati nella fisica, infatti, sono astratti e idealizzati. Non sono qualcosa che possiamo percepire direttamente con i sensi. La fisica si basa su queste astrazioni per descrivere la realtà, e ridurle a mere sensazioni non sembra rendere giustizia al loro ruolo. Questo solleva dubbi sulla capacità della teoria di Mach di spiegare la natura dei concetti scientifici.
La distinzione tra le sensazioni che proviamo noi e quelle degli altri, e tra la sensazione stessa e l’oggetto che la causa, sembra essere radicata nella nostra esperienza quotidiana. Non appare come un semplice cambiamento di prospettiva, come suggerisce Mach. Questa distinzione fondamentale nella nostra percezione del mondo non è facilmente eliminabile o riducibile a una diversa organizzazione di elementi neutri. Il sistema di Mach fatica a rendere conto in modo convincente di questo aspetto basilare dell’esperienza umana. La nostra interazione con il mondo si basa su questa separazione tra chi percepisce, cosa è percepito e chi altro percepisce.
Ma se la necessità naturale non esiste, su cosa si fonda la ‘pratica scientifica’ che il capitolo stesso ammette presupporre regolarità?
Il capitolo mette in luce una contraddizione cruciale: la negazione della necessità naturale da parte di Mach cozza con la dipendenza della pratica scientifica dalla regolarità osservata. Questo solleva dubbi sulla coerenza interna del suo sistema e sulla sua capacità di fornire una base solida per l’impresa scientifica. Per approfondire questa problematica e capire come la scienza affronta la questione della regolarità, della causalità e della natura delle leggi, è utile esplorare la filosofia della scienza e l’epistemologia. Autori come Popper, che ha discusso i fondamenti della conoscenza scientifica e il problema dell’induzione, o studi sulla storia della fisica possono offrire prospettive diverse su come si costruiscono le leggi e i concetti scientifici al di là di una mera organizzazione di sensazioni.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]