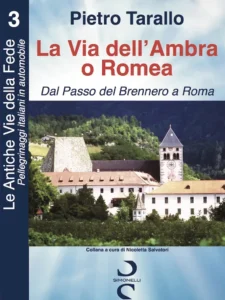1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Sulle Orme dei Normanni – da Palermo a Roma” di Pietro Tarallo non è la solita guida turistica, ma un invito a riscoprire l’Italia antica e spirituale, seguendo le Vie Romee che da secoli portano i pellegrini verso la Città Eterna. Questo libro ti prende per mano e ti guida in un viaggio che parte dalla Sicilia, terra segnata dalla storia dei Normanni e ricca di luoghi di fede e arte, come Palermo, Monreale o i siti archeologici di Selinunte e Segesta. Non si tratta solo di vedere, ma di vivere, di rallentare il passo per immergersi nelle tradizioni locali, cercare ospitalità monastica in antiche abbazie e santuari, e capire il profondo legame tra storia, arte e fede che ha plasmato il Sud Italia, dalla Calabria alla Campania, fino al Lazio e a Roma. Attraverso i racconti di antichi pellegrinaggi, il ruolo degli ordini religiosi come Benedettini e Cistercensi, e la scoperta di tesori nascosti lungo la Via Appia, capirai perché percorrere queste strade è un vero cammino spirituale, lontano dal turismo di massa, un’esperienza umana autentica che ti riconnette con te stesso e con secoli di storia e devozione.Riassunto Breve
Le antiche Vie Romee e altri percorsi storici in Italia tornano a essere importanti per chi cerca un’esperienza di viaggio diversa, più umana e spirituale rispetto al turismo di massa. Percorrere queste strade significa riscoprire la storia e il legame tra i popoli, preferendo strade statali e provinciali lente e panoramiche, esplorando paesi e città a piedi. Per l’alloggio si scelgono foresterie di monasteri o locande d’epoca, evitando strutture moderne, e per il cibo si privilegiano osterie locali con cucina tradizionale. Limitare l’uso del telefono aiuta a immergersi nei luoghi e a rallentare il ritmo. L’ospitalità nelle strutture religiose richiede contatto preventivo e rispetto degli orari e delle regole della comunità, come il silenzio e la pulizia, con soggiorni consigliati di almeno tre giorni e offerte libere per sostenere i religiosi.Il pellegrinaggio verso grandi centri come Roma, Gerusalemme e Santiago di Compostela è un fenomeno sociale con motivazioni diverse, dalla ricerca dell’indulgenza alla salvezza eterna, o anche per sostentamento e commercio. I viaggi erano pericolosi, ma col tempo le strade migliorano con infrastrutture come ospizi gestiti da religiosi per accogliere i pellegrini. Dal XIV secolo i pellegrinaggi diventano di massa, affiancati da percorsi minori verso santuari locali. Un evento centrale è il Giubileo, iniziato a Roma nel 1300 e celebrato con cadenza regolare, attirando grandi folle e riflettendo le vicende storiche.Molti pellegrini sono diventati santi, come Santa Brigida o San Rocco. Le antiche vie facilitavano questi spostamenti; dalla Sicilia, un flusso costante si dirigeva a nord verso Roma o la Terra Santa, usando percorsi come la Via Valeria. I re Normanni in Sicilia, come Ruggero II, favoriscono la convivenza di culture diverse e costruiscono centri di accoglienza. Lungo la via dalla Sicilia si incontrano importanti centri religiosi e artistici come Palermo con la Cappella Palatina e la Cattedrale, Monreale con il Duomo e Cefalù.La Sicilia occidentale offre un percorso ricco di storia e arte, toccando Alcamo con i suoi conventi, Castellammare del Golfo e Scopello sulla costa. Erice, borgo medievale in vetta, conserva mura antiche e chiese, noto per la pasticceria e l’artigianato. Trapani è una città costiera con vita religiosa intensa e musei. Proseguendo si incontrano lo Stagnone di Mozia con le saline, l’isola di Mothia con reperti fenici, Marsala famosa per il vino e Mazara del Vallo con il suo centro storico. Selinunte presenta un vasto parco archeologico, mentre Castelvetrano custodisce reperti nel museo civico. La valle del Belice, segnata dal terremoto, include il Cretto di Burri e Gibellina Nuova, città-museo. Segesta offre un tempio dorico e un teatro greco. La regione è ricca di specialità culinarie e artigianato locale, con possibilità di alloggio in strutture religiose.Il Sud Italia, tra Sicilia e Calabria, è costellato di luoghi di culto che testimoniano una lunga storia. Città come Catania e Siracusa presentano cattedrali e monasteri stratificati, legati al culto di santi martiri. L’architettura religiosa varia dal normanno al barocco, come a Noto e Ragusa. Monasteri di diversi ordini si trovano in molte località, offrendo ospitalità o conservando tradizioni. In Calabria, santuari come l’Eremo della Madonna della Consolazione o il Santuario di San Francesco di Paola sono mete di pellegrinaggio, e la Certosa di Serra San Bruno è un centro di vita monastica.Il percorso prosegue attraverso il Sud Italia, collegando aree naturali come la Sila e il Parco del Pollino a centri storici e religiosi. Si incontrano l’Abbazia Florense a San Giovanni in Fiore, Rossano con influenze bizantine, Castrovillari, Morano Calabro e Laurìa. Sulla costa, Maratea ospita il Santuario di San Biagio. Nell’interno, Rivello e Lagonegro presentano chiese e conventi antichi. In Campania si trova la vasta Certosa di San Lorenzo a Padula, Eboli, Salerno con il suo Duomo, e complessi monastici importanti come Montevergine e l’Abbazia della Santissima Trinità a Cava de’ Tirreni. Il percorso raggiunge Pompei con il suo santuario mariano e infine Napoli, ricca di luoghi di culto storici nel suo centro.A nord di Napoli, il percorso segue la Via Appia, attraversando aree con resti romani e siti religiosi. Aversa presenta un Duomo e un monastero. La Via Appia conduce a Formia e Gaeta, con chiese storiche e il Santuario della Montagna Spaccata. Si incontrano siti romani come la Grotta di Tiberio e il Tempio di Giove Anxur. Deviando verso l’interno si trovano abbazie gotico-cistercensi come Fossanova e Valvisciolo. Sull’Appia si attraversano l’Agro Pontino e i Castelli Romani, con città come Velletri, Genzano, Ariccia, Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, ricche di storia e tradizioni. A Grottaferrata sorge l’Abbazia di Santa Maria, legata al rito greco-bizantino. Il percorso termina alle Frattocchie e prosegue sull’Appia Antica verso Roma, passando per siti archeologici fino a San Pietro. Lungo la via si trovano possibilità di alloggio in abbazie e si possono scoprire prodotti monastici e canti gregoriani.Esiste una vasta letteratura su temi religiosi e spirituali, che documenta il Cristianesimo, i percorsi di pellegrinaggio e la storia del monachesimo. Gli ordini religiosi hanno avuto un ruolo cruciale nella storia della Chiesa e nell’accoglienza dei pellegrini. Tra i principali si annoverano i Benedettini con le loro diverse congregazioni, i Basiliani, i Certosini, i Cisterciensi con le loro riforme come i Trappisti, e gli ordini mendicanti come Francescani, Domenicani, Agostiniani, Carmelitani, Minimi e Servi di Maria, ciascuno con specifici carismi e attività. Nel Cinquecento sorgono i Chierici Regolari per rispondere alle sfide dell’epoca.Riassunto Lungo
1. Viaggiare l’Italia antica e spirituale
Le antiche Vie Romee, percorsi storici che univano i grandi centri della fede cattolica a Roma, ritrovano oggi la loro importanza. Queste strade, percorse nei secoli da pellegrini, mercanti e viaggiatori in cerca di conoscenza, offrono ora un modo per riscoprire la storia profonda e il legame che unisce i popoli europei. Viaggiare lungo questi percorsi non è semplice turismo di massa, ma un’esperienza umana e spirituale che invita a un ritmo diverso e a una connessione più autentica con i luoghi e con sé stessi. Per vivere appieno l’anima di queste vie, è consigliabile allontanarsi dalle autostrade veloci e preferire le strade statali e provinciali, che permettono di attraversare paesaggi e borghi con maggiore calma e attenzione.Consigli pratici per il percorso
Quando si arriva nei paesi e nelle città lungo il cammino, il modo migliore per scoprirli è esplorare a piedi, addentrandosi negli angoli nascosti che spesso sfuggono a uno sguardo frettoloso. Per il riposo notturno, l’ideale è scegliere luoghi che riflettono lo spirito del viaggio, come le foresterie all’interno di monasteri o le locande tradizionali, evitando le strutture alberghiere moderne e impersonali. Anche per i pasti, si prediligono le osterie locali che propongono la cucina tipica del territorio, lasciando da parte i fast food e i ristoranti di lusso. Un suggerimento utile è limitare l’uso dei telefoni cellulari; questo aiuta a immergersi completamente nell’atmosfera dei luoghi visitati, a rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana e a ritrovare un rapporto più intimo con il tempo e lo spazio del viaggio.Accoglienza nelle strutture religiose
Cercare ospitalità in un monastero o in un’altra struttura religiosa richiede un approccio specifico. È fondamentale contattare la comunità in anticipo per verificare la disponibilità, poiché queste strutture non operano come normali alberghi e hanno regole e ritmi propri. L’arrivo degli ospiti è generalmente previsto al mattino o nel primo pomeriggio, rispettando gli orari di preghiera o dei pasti della comunità. Le sistemazioni possono essere semplici, a volte con bagni in comune, e in alcuni casi potrebbe essere richiesto agli ospiti di aiutare nella pulizia della stanza o di portare la propria biancheria. È importante sapere che alcuni monasteri offrono ospitalità solo a uomini o solo a donne. Per cogliere appieno lo spirito del luogo e vivere un’esperienza significativa, si consiglia un soggiorno di almeno tre giorni. Molte foresterie chiudono durante i mesi invernali e possono essere molto richieste durante le festività o in estate; la primavera e l’autunno offrono solitamente maggiore tranquillità. Durante i pasti, se condivisi nel refettorio comune con i religiosi, è richiesto di mantenere il silenzio. Il cibo offerto è semplice e genuino, spesso preparato seguendo antiche ricette locali. È essenziale rispettare gli orari e gli impegni liturgici della comunità ospitante, anche se non si è obbligati a partecipare alle funzioni religiose. L’ospitalità è spesso basata su offerte libere da parte degli ospiti, che, insieme ad altre attività, contribuiscono al sostentamento della comunità religiosa.Ma cosa rende davvero ‘spirituale’ un viaggio, o ‘autentica’ un’esperienza, al di là della semplice rinuncia alle comodità moderne?
Il capitolo lega strettamente l’esperienza “spirituale” e “autentica” del viaggio alla scelta di evitare le infrastrutture moderne e di privilegiare forme di ospitalità e spostamento tradizionali. Questa visione rischia di essere limitante e non esplora a fondo la natura intrinseca della spiritualità o dell’autenticità nel contesto del viaggio. Per arricchire questa prospettiva, sarebbe utile indagare le radici storiche e le diverse motivazioni del pellegrinaggio, confrontandole con le moderne ricerche di senso nel viaggio. Approfondire studi di storia delle religioni, antropologia del viaggio o filosofia dell’esperienza potrebbe offrire strumenti concettuali per comprendere meglio cosa significhi cercare e trovare significato in un percorso, indipendentemente dalle modalità pratiche scelte.2. Le Rotte Sacre e i Grandi Anni
Il pellegrinaggio verso luoghi come Gerusalemme, Santiago di Compostela e Roma è un fenomeno sociale che coinvolge persone di ogni ceto. Le motivazioni per intraprendere questi viaggi, noti come “cammino del cielo”, sono diverse. Si cerca l’indulgenza, l’espiazione di pene, la redenzione dai peccati tramite la sofferenza, la benevolenza divina o la salvezza eterna. Per alcuni, il pellegrinaggio rappresenta un mezzo di sostentamento, basato sulla carità offerta lungo il percorso, specialmente dai monaci. Altri motivi includono la ricerca di guarigioni, lo studio, la partecipazione a conflitti militari, il commercio, l’acquisizione di terre, il riconoscimento politico o spirituale, e il lucroso scambio di reliquie.Il Viaggio e le Mete
Viaggiare comporta affrontare pericoli naturali e umani, come banditi e rapitori. Le condizioni di viaggio sono difficili, con lunghi tratti senza riparo. Con il tempo, le strade migliorano, diventando più sicure e dotate di infrastrutture come ponti e ospizi gratuiti (hospitali), gestiti da religiosi per accogliere i pellegrini. Successivamente sorgono anche locande a pagamento. Il pellegrinaggio assume caratteri di massa dal XIV secolo, con Roma, Santiago e Gerusalemme come mete principali (peregrinationes maiores). Accanto a queste, si sviluppano pellegrinaggi minori verso santuari legati a miracoli e apparizioni, che riflettono la religiosità popolare.Il Giubileo: Un Anno Speciale
Un evento centrale è il Giubileo, la cui origine si lega a tradizioni ebraiche basate sul numero sette. Il primo Giubileo cristiano viene indetto a Roma da Bonifacio VIII nel 1300. Inizialmente celebrato circa ogni 50 anni, dal 1475 la cadenza diventa venticinquennale. Questi Anni Santi attirano grandi folle di fedeli a Roma e riflettono le vicende storiche e le iniziative papali dei vari secoli. Vengono indetti anche Giubilei straordinari. Il Giubileo del 2000 segna l’inizio del Terzo Millennio, mentre quello del 2015 è dedicato alla misericordia.Ma se le motivazioni erano così varie, quale era davvero la spinta principale dietro il “cammino del cielo”?
Il capitolo elenca una vasta gamma di motivazioni, dalle più spirituali (indulgenza, redenzione) a quelle più terrene (sostentamento, commercio, acquisizione di terre). Questa eterogeneità solleva un dubbio fondamentale: il pellegrinaggio era primariamente un atto di fede o un fenomeno sociale ed economico complesso, dove le motivazioni spirituali si intrecciavano, e talvolta si scontravano, con interessi materiali e sociali? Il capitolo presenta queste motivazioni in parallelo, senza approfondire la loro gerarchia, la loro evoluzione nel tempo o le differenze tra i vari ceti sociali. Per comprendere meglio questo aspetto, sarebbe utile approfondire la storia sociale del Medioevo, l’economia dell’epoca e analizzare fonti primarie come i racconti dei pellegrini o i registri degli ospizi.3. Santi e le Vie del Sud: Il Percorso dalla Sicilia
Un’antica via di fede si snoda dalla Sicilia verso nord, un percorso seguito da un flusso costante di pellegrini fin dal Medio Evo. Questi viaggiatori si dirigevano principalmente verso Roma o, imbarcandosi dai porti pugliesi, verso la Terra Santa. Già in tempi antichi, figure come San Paolo sono indicate come pellegrini partiti proprio dalla Sicilia per raggiungere Roma, segnando l’importanza storica di questa rotta.Il Ruolo dei Re Normanni
Dopo aver cacciato gli Arabi, i re Normanni, in particolare Ruggero II, crearono in Sicilia una società dove culture e fedi diverse convivevano. Questi sovrani ebbero un ruolo importante nel favorire i viaggi e i pellegrinaggi. Costruirono infatti ospitali e centri di accoglienza per i pellegrini, rendendo il percorso più accessibile e sicuro per chi affrontava il lungo cammino. La Calabria, vicina alla Sicilia, divenne in quel periodo un rifugio per eremiti in fuga dall’Oriente e dalla Sicilia stessa, sottolineando l’importanza spirituale della regione come tappa o destinazione.Le Antiche Vie del Pellegrinaggio
In Sicilia, la Via Valeria rappresentava un percorso principale per i pellegrini diretti a nord. Questa strada si snodava lungo la costa tirrenica dell’isola fino a raggiungere Messina. Da Messina, i viaggiatori potevano poi collegarsi ad altre vie che li conducevano attraverso la penisola italiana verso la loro destinazione finale, Roma. Queste antiche strade erano le arterie che permettevano il movimento di persone animate dalla fede attraverso l’Italia meridionale.Luoghi Significativi Lungo il Percorso
Lungo questa via che parte dalla Sicilia, si incontrano importanti centri religiosi e artistici che offrivano riposo e preghiera ai viaggiatori. Palermo, un tempo chiamata “tutto porto” per la sua importanza strategica e commerciale, presenta luoghi di grande valore come il Palazzo dei Normanni con la preziosa Cappella Palatina, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, riconoscibile per le sue suggestive cupole rosse che richiamano l’architettura orientale, e la Cattedrale, dove si trova la cappella dedicata a Santa Rosalia, la santa patrona della città, molto venerata localmente. Proseguendo il viaggio, altri luoghi significativi includono Monreale, famoso in tutto il mondo per il suo magnifico Duomo ricco di mosaici bizantini e il chiostro annesso, e Cefalù, con la sua imponente Cattedrale normanna che domina la città e la costa. Numerosi conventi e santuari punteggiavano il percorso, fornendo assistenza, un luogo per la preghiera e un rifugio sicuro ai pellegrini in viaggio verso le grandi mete della cristianità.Pellegrini e Santi Protettori
Il percorso di fede poteva condurre alla santità, e molti pellegrini sono stati canonizzati nel corso dei secoli, a volte proprio in concomitanza con gli Anni Santi. Tra le figure più note legate al pellegrinaggio o all’assistenza ai viaggiatori ci sono Santa Brigida di Svezia, pellegrina e mistica, e San Bernardino da Siena, che si distinse per l’organizzazione dell’accoglienza dei pellegrini nei centri urbani. C’è anche Santa Bona da Pisa, ricordata per i suoi numerosi viaggi e considerata la patrona delle hostess e dei viaggiatori. San Rocco è venerato per aver curato gli appestati, una figura importante per chi viaggiava in tempi di epidemie e malattie diffuse, mentre San Cristoforo è tradizionalmente invocato come santo protettore dei viaggiatori che affrontano lunghi percorsi. Queste figure rappresentano diversi aspetti del viaggio di fede, dalla devozione personale all’assistenza offerta lungo le vie.Se il capitolo si concentra sulla Via Appia e le sue ‘Antichità’, perché include così tante deviazioni e siti medievali?
Il capitolo offre un ricco itinerario, ma il titolo e l’introduzione sembrano promettere un focus sulla Via Appia romana e le sue vestigia antiche, affiancate da tracce di fede. Tuttavia, una parte significativa del percorso descritto si snoda attraverso città fondate in epoca normanna e abbazie medievali (gotico-cistercensi, greco-bizantine) che, pur essendo di grande interesse storico e religioso, rappresentano deviazioni notevoli dal tracciato principale dell’antica Via Appia e appartengono a epoche successive all’antichità romana. Questa scelta narrativa non è pienamente giustificata nel testo, lasciando il lettore incerto sul vero ambito del capitolo: si tratta di un percorso storico sull’Appia antica, un itinerario tematico su fede e storia nella regione, o una semplice lista di luoghi interessanti vicini al percorso? Per comprendere meglio questa commistione di epoche e luoghi, sarebbe utile approfondire la storia della Via Appia nel suo complesso (non solo l’epoca romana, ma anche il suo uso e la sua rilevanza nei secoli successivi), la storia del popolamento e delle istituzioni religiose nel Lazio meridionale e in Campania tra l’alto e il basso medioevo, e la storia delle grandi vie di comunicazione e dei pellegrinaggi in Italia. Approfondire testi di storici e archeologi specializzati in queste aree potrebbe fornire il contesto mancante.8. Sentieri di Carta e Comunità di Fede
Una vasta quantità di scritti esplora temi religiosi e spirituali. Questi testi approfondiscono argomenti come il Cristianesimo, i cammini di pellegrinaggio verso Roma, tra cui la celebre Via Francigena, e offrono guide ai santuari e ai monasteri presenti in Italia. Si raccontano anche la storia del pellegrinaggio cristiano, le vite di figure spirituali come San Bernardo, l’influenza della fede cristiana sull’ambiente, il significato profondo del pellegrinaggio e l’esperienza del monachesimo femminile.Il ruolo degli ordini religiosi
Gli ordini religiosi hanno svolto un ruolo fondamentale nella storia della Chiesa e hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dei pellegrinaggi. La loro organizzazione e le loro regole di vita hanno influenzato profondamente le pratiche spirituali e sociali nel corso dei secoli. Comprendere le diverse forme di vita consacrata aiuta a cogliere la ricchezza e la varietà del panorama religioso.Gli ordini monastici e contemplativi
Tra i principali ordini religiosi attivi, spiccano i Benedettini, fondati da San Benedetto. La loro regola pone l’accento sulla preghiera, sul lavoro e sull’accoglienza dei pellegrini, principi che hanno guidato la vita monastica per lungo tempo. Diverse congregazioni benedettine hanno sviluppato orientamenti specifici, riflettendo diverse sensibilità e priorità all’interno della stessa tradizione.Diverse figure emergono per il loro impegno e la loro visione in questo esempio:- Camaldolesi: Privilegiano la vita mistica e contemplativa, cercando un rapporto più intimo con Dio attraverso la preghiera solitaria e comunitaria.
- Camaldolesi di Monte Corona: Scelgono in modo più radicale la vita eremitica, con un forte isolamento per dedicarsi completamente alla contemplazione.
- Cassinesi: Adottano un regime confederato, che unisce diverse abbazie sotto una struttura comune, pur mantenendo una certa autonomia locale.
- Olivetani: Riprendono la regola benedettina con una particolare attenzione alla cultura e alle arti, promuovendo lo studio e la conservazione del patrimonio.
- Silvestrini: Si focalizzano sulla ricerca interiore e sull’attività missionaria, cercando di conciliare la vita contemplativa con l’annuncio del Vangelo.
- Sublacensi: Sono impegnati in attività apostoliche e sociali, portando la loro spiritualità a contatto con le esigenze del mondo.
- Vallombrosani: Sono noti per la loro lotta contro la simonia e per un forte impegno nella conservazione forestale, legando spiritualità e cura del creato.
Gli ordini mendicanti
Gli ordini mendicanti si distinguono per la scelta di vivere tra la gente e di dipendere dalla carità per il proprio sostentamento. I Francescani, con le loro diverse famiglie (Cappuccini, Conventuali, Minori), si dedicano all’aiuto sociale, alla vita comunitaria nelle città, alla cura dei luoghi legati a San Francesco e alla predicazione del Vangelo in modo semplice e diretto. I Domenicani, fondati da San Domenico, sono fortemente impegnati nell’evangelizzazione e nella cultura, giocando un ruolo chiave nella formazione delle prime università e dedicandosi allo studio approfondito della teologia. Gli Agostiniani si rifanno alle regole di Sant’Agostino, concentrandosi sulla contemplazione, sull’apostolato, sullo studio e sulla carità verso il prossimo. I Carmelitani, ispirati al Profeta Elia, uniscono la vita contemplativa all’attività missionaria e caritativa. I Minimi, fondati da San Francesco da Paola, scelgono di vivere in povertà e penitenza radicale. I Servi di Maria, devoti alla Madonna Addolorata, sono attivi nell’apostolato e nell’ospitalità, accogliendo e assistendo chi è nel bisogno.I Chierici Regolari
Nel Cinquecento, in risposta alle sfide poste dalla Riforma Protestante, sorgono i Chierici Regolari. Ordini come i Gesuiti, i Somaschi e i Teatini si caratterizzano per una maggiore disciplina e per una forte attenzione ai problemi sociali e all’attività apostolica nel mondo, distinguendosi dagli ordini monastici e mendicanti per la loro struttura e il loro campo d’azione.È possibile descrivere il ruolo storico degli ordini religiosi senza affrontare le loro controversie e i conflitti che li hanno visti protagonisti?
Il capitolo offre una panoramica descrittiva degli ordini religiosi, ma omette di affrontare le complesse dinamiche storiche, le critiche interne ed esterne, i periodi di crisi o le controversie che hanno segnato la vita di queste istituzioni. Per comprendere appieno il ruolo degli ordini religiosi, non basta descriverne la regola o le attività principali; è fondamentale analizzare il loro rapporto con il potere secolare, le eresie, i movimenti di riforma (anche interni alla Chiesa), e le critiche sociali o teologiche che hanno dovuto affrontare nei secoli. Approfondire la storia della Chiesa medievale e moderna, studiare i movimenti ereticali e riformatori, e leggere autori che hanno analizzato criticamente il potere ecclesiastico (come, in epoche diverse, Machiavelli o Voltaire) può fornire il contesto necessario per una visione più completa e meno agiografica.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]