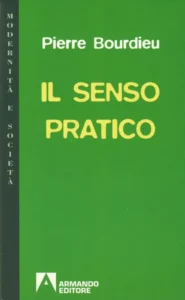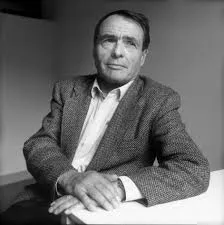1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Sulla televisione” di Pierre Bourdieu non è un libro facile, ma ti apre gli occhi su come funziona davvero il mondo dei media, specialmente la televisione. Bourdieu, con la sua sociologia dei media, analizza la televisione non solo come uno strumento che mostra la realtà, ma che la crea e la distorce. Parla della violenza simbolica che esercita, spesso senza che ce ne accorgiamo, e di come impone i suoi ritmi e le sue logiche a tutti, dai giornalisti agli intellettuali. Il libro esplora il campo giornalistico, mostrando come la ricerca dello scoop e la pressione dell’Auditel portino a un’omologazione dell’informazione, dove tutti dicono le stesse cose, privilegiando la cronaca sensazionale e la spettacolarizzazione a scapito dell’analisi profonda. Questa influenza dei media, guidata dal mercato, non si ferma al giornalismo, ma invade e indebolisce l’autonomia di altri campi sociali come la politica, la cultura e la scienza, spingendoli a conformarsi alla logica dell’audience e della visibilità. È una critica televisiva potente che ti fa capire perché l’informazione sembra sempre più superficiale e depoliticizzata, e come la logica dell’Auditel stia cambiando il modo in cui pensiamo e percepiamo il mondo.Riassunto Breve
La televisione mette un sacco di paletti a chi ci va, tipo poco tempo per parlare, argomenti non sempre scelti liberamente e un controllo su quello che dici. Però un sacco di gente, anche quelli bravi come scienziati o intellettuali, ci vanno lo stesso perché l’importante è farsi vedere, apparire sullo schermo, che per molti è come esistere pubblicamente. C’è una specie di censura, non solo quella che pensi, ma anche un’autocensura perché il lavoro è precario e le aziende che possiedono le reti influenzano tutto. La televisione usa una violenza che non si vede, una violenza simbolica, che distorce la realtà senza che nessuno se ne accorga. Sceglie le notizie in un certo modo, preferendo quelle di cronaca, sensazionali e drammatiche, perché attirano l’attenzione e non creano discussioni, occupando spazio che servirebbe per cose più importanti. I giornalisti scelgono cosa mostrare in base a quello che pensano sia interessante o spettacolare, drammatizzando gli eventi e cercando sempre lo scoop, anche nelle cose normali, e questo rende l’informazione tutta uguale. L’immagine in TV sembra vera e può far credere a quello che mostra, influenzando le persone e persino creando gruppi. Oggi, per contare in politica, devi creare eventi fatti apposta per la TV. Nonostante sembrino diverse, le notizie sono molto simili tra loro perché i giornalisti si copiano a vicenda, usano le stesse fonti e sono influenzati dalla concorrenza e dagli indici di ascolto, come l’Auditel, che diventa la cosa più importante, decidendo cosa va in onda e spingendo a pensare in modo veloce, con idee semplici e luoghi comuni. Il pensiero più complesso, che richiede tempo, non trova spazio. Chi conduce i programmi controlla tutto, dai tempi a chi parla, e invita sempre le solite facce note, creando una disuguaglianza. La televisione ha cambiato il giornalismo e la cultura, rendendo difficile fare cose profonde e farle capire a tutti, perché c’è la pressione del mercato misurata dall’Auditel. Molti giornalisti non sono contenti, ma non c’è una vera ribellione. Le reti competono, ma ci sono forze nascoste che influenzano tutto, e la TV, essendo diventata più importante dei giornali, influenza tutto il settore. Per piacere a tanti, la TV evita argomenti difficili, rendendo l’informazione banale e meno politica, adattandosi alle idee del pubblico invece di provare a cambiarle. I giornalisti hanno potere perché decidono chi si vede e si sente, e usano questo potere per scegliere cosa mostrare in base a quello che “funziona” in TV, che è una specie di censura nascosta. La TV è passata dal voler diffondere cultura al voler piacere al pubblico con cose semplici ed emozionanti, e nessuno dei due modi aiuta una vera democrazia dell’informazione. Il giornalismo è molto influenzato dal mercato e dall’Auditel, e questo si vede in come i giornalisti interagiscono e in come sono fatte le notizie. La posizione di un giornale o di un giornalista decide cosa si può dire. La competizione porta a criticarsi a vicenda, e i giornalisti della carta stampata criticano la TV perché sta diventando dominante e impone un modo di fare informazione basato sullo spettacolo e sulla cronaca, tipico dei giornali di gossip. La ricerca dell’audience spinge a dare spazio a cronaca nera, sport e pettegolezzi politici, cose che non richiedono di capire molto e rendono la vita pubblica un chiacchiericcio, anche se poi chiamano esperti per dare un senso a cose senza importanza. I giornali devono scegliere se copiare la TV o fare diverso, ma spesso finiscono per perdere la loro identità. Il giornalismo, sottomesso al mercato, influenza a sua volta altri campi come la legge, la scienza, la politica e la cultura, imponendo la sua logica. Questo succede perché ci sono persone in questi campi che non sono molto apprezzate dai loro colleghi e cercano successo nei media, facendo entrare la logica commerciale che rovina l’autonomia di questi campi, che è importante per farli funzionare bene. La pressione dei media può influenzare i giudici o sostituire la critica interna nella scienza con la logica del successo facile. In politica, i media eliminano la distanza necessaria per pensare, promuovendo una democrazia basata sull’emozione del momento. L’influenza del giornalismo, sempre più legato al mercato, si estende a cultura, politica e sport, indebolendo la loro autonomia che si basa su valori interni. Vengono favoriti quelli che cercano il successo di pubblico, come gli “intellettuali-giornalisti”, che usano criteri basati sulla visibilità e sui numeri, a scapito della qualità, orientando la produzione verso cose semplici e facili da vendere. In politica, l’influenza dei media e dei sondaggi spinge a seguire le emozioni del pubblico, trasformando la politica in uno spettacolo di scontri personali invece che in un dibattito serio sui problemi. Anche eventi come le Olimpiadi diventano uno spettacolo per la TV, orientato a fare audience e soldi, enfatizzando il nazionalismo e gli atleti famosi. L’atleta che si vede è solo una piccola parte di un sistema commerciale enorme. Questa prevalenza del mercato porta a vedere il mondo in modo spezzettato, concentrato sull’evento che fa rumore e senza capire il contesto o la storia. Questo fa sentire le persone disilluse e meno interessate alla politica, perché vedono le cose come incomprensibili e fuori controllo, lasciando tutto in mano agli esperti e diventando fatalisti.Riassunto Lungo
1. Lo Schermo che Modella la Realtà
La televisione pone vincoli significativi su chi vi prende parte. Il tempo a disposizione è limitato, l’argomento spesso non può essere scelto liberamente e il discorso è soggetto a un controllo esterno. Nonostante queste condizioni, molte persone, inclusi intellettuali e scienziati, accettano di apparire. Questo accade perché l’obiettivo principale diventa la visibilità sullo schermo, che per alcuni coincide con l’esistenza pubblica. In questo senso, la televisione agisce come uno specchio per l’esibizione personale.Pressioni Nascoste e Censura
Sulla televisione esiste una forma di censura che va oltre quella politica o economica. C’è anche un’autocensura dovuta alla precarietà del lavoro nel settore. Le pressioni economiche, spesso legate alla proprietà delle reti televisive da parte di grandi gruppi industriali, influenzano i contenuti in modi non sempre evidenti. Queste dinamiche contribuiscono a una forma di violenza simbolica, spesso non percepita né da chi la subisce né da chi la esercita. La sociologia può aiutare a svelare questi meccanismi nascosti.Come Vengono Scelte le Notizie
Un modo in cui la televisione opera è attraverso la selezione e la presentazione delle notizie. Vengono privilegiati i fatti di cronaca sensazionali e drammatici, perché attirano l’attenzione e non creano divisioni nel pubblico. Questi fatti “omnibus” occupano tempo prezioso che potrebbe essere dedicato a informazioni più rilevanti, funzionando di fatto come una distrazione. La selezione degli eventi da parte dei giornalisti si basa sulle loro categorie di percezione e sulla ricerca dello spettacolare, portando a una “drammatizzazione” degli eventi. La necessità di distinguersi e la corsa allo scoop spingono i giornalisti a cercare lo straordinario, anche nell’ordinario, il che paradossalmente porta a una uniformazione dell’informazione.Il Potere dell’Immagine e la Creazione della Realtà
L’immagine televisiva ha un forte potere di creare un “effetto di realtà”, inducendo a credere a ciò che viene mostrato. Questo può mobilitare sentimenti e persino creare gruppi sociali o politici. La televisione non si limita a registrare la realtà, ma la plasma attivamente. Oggi, per avere un impatto politico, è sempre più necessario produrre eventi pensati appositamente per essere ripresi e amplificati dalla televisione, adattandoli alle sue esigenze e categorie.Il capitolo non rischia di attribuire alla televisione un potere quasi onnipotente, trascurando la capacità critica e interpretativa del pubblico?
Il capitolo descrive con efficacia i meccanismi attraverso cui la televisione seleziona, presenta e potenzialmente plasma la realtà, evidenziando i vincoli e le pressioni che influenzano i contenuti. Tuttavia, l’analisi sembra concentrarsi prevalentemente sul potere del mezzo e dei suoi produttori, dedicando meno attenzione a come i messaggi vengono ricevuti e decodificati da un pubblico eterogeneo. È fondamentale considerare che gli spettatori non sono recettori passivi, ma interpretano i contenuti mediatici attraverso i propri filtri culturali, sociali ed esperienziali. Per bilanciare questa prospettiva e comprendere appieno l’interazione tra media e società, sarebbe utile esplorare le teorie sulla ricezione e gli studi sull’audience, che hanno messo in discussione i modelli lineari di comunicazione. Approfondire il lavoro di autori che si sono dedicati alla sociologia della comunicazione e agli studi culturali può offrire una visione più sfumata e complessa del rapporto tra televisione e spettatori.2. La fabbrica dell’informazione omogenea
I prodotti giornalistici, anche se sembrano diversi tra loro, in realtà mostrano una forte somiglianza. Questa uniformità nasce dalla competizione tra i media e tra i giornalisti stessi. Tutti lavorano con limiti simili, usano le stesse fonti e si influenzano a vicenda leggendo i lavori degli altri. I giornalisti leggono molto gli altri giornali per capire quali argomenti trattare, creando così un circolo che rende le notizie e le loro priorità sempre più simili. Le piccole differenze che i professionisti cercano per distinguersi sono spesso quasi invisibili per chi legge o guarda.Un sistema chiuso e guidato dai numeri
Questo modo di lavorare crea un ambiente mediatico isolato, dove le informazioni circolano principalmente tra gli addetti ai lavori. È difficile far entrare temi o punti di vista che non rientrano in questo giro. La logica principale che domina è quella della concorrenza. In televisione, in particolare, c’è una forte pressione dovuta all’urgenza di dare notizie subito e agli indici di ascolto, i cosiddetti auditel. L’auditel diventa il criterio più importante, influenzando le scelte su cosa mandare in onda e promuovendo un modo di pensare che valuta il successo in termini commerciali, anche per i programmi culturali.L’urgenza e il pensiero veloce
La fretta imposta dai ritmi dei media favorisce un “pensiero veloce”. Questo tipo di pensiero si basa su idee comuni e già sentite, che sono facili da capire e da diffondere rapidamente. Un pensiero più profondo e complesso, che richiede tempo per analizzare le idee comuni e costruire argomenti articolati, trova poco spazio in questo sistema.Il controllo nei dibattiti televisivi
Nei dibattiti in televisione, chi conduce la trasmissione ha un grande controllo. Decide quanto tempo ha a disposizione ognuno per parlare, il tono della discussione e come vengono formulate le domande. Questo può manipolare il modo in cui si svolge il dibattito. Anche la scelta degli ospiti è fondamentale. Spesso si preferiscono persone che appaiono spesso in televisione (“buoni clienti”), invece di invitare voci meno conosciute ma che potrebbero portare idee nuove e originali. Questo crea una differenza nella possibilità che le diverse opinioni hanno di essere ascoltate.Il capitolo attribuisce l’omogeneità dell’informazione principalmente alla competizione e alle dinamiche interne tra giornalisti. Ma questa spiegazione non rischia di ignorare il peso di fattori esterni e strutturali ben più potenti?
Il capitolo, nel descrivere la genesi dell’omogeneità informativa, pone l’accento sulle dinamiche interne al campo giornalistico e sulla logica competitiva. Tuttavia, concentrarsi esclusivamente su questi aspetti potrebbe non fornire un quadro completo, trascurando l’influenza determinante di fattori strutturali come la proprietà dei mezzi di comunicazione, le pressioni economiche legate alla pubblicità, o i rapporti di potere con le élite politiche ed economiche. Per approfondire queste prospettive critiche e comprendere come forze esterne al puro campo giornalistico modellino il panorama informativo, è utile esplorare la sociologia dei media e l’economia politica della comunicazione. Autori come Herman e Chomsky o Bourdieu offrono strumenti concettuali per analizzare queste dimensioni più ampie.3. Il peso invisibile dell’Auditel
La televisione non è uno strumento libero, ma opera sotto forti vincoli. Queste limitazioni derivano in parte dalle relazioni tra i giornalisti, caratterizzate da competizione e accordi informali, e dalle idee comuni che condividono a causa della loro formazione ed esperienza nel mestiere. Nonostante la sua apparente potenza, il mezzo televisivo è di fatto molto condizionato.La pressione del mercato e l’Auditel
La televisione ha trasformato profondamente il mondo della cultura e del giornalismo, forse più di quanto si riconosca. Porta all’estremo la sfida di creare contenuti complessi che siano allo stesso tempo facilmente comprensibili e accessibili a un pubblico vasto. Questa difficoltà è amplificata dalla fortissima pressione che la televisione subisce dal mercato, una pressione misurata costantemente da sistemi come l’Auditel.Competizione e forze nascoste
Le diverse reti televisive competono tra loro, ma questa competizione è influenzata da forze meno visibili. Fattori come le quote di mercato raggiunte o il prestigio di specifici giornalisti e testate giornalistiche creano una gerarchia implicita nel campo dell’informazione. La televisione, essendo diventata il mezzo dominante rispetto ai giornali tradizionali, ha ora il potere di influenzare l’intero settore giornalistico.Evitare argomenti difficili
Per riuscire a raggiungere un pubblico il più ampio possibile, la televisione tende a evitare gli argomenti che sono considerati difficili, controversi o che potrebbero creare divisioni tra gli spettatori. L’informazione che viene proposta diventa così più generica e omogenea su tutte le piattaforme. Questo processo di semplificazione e di riduzione della profondità politica avviene senza una decisione esplicita di qualcuno, ma è una diretta conseguenza della necessità di ottenere il massimo ascolto e di adattarsi alle opinioni già diffuse tra il pubblico, invece di cercare di stimolarne di nuove.Il ruolo e il potere dei giornalisti
I giornalisti all’interno di questo sistema hanno un ruolo centrale perché controllano l’accesso allo spazio pubblico, decidendo chi e cosa può essere visto e ascoltato da una grande platea. Questo controllo conferisce loro un potere significativo, anche se in altri ambiti culturali la loro posizione potrebbe essere considerata meno influente. Utilizzano questo potere per selezionare quali notizie e quali persone mostrare, basandosi spesso su ciò che ritengono “interessante” o su ciò che credono “funzioni bene in televisione”. Questa selezione agisce di fatto come una forma di censura implicita.Tensioni interne e frustrazione
Nel mondo del giornalismo televisivo esistono forti tensioni tra chi vorrebbe mantenere una maggiore libertà editoriale e chi invece si adatta alle logiche del sistema per convenienza o necessità. Molti giornalisti, anche quelli con una preparazione elevata, si ritrovano a svolgere compiti ripetitivi e poco stimolanti, il che aumenta un senso di frustrazione diffusa. Nonostante il malcontento sia ampio, non si registra una vera e propria opposizione o resistenza collettiva contro queste dinamiche.Dalla cultura all’intrattenimento
La televisione è cambiata nel tempo, passando da uno strumento pensato per diffondere la cultura a un mezzo che cerca soprattutto di compiacere il pubblico con programmi semplici, spesso focalizzati sull’emozione o sull’esibizione personale. Né l’approccio più vecchio, che poteva apparire come un modo per imporre la cultura dall’alto, né quello più recente, che si limita a seguire i gusti popolari, contribuiscono a un utilizzo veramente democratico dei mezzi di comunicazione.Se il mercato è così perverso, come si spiega che in alcuni settori “commerciali” emergano innovazione e varietà?
Il capitolo presenta una visione piuttosto unidirezionale dell’influenza del mercato e dei media sulla cultura, descrivendola quasi esclusivamente in termini negativi: abbassamento della qualità, uniformità, prevalenza del “commerciale” sul “puro”. Tuttavia, questa argomentazione trascura di considerare le dinamiche più complesse dei mercati culturali, dove la competizione e la ricerca di nuovi pubblici possono talvolta stimolare la creatività e la diversificazione dell’offerta, anche al di fuori delle logiche di “alto livello” tradizionali. Per ottenere una visione più completa, sarebbe utile approfondire gli studi sull’economia dei media, le teorie dell’innovazione nei settori creativi e la sociologia del consumo culturale. Autori come Pierre Bourdieu o Stuart Hall offrono strumenti concettuali per analizzare le interazioni tra campi culturali, potere e pubblico in modo più articolato, andando oltre una semplice dicotomia tra “mercato” e “qualità”.6. L’influenza del mercato sulla cultura e la politica
Il modo in cui funziona il giornalismo, sempre più legato alle regole del mercato e all’obiettivo di avere un vasto pubblico, sta cambiando anche altri settori importanti della società, come la cultura, la politica e lo sport. Questa pressione dall’esterno rende meno liberi questi ambiti, che di solito si basano su regole e valori propri (come la serietà scientifica, il valore artistico o i principi politici).Chi guadagna dalla logica del mercato
Chi lavora in questi settori e si preoccupa di più del successo di pubblico e dei guadagni esterni diventa più forte. Pensiamo, ad esempio, agli “intellettuali-giornalisti”, persone che si muovono tra mondi diversi. Loro portano nuovi modi di valutare le cose, dando importanza alla visibilità sui media e ai numeri (come quanti guardano la TV o quante copie si vendono), piuttosto che alla qualità o alla profondità dei contenuti. Questo spinge a creare prodotti culturali, politici o sportivi che siano più semplici e facili da vendere.La politica diventa uno spettacolo
Nella politica, l’influenza del giornalismo, insieme alla pressione dei sondaggi d’opinione, porta chi fa politica a cercare di piacere subito al pubblico, anche quando le reazioni del pubblico sono solo emotive o poco ragionate. La politica rischia così di trasformarsi in uno spettacolo, dove contano più gli scontri personali e le strategie per vincere che il confronto serio sui problemi veri. Anche i giornalisti stessi, spesso più interessati ai retroscena e alle relazioni personali, contribuiscono a questa visione superficiale e un po’ disillusa della politica.Lo sport sotto i riflettori della TV
Anche grandi eventi come i Giochi Olimpici cambiano per seguire le regole della televisione e del commercio. La gara sportiva diventa uno spettacolo mondiale pensato per avere il massimo numero di spettatori e guadagnare di più. La programmazione e il racconto degli eventi mettono in risalto il senso di appartenenza nazionale e gli atleti che hanno successo sui media. L’atleta famoso che vediamo è solo una piccola parte di un sistema commerciale molto grande e complesso.Come vediamo il mondo oggi
Questo dominio della logica di mercato porta a mostrare il mondo in modo spezzettato. Ci si concentra sull’evento che fa più notizia, senza dare il giusto contesto storico o spiegare le cause profonde dei problemi. Questo fa sentire le persone disorientate e meno interessate alla politica, perché gli eventi sembrano difficili da capire e impossibili da controllare. Molti finiscono per pensare che sia meglio lasciare che siano gli “esperti” a gestire la realtà, accettando le cose come stanno con un senso di inevitabilità.Ma siamo sicuri che la logica di mercato sia l’unica, inesorabile forza a plasmare cultura e politica?
Il capitolo presenta un quadro convincente dell’influenza del mercato, ma l’argomentazione potrebbe beneficiare di un approfondimento su altre dinamiche che concorrono a definire questi ambiti. Concentrarsi quasi esclusivamente sulla pressione economica rischia di trascurare fattori endogeni alle sfere culturale e politica, o l’impatto di altre trasformazioni sociali e tecnologiche. Per esplorare questa complessità, sarebbe utile approfondire discipline come la sociologia della comunicazione, la teoria politica e gli studi culturali, magari leggendo autori come Pierre Bourdieu, per la sua analisi dei campi e delle forme di capitale, o Jürgen Habermas, per la sua riflessione sulla sfera pubblica e le sue trasformazioni.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]