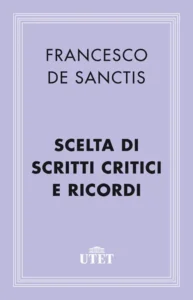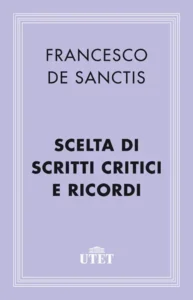1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Storia della letteratura italiana” di Francesco Sanctis è un viaggio incredibile attraverso i secoli, non solo raccontando chi ha scritto cosa, ma capendo come la vita vera dell’Italia si è riflessa nell’arte. De Sanctis, con la sua critica letteraria che guarda insieme forma e contenuto, ci porta dalle origini con la scuola siciliana e quella toscana, dove il volgare inizia a prendere vita, fino al Duecento e Trecento, esplorando figure immense come Dante Alighieri e la sua Divina Commedia, che è una sintesi pazzesca di un’epoca, ma anche Petrarca e Boccaccio, che spostano lo sguardo verso l’interno o sulla realtà terrena del Decameron. Poi entriamo nel Rinascimento, l’età della forma, con l’ironia di Ariosto nell’Orlando Furioso e la scoperta della realtà effettuale con Machiavelli. Vediamo come la letteratura cambia, a volte si perde nella forma vuota nel Seicento, a volte cerca la sostanza con filosofi e scienziati, fino al risveglio dell’Illuminismo e all’Ottocento con Manzoni e Leopardi, che affrontano temi nuovi e l’anima italiana. È una storia che lega l’arte alla storia morale e civile del paese, mostrandoci come la letteratura sia sempre stata specchio e parte della vita d’Italia, dalle corti siciliane alle città toscane, attraverso epoche di splendore, crisi e rinascita.Riassunto Breve
La critica letteraria si concentra sull’opera come unità di forma e contenuto, cercando di capire la sua vita interna e il processo creativo, legando la letteratura alla vita civile e alla storia nazionale. La storia letteraria diventa così una storia morale e politica del paese. Le origini della letteratura italiana mostrano due vie: la scuola siciliana, più artificiale e legata alla corte, e quella toscana, che sviluppa un volgare più semplice e preciso, influenzato dalla scienza e dalla filosofia, portando allo Stil Novo con figure come Guinicelli, Cavalcanti e Dante. Il Duecento si basa su cavalleria (superficiale in Italia) e religione (profonda), con una prosa didattica che prepara la lingua e rappresentazioni sacre allegoriche. Dante, nella lirica, introduce verità psicologica e infonde vita nel contenuto astratto. La Commedia di Dante sintetizza le correnti del Trecento, integrando la cultura medievale in una visione allegorica per la salvezza, ma la fantasia poetica crea un mondo vivido che supera l’intenzione didattica. Dopo Dante, l’attenzione si sposta sull’analisi psicologica e sul mondo interiore, con un interesse crescente per la forma. Boccaccio incarna il passaggio a un mondo terreno, dominato dal caso e dalle passioni, dove l’arte diventa centrale e il comico nasce dal contrasto sociale. Il Quattrocento è un’età di rinascimento latino e culto della forma, con la cultura concentrata nelle corti e un mondo poetico idillico e comico; la letteratura cavalleresca diventa gioco d’immaginazione. Il Rinascimento vede la società allontanarsi dal dogma medievale verso il materialismo e l’esperienza; Machiavelli fonda la scienza dell’uomo sulla “verità effettuale”, mentre l’arte (come l’Orlando Furioso di Ariosto) tratta il mondo fantastico con ironia. Il pensiero si sposta alla realtà terrena, con la patria come scopo e la politica come arte di gestire le forze umane, ma questo realismo porta anche alla corruzione e all’interesse individuale. Sotto il dominio straniero, la letteratura diventa artificio formale, separata dalla vita, con la lingua fissata dall’Accademia della Crusca; Tasso mostra la tensione tra ideali e sentimento, mentre la lirica diventa rifugio malinconico. Il Seicento eredita questa tendenza alla perfezione formale ma mancanza di contenuto, anche se emergono “nuovi filosofi” (Bruno, Galileo) che cercano la realtà attraverso l’esperienza, scontrandosi con la reazione ecclesiastica. Mentre l’Europa si rinnova, l’Italia è lenta, ma figure come Vico e Giannone iniziano a confrontarsi con le nuove idee, portando nel Settecento un desiderio di riforme e una letteratura che si avvicina alla vita reale (Goldoni, Parini). L’Ottocento vede l’emergere di temi nazionali e storici, con Foscolo che introduce la dimensione interiore e Manzoni che unisce storia, religione e idee moderne; la letteratura cerca di rappresentare la complessità umana e la realtà italiana, superando le vecchie distinzioni e puntando a una scrittura che rifletta la coscienza nazionale e individuale basata sull’osservazione. La letteratura italiana mostra un percorso da una visione allegorica e teologica a una maggiore attenzione per la vita terrena e le passioni umane, con un continuo confronto tra forma e contenuto e l’evoluzione verso la rappresentazione della realtà effettuale e dell’anima italiana.Riassunto Lungo
1. L’arte, la vita e lo sguardo del critico
Francesco De Sanctis sviluppa un approccio critico che si distacca nettamente dal purismo, dalla critica basata solo sulle impressioni e dallo schematismo filosofico rigido. Per lui, l’arte è un’unità organica di forma e contenuto, non un semplice ornamento o un’espressione di idee astratte. Il compito del critico è penetrare l’opera per comprenderne la vita interna e il processo creativo dell’artista, quasi come un attore interpreta un dramma. Questo metodo critico si riflette nel suo insegnamento, caratterizzato da un approccio dialogico e collaborativo, dove gli studenti partecipano attivamente alla discussione sui testi. L’obiettivo principale della sua didattica è formare il gusto estetico e la coscienza morale, considerando la letteratura strettamente legata alla vita civile e alla storia della nazione.La “Storia della letteratura italiana” e la sua eredità
La “Storia della letteratura italiana” rappresenta l’opera centrale del suo pensiero e della sua attività. È concepita non solo come una narrazione letteraria, ma come una vera e propria storia morale e politica d’Italia. In essa, De Sanctis analizza come la vita del paese si riflette e si trasforma attraverso l’arte, legando in modo indissolubile l’analisi estetica al contesto storico e culturale. Nonostante l’importanza innovativa del suo pensiero critico, che ha segnato una svolta nel modo di studiare la letteratura in Italia, l’opera di De Sanctis non ricevette subito l’attenzione e la comprensione che meritava e rimase per lungo tempo poco conosciuta anche a livello europeo. La sua critica unisce in modo potente l’analisi estetica profonda a una forte tensione morale e civile.Se il pensiero di De Sanctis era una svolta così potente, come mai non fu subito compreso e riconosciuto, persino in Europa?
Il capitolo evidenzia l’innovazione del pensiero di De Sanctis, ma lascia aperta la questione cruciale del perché un approccio così potente e legato alla vita nazionale non abbia trovato immediata comprensione e riconoscimento, persino al di fuori dei confini italiani. Per indagare questa apparente contraddizione, è necessario esplorare più a fondo il panorama della critica letteraria dell’epoca e dei decenni successivi, sia in Italia che in Europa, per capire quali fossero le resistenze o le alternative prevalenti. Approfondire gli studi sulla storia della critica e leggere autori che hanno analizzato l’eredità desanctisiana può fornire gli strumenti per colmare questa lacuna contestuale.2. Dalle Corti Siciliane alla Scienza Toscana
La letteratura italiana dei primi secoli prende forma principalmente in due aree geografiche: la Sicilia e la Toscana.La Poesia alla Corte di Federico II
In Sicilia, presso la corte di Federico II a Palermo, fiorisce una poesia che utilizza un volgare influenzato da elementi locali e da tradizioni straniere, come quella cavalleresca e orientale. Nonostante alcuni esempi di spontaneità, come si nota in Ciullo d’Alcamo, questa poesia risulta spesso poco autentica, poiché i temi cavallereschi non erano profondamente radicati nella vita italiana del tempo. Poeti come Guido delle Colonne e Jacopo da Lentini mostrano grande abilità tecnica, ma i loro contenuti appaiono artificiali e legati a convenzioni. Questa scuola poetica scompare con la fine del regno degli Svevi.Lo Sviluppo Letterario in Toscana e Altre Voci
In Toscana, specialmente nelle città di Firenze e Bologna, il volgare si sviluppa con caratteristiche di maggiore semplicità, grazia e precisione espressiva. Bologna diventa un importante centro di studi scientifici, dalla filosofia alla teologia, e queste discipline iniziano a influenzare anche la poesia. Guido Guinicelli è considerato una figura chiave di questa nuova tendenza: introduce nella poesia concetti filosofici e scientifici, legando per esempio l’amore al concetto di “cor gentil”, e utilizza immagini prese dal mondo della scienza e della natura per esprimere le proprie idee. La poesia inizia così a spostarsi dagli ambienti di corte a quelli più colti e universitari, diventando meno legata al gusto popolare e più dotta. Accanto a questa linea più intellettuale, sopravvive una poesia religiosa di carattere popolare e spontaneo, di cui è massimo rappresentante Jacopone da Todi, capace di esprimere sentimenti in modo diretto, a volte anche rude o grottesco. Tra le figure di spicco del periodo si distingue anche Guittone d’Arezzo, noto per la sua serietà morale e uno stile argomentativo, sebbene talvolta privo di leggerezza. La poesia politica di questi anni è spesso limitata e strettamente legata alle vicende interne dei singoli comuni.Lo Stil Novo: Amore, Scienza e Bellezza
La nuova scuola toscana, che include poeti come Cino da Pistoia, Guido Cavalcanti e Dante Alighieri, rappresenta un’evoluzione significativa. Questi autori uniscono la cultura scientifica e filosofica del tempo a una crescente attenzione per la forma artistica e l’espressione personale. L’amore diventa un tema centrale, indagato nelle sue dimensioni filosofiche e teologiche. Cino da Pistoia contribuisce ad affinare la musicalità del verso. Guido Cavalcanti è tra i primi a portare un senso più concreto e realistico nella poesia, riuscendo a combinare la tecnica stilistica con un sentimento autentico e profondo. Dante Alighieri perfeziona questo stile, che verrà definito “stil novo”, integrando in modo magistrale la scienza e la filosofia nella poesia e vedendo nella bellezza l’espressione della saggezza. In questa prospettiva, l’amore non è solo passione, ma un percorso di elevazione intellettuale e spirituale.È corretto definire “poco autentica” la poesia siciliana solo perché i temi cavallereschi non erano “profondamente radicati” nella vita italiana del tempo?
Il capitolo esprime un giudizio piuttosto severo sulla poesia della scuola siciliana, legando la sua presunta mancanza di autenticità alla non piena aderenza dei temi cavallereschi alla realtà italiana. Questa valutazione solleva una questione fondamentale: l’autenticità di un’opera d’arte deve necessariamente dipendere dalla diretta corrispondenza dei suoi temi con la vita quotidiana e sociale del luogo in cui viene prodotta? O l’arte può attingere a modelli e tradizioni esterne per creare qualcosa di nuovo e valido a prescindere dalla loro “radicazione”? Per approfondire questo dibattito, sarebbe utile esplorare la critica letteraria sul concetto di mimesi e sulla ricezione delle tradizioni culturali, oltre a leggere studi specifici sulla corte di Federico II e sul contesto culturale in cui operavano poeti come Jacopo da Lentini, magari confrontando le analisi di storici della letteratura come Francesco De Sanctis o Gianfranco Contini.3. La Parola e lo Spirito del Secolo Tredicesimo
Le radici della letteratura del Duecento: cavalleria e religione
La letteratura del Duecento poggia su due elementi fondamentali: l’idea di cavalleria e la fede religiosa. Sebbene la cavalleria appaia nei romanzi e nelle cronache come un elemento fantastico, non mette radici profonde nella cultura italiana. È invece la religione a permeare i sentimenti e le abitudini delle persone. L’eroe di questo periodo è il “cavaliere di Cristo”, una figura contemplativa che cerca la salvezza dell’anima. Rinuncia ai beni materiali e vive una vita spirituale dedicata alla preghiera e alla contemplazione, proiettato verso l’aldilà.La prosa didattica e la lingua volgare
La prosa di questo secolo nasce dall’ambiente laico e colto, che usa il volgare per diffondere il sapere. Si concentra sulla traduzione e sulla raccolta di opere che trattano di etica, retorica e filosofia. Testi come il Libro di Cato o il Fiore di rettorica hanno uno scopo educativo: vogliono trasmettere conoscenze pratiche e morali. Nonostante manchino di profondità artistica e non rappresentino la vita di tutti i giorni in modo realistico, sono importanti perché preparano la lingua volgare a essere usata per argomenti più complessi.Le rappresentazioni sacre e il viaggio dell’anima
Le rappresentazioni teatrali a tema religioso, chiamate “divozioni” o “misteri”, e le visioni descrivono il percorso dell’anima. Questo cammino va dalla condizione terrena, detta “Umano”, attraverso la purificazione, chiamata “Spoglia”, fino al rinnovamento spirituale, il “Rinnova”. Opere come la Commedia dell’anima mettono in scena la lotta tra i vizi e le virtù e mostrano la realtà dell’aldilà. Tuttavia, rimangono legate all’allegoria e alla dottrina, non riescono a creare personaggi con una vera individualità e rappresentano la vita terrena solo come luogo di peccato.Dante e la nascita dell’individuo poetico
Nella sua poesia lirica, Dante riesce a raggiungere una maggiore verità psicologica. La sua ispirazione è autentica, e il dolore per la morte di Beatrice trasforma l’amore giovanile in un sentimento più profondo, legato alla filosofia e alla conoscenza. Beatrice diventa una figura spirituale, quasi un “fantasma”, più un’impressione che una descrizione fisica concreta. Anche se il mondo della sua lirica è ancora ancorato alle idee e alla scienza del Medioevo, Dante, con la forza della sua immaginazione, riesce a dare vita a questi concetti astratti. Crea così la prima figura poetica individuale di rilievo del secolo, Beatrice, che simboleggia il passaggio dalla realtà terrena, fatta d’ombra, alla luce dello spirito.Ma in che modo le trasformazioni letterarie descritte riflettono o addirittura plasmano una specifica “anima italiana”?
Il capitolo elenca figure e movimenti cruciali, ma la connessione tra l’evoluzione della scrittura e la formazione di una “coscienza nazionale” o “anima italiana” rimane in parte implicita. Per comprendere meglio questo legame, sarebbe utile approfondire la storia culturale e politica del periodo, studiando non solo gli autori menzionati come Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo, Manzoni, Leopardi e Giusti, ma anche il contesto sociale e le idee filosofiche che circolavano, esplorando discipline come la storia del Risorgimento e la filosofia politica dell’epoca.14. Viaggio Attraverso i Secoli Letterari
La letteratura italiana cambia molto nel corso dei secoli. All’inizio, come nella Commedia di Dante, si parlava di viaggi spirituali e si usavano simboli per capire la realtà. Poi, nel Trecento, l’attenzione si sposta di più sulla vita di tutti i giorni e sui sentimenti delle persone. Petrarca racconta i suoi pensieri e le sue emozioni più intime. Boccaccio, invece, descrive il mondo reale con i suoi personaggi e le loro storie, come si vede bene nelle novelle del Decameron.Il Rinascimento
Il Rinascimento segna l’arrivo di nuove forme e temi nella letteratura, spostando ulteriormente l’attenzione verso la vita terrena e le dinamiche umane. L’epica cavalleresca, come l’Orlando Furioso di Ariosto, unisce avventura e ironia, offrendo una visione più complessa del mondo. Parallelamente, si sviluppa una prosa che affronta la società e la politica in modo diretto e concreto. Autori come Machiavelli e Guicciardini analizzano la realtà effettuale delle cose, descrivendo il mondo per quello che è, senza filtri. Questo periodo mostra un interesse crescente per l’uomo e il suo posto nella storia e nella società.I Secoli Successivi
Nei secoli dopo il Rinascimento, la letteratura continua a evolversi, influenzata da nuove idee filosofiche e scoperte scientifiche. Pensatori come Giordano Bruno e Tommaso Campanella esplorano la natura e l’universo con approcci innovativi, allargando gli orizzonti del pensiero. Questa apertura si riflette nella poesia e nella prosa. A volte si dà grande importanza ai sentimenti e alle emozioni interiori. Altre volte, invece, l’attenzione si concentra sulla cura della forma e dello stile della scrittura. La letteratura di questi secoli mostra una varietà di approcci nel rappresentare sia il mondo interiore che quello esterno.L’Ottocento
L’Ottocento è un periodo cruciale per la letteratura italiana. Emergono con forza temi legati all’identità della nazione e alle grandi vicende storiche che l’Italia sta vivendo. Gli scrittori di questo secolo cercano nuovi modi per raccontare la realtà contemporanea. Vogliono esprimere le speranze e le aspirazioni del loro tempo. La letteratura diventa uno strumento per esplorare il rapporto tra l’individuo e la collettività e per riflettere sui cambiamenti sociali e politici.Ma davvero la letteratura italiana si è sviluppata con questa semplicità, saltando a piè pari secoli interi?
Il capitolo offre una panoramica, ma la descrizione dei “Secoli Successivi” al Rinascimento appare lacunosa e generica. La storia letteraria è un processo complesso, fatto di correnti, reazioni, e figure significative che non sempre si inseriscono in una linea retta. Per comprendere meglio la ricchezza e le sfumature di questi periodi, che includono Barocco, Arcadia, Neoclassicismo, e le prime fasi del Romanticismo, sarebbe utile approfondire la storia della letteratura italiana nel suo complesso. Autori come Giambattista Marino, Giuseppe Parini, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, e i primi romantici come Manzoni e Leopardi (già attivi prima dell’Ottocento “cruciale” menzionato) sono fondamentali per cogliere la reale evoluzione e le tensioni che hanno attraversato questi secoli.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]