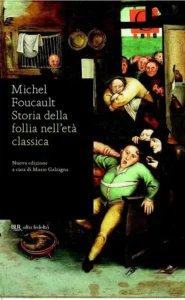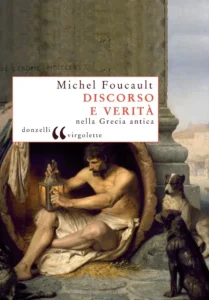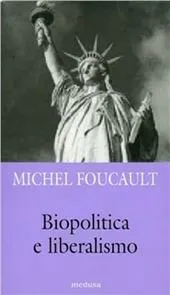1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Storia della follia nell’età classica” di Michel Foucault ti porta in un viaggio pazzesco (nel senso buono!) attraverso come la società ha visto e trattato la follia, soprattutto tra il Rinascimento e il Settecento. All’inizio, la follia era vista quasi come una cosa mistica, un’esperienza limite che diceva qualcosa di profondo sulla vita, un po’ come nella “Nave dei Folli”. Ma poi, nell’età classica, cambia tutto. Non è più una cosa tragica o cosmica, ma diventa un problema di ordine pubblico, legato alla povertà e alla “sragione”. È qui che scatta il “grande internamento”: gente con problemi diversi – poveri, vagabondi, ma anche i folli – vengono chiusi in posti come l’Hôpital Général, non tanto per curarli, ma per tenerli lontani e correggerli moralmente. La follia viene vista come un errore etico, una devianza morale, non una malattia mentale vera e propria. Il libro esplora come questa visione si lega anche alle idee sul corpo, sui nervi, su isteria e ipocondria, e come le terapie erano più che altro tentativi di riportare all’ordine morale. Poi, lentamente, la follia inizia a distinguersi dalla massa della sragione, ma finisce per essere rinchiusa in un nuovo posto: l’asilo. Qui, figure come Pinel e Tuke, pur con buone intenzioni, creano un luogo di silenzio e giudizio morale, dove il folle è costretto a confrontarsi con la propria “colpa”, diventando oggetto di osservazione. È un passaggio cruciale che prepara la strada alla psichiatria moderna, ma Foucault ci fa capire che questa “liberazione” è in realtà una nuova forma di prigionia, dove la follia viene oggettivata e alienata.Riassunto Breve
La follia, inizialmente vista come una dimensione che svela verità profonde e irrompe nella ragione, manifestandosi nell’arte e nella letteratura come esperienza limite e tragica, subisce una trasformazione radicale nell’età classica, tra il XVII e il XVIII secolo. Non è più un’esperienza estrema, ma diventa un elemento gestibile, spesso percepito come illusione o finzione. Questo cambiamento coincide con il grande internamento, un fenomeno sociale diffuso in Europa, non primariamente medico ma di ordine pubblico, volto a gestire povertà, disoccupazione e ozio. Istituzioni come l’Hôpital Général accolgono insieme poveri, vagabondi, malati e folli, associando la follia alla marginalità sociale e alla devianza morale. La follia viene così desacralizzata, perdendo la sua aura mistica per diventare un problema etico e sociale, legato al disordine e al rifiuto delle norme. L’internamento non cerca la cura medica, ma la correzione morale; la follia è vista come un errore etico, una cattiva volontà, uno scandalo da nascondere ma anche uno spettacolo pubblico. La medicina classica dibatte sulla natura della follia, legandola alla materialità dell’anima e del corpo, identificando cause nelle passioni e alterazioni nervose; il delirio è il suo linguaggio, radicato nell’immagine e nell’errore. Condizioni come isteria e ipocondria, inizialmente legate a squilibri di fluidi, vengono ricondotte al sistema nervoso, con la fibra nervosa e la “simpatia” tra organi che spiegano i sintomi; queste malattie nervose si legano a uno stile di vita “innaturale” e a colpe morali, entrando nel dominio della follia come accecamento spirituale. Le terapie riflettono questa ambivalenza, mescolando rimedi fisici, simbolici e morali, cercando di “risvegliare” il folle alla ragione o di ristabilire l’equilibrio attraverso il ritorno alla natura. Nel XVIII secolo, la paura del contagio proveniente dai luoghi di reclusione contribuisce a distinguere la follia dalla generica sragione, attribuendole una specificità inquietante. La civiltà moderna stessa è vista come causa di alienazione mentale. Si assiste alla creazione di istituzioni dedicate esclusivamente ai folli, segnale di un tentativo di isolamento. La crisi del sistema di internamento generale e una rivalutazione della povertà spingono ulteriormente verso la separazione. La follia emerge come entità distinta, non più solo esclusa ma oggetto di attenzione medica e morale. Si cercano nuovi spazi, oscillando tra vecchie funzioni di internamento e strutture specializzate; l’internamento stesso inizia a essere visto come strumento terapeutico. Questo passaggio segna una trasformazione profonda: la follia, da soggetto, diventa oggetto per la conoscenza. L’asilo emerge come luogo di verità e cura, ma anche di oggettivazione, dove la follia è osservata e giudicata. La “liberazione” associata all’asilo si rivela paradossale: la rimozione delle catene fisiche lascia spazio a una prigionia morale e psicologica. L’asilo diventa un ambiente di silenzio, giudizio e auto-riconoscimento forzato della propria follia. Il silenzio e il meccanismo dello specchio inducono il folle a interiorizzare il giudizio negativo. Il medico assume un ruolo centrale di autorità morale, quasi taumaturgo. Questa nuova forma di internamento oggettiva la follia e la imprigiona in un mondo morale, sostituendo la libertà fisica con una catena invisibile di colpa e vergogna. La psichiatria positivista eredita questa ambiguità, mescolando pretesa scientifica e potere morale. La psicanalisi, pur criticando l’asilo, perpetua la dinamica dell’autorità medica e dell’alienazione del malato. La liberazione del folle nel XIX secolo si traduce in una nuova forma di assoggettamento, dove la verità della follia diventa la verità alienata dell’uomo stesso, definendo la psicologia moderna.Riassunto Lungo
1. Nave dei Folli e Specchio della Ragione
La verità paradossale della follia
La follia, in modo sorprendente, può far emergere verità profonde. Agisce come un elemento di rottura, creando un momento di incertezza che costringe a rimettere in discussione ciò che si considera sicuro e assodato. Quando la follia si manifesta in modo estremo, diverse dimensioni apparentemente opposte coesistono: fragilità e forza, distruzione e creazione, malattia e genio si intrecciano. Anche la malinconia, pur essendo una condizione di sofferenza, può essere fonte di grande capacità intellettuale, oscillando tra momenti di profonda tristezza e intuizioni brillanti.L’interazione tra soggetto e conoscenza
Ogni persona è allo stesso tempo influenzata dal mondo che la circonda e capace di modificarlo attivamente. La conoscenza non è qualcosa di oggettivo e distaccato, ma è sempre legata a un punto di vista specifico; chi osserva, infatti, influenza ciò che osserva. Questa interazione continua è fondamentale per capire la realtà. Il soggetto che conosce e l’oggetto conosciuto si influenzano a vicenda, in un equilibrio dinamico tra ciò che è inevitabile e ciò che è frutto di libera scelta. La libertà nasce proprio dal confronto con i limiti e i condizionamenti, non come qualcosa che viene dopo, ma come una forza opposta che è sempre presente.La follia come esperienza originaria
La follia, con la sua natura imprevedibile e anarchica, irrompe in questo processo dialettico, rappresentando un gesto primario, un’esperienza al limite che precede la distinzione netta tra ragione e mancanza di ragione. Si manifesta in una zona indefinita e ambigua, dove ragione e follia si confrontano nella loro diversità più radicale. Per capire questi sviluppi storici, è necessario adottare un modo di pensare che tenga insieme elementi diversi e contrastanti, superando la tradizionale contrapposizione tra opposti.Follia, storia ed espressione artistica
La storia della follia è strettamente legata alla storia dell’esperienza umana, e si contrappone a un modo di pensare che si basa solo su concetti astratti e sulla realtà materiale. La letteratura e la poesia diventano strumenti essenziali per esplorare l’esperienza estrema della follia, dando voce a dimensioni che vanno al di là della logica e del discorso razionale. L’immagine della “Nave dei Folli”, tipica del Rinascimento, rappresenta un disagio culturale profondo, in cui la follia diventa oggetto di critica morale e sociale. Tuttavia, nella follia rimane sempre presente un aspetto tragico e universale, che spesso viene nascosto dalla coscienza critica. Questa dimensione tragica, legata all’assenza di opere concrete e al silenzio, riemerge con forza nella poesia e nell’arte, rivelando una verità profonda e difficile da esprimere a parole.In che modo la follia, intrinsecamente irrazionale, può rivelare una “verità profonda” senza cadere in un relativismo assoluto dove ogni percezione, anche la più delirante, diventa valida?
Il capitolo afferma che la follia può far emergere “verità profonde”, ma non chiarisce come questa verità si distingua da semplici allucinazioni o interpretazioni soggettive. Se ogni forma di follia rivela una verità, allora il concetto stesso di verità oggettiva viene messo in discussione. Per comprendere meglio questa complessa relazione tra follia e verità, sarebbe utile approfondire la filosofia della conoscenza e la psicologia della percezione, studiando autori come Michel Foucault per la sua analisi storica della follia, e filosofi come Karl Jaspers per la sua fenomenologia delle esperienze psicopatologiche.2. L’Età Classica e la Reclusione della Follia
La Trasformazione della Follia nell’Età Classica
Nell’età classica, il modo di vivere e vedere la follia cambia profondamente. Rispetto al periodo di Cervantes e Shakespeare, dove la follia era vista come qualcosa di estremo e tragico, ora assume un ruolo diverso. Diventa un elemento presente nelle opere letterarie e teatrali, ma non è più considerata una condizione assoluta e senza rimedio. Al contrario, viene vista più come un’illusione, una rappresentazione teatrale che serve a far emergere la verità e a riportare alla ragione.Il Grande Internamento e la Gestione della Marginalità
Questo cambiamento nel modo di vedere la follia avviene nello stesso periodo in cui si verifica un grande fenomeno sociale: il grande internamento. A partire dal Seicento, in tutta Europa nascono istituzioni come l’Hôpital Général, le workhouses e le Zuchthäuser. Questi luoghi non nascono come ospedali per curare le malattie, ma piuttosto come strumenti per mantenere l’ordine pubblico. Servono a gestire problemi come la povertà, la mancanza di lavoro e il vagabondaggio. L’internamento diventa quindi una risposta alla crisi economica e sociale, con l’obiettivo di fermare la mendicità e di imporre l’idea che il lavoro sia un valore fondamentale per la società.Follia e Marginalità Sociale
In questi luoghi di internamento, la follia viene associata ad altre forme di esclusione e di comportamento considerato sbagliato. Insieme ai folli, vengono rinchiusi anche poveri, vagabondi, persone con malattie veneree, omosessuali, bestemmiatori e libertini. Questa unione di persone diverse non è un caso. Riflette un nuovo modo di sentire comune nella società, che non vede più la follia come un’esperienza speciale o tragica, ma come una forma di irrazionalità che si manifesta nel disordine sociale, nella mancanza di moralità e nel rifiuto delle regole della borghesia.La Nuova Percezione della Follia e le sue Conseguenze
Quindi, l’internamento non è solo un modo per reprimere i comportamenti indesiderati, ma anche il segno di come la follia viene percepita in modo nuovo. Ora la follia è vista in relazione a concetti come l’etica e la società. Non è più considerata qualcosa di sacro o misterioso, ma diventa un problema di ordine pubblico, legato alla povertà, all’ozio e alla devianza morale. Questo nuovo modo di vivere la follia, che nasce con l’internamento e con la condanna morale della mancanza di ragione, prepara la strada per il futuro in cui la malattia mentale verrà studiata dalla medicina e concettualizzata in modo scientifico.Ma è davvero corretto ridurre la complessità del “Grande Internamento” a una mera strategia di controllo sociale e repressione delle marginalità, o si rischia di trascurare altre dinamiche storiche e sociali altrettanto rilevanti?
Il capitolo sembra presentare una visione eccessivamente unidimensionale del “Grande Internamento”, focalizzandosi quasi esclusivamente sull’aspetto repressivo e di controllo sociale. Sarebbe opportuno considerare se tale interpretazione non tralasci altri fattori concomitanti, come ad esempio le mutate concezioni di assistenza e beneficenza, o le nascenti politiche sanitarie che, pur con le contraddizioni dell’epoca, potrebbero aver contribuito a plasmare le istituzioni di internamento. Approfondire le opere di storici come Michel Foucault, ma anche studi più specifici sulla storia della povertà e dell’assistenza nel periodo classico, potrebbe offrire una prospettiva più articolata e sfumata sul fenomeno descritto.3. Il Paesaggio Morale della Follia
L’internamento e la sua natura nell’età classica
Nell’età classica, l’internamento era una pratica diffusa per gestire la sragione, accogliendo diverse figure come persone dissolute, libertini e folli, senza fare distinzioni precise tra loro. Questa usanza nasceva più da esigenze morali e sociali che da una vera consapevolezza medica. La parola chiave per definire questo internamento era “furioso”, un termine legale e medico che all’epoca veniva usato comunemente per indicare ogni tipo di violenza che non rientrava nelle categorie del diritto penale. “Furioso” descriveva quindi un generico disordine nel comportamento, nei sentimenti e nello spirito delle persone.Internamento come correzione morale e non come cura medica
L’internamento non aveva lo scopo di curare dal punto di vista medico, ma piuttosto di correggere il comportamento morale delle persone. Anche se alcuni ospedali avevano degli spazi riservati ai folli che potevano guarire, la maggior parte delle persone con problemi mentali veniva rinchiusa in istituti simili a prigioni, vivendo nelle stesse condizioni dei carcerati comuni. Le rare cure mediche che venivano praticate erano più che altro misure igieniche per evitare il diffondersi di malattie, e non veri tentativi di terapia. Quindi, l’esperienza della follia si divideva in due modi: uno, meno comune, che la considerava una malattia curabile, e un altro, più diffuso, che la assimilava all’internamento e alla correzione morale.La follia come errore etico e scandalo sociale
Questo secondo modo di vedere la follia, tipico dell’età classica, non la considerava una malattia mentale, ma un errore dal punto di vista etico, una mancanza di volontà. Follia e delitto non erano concetti separati, ma si sovrapponevano in una zona grigia dove la ragione tradizionale esercitava il suo potere di esclusione. La follia diventava così uno scandalo per la società, qualcosa da tenere nascosto, ma allo stesso tempo anche uno spettacolo pubblico, mostrato come avvertimento e per un divertimento crudele.Differenza con la visione medica moderna
La percezione della follia nell’età classica era quindi molto diversa da come la si considera oggi dal punto di vista medico. Non si trattò di un avvicinamento a una comprensione scientifica della follia, ma di un’esperienza specifica, legata a un contesto etico e sociale. In questo contesto, la follia era vista soprattutto come una deviazione morale e uno scandalo pubblico, più che come una malattia da curare.Se l’asilo nasce con l’intento di curare, ma finisce per oggettivare la follia, non si rischia di interpretare la nascita della psichiatria moderna come un progresso lineare e positivo, trascurando le zone d’ombra etiche e sociali insite in questa “oggettivazione”?
Il capitolo descrive un cambiamento di prospettiva sulla follia nel Settecento, ma sembra presentare la nascita dell’asilo come una conseguenza inevitabile e in gran parte positiva di questa evoluzione. Tuttavia, si potrebbe mettere in discussione se questa narrazione non tralasci aspetti problematici. Per avere una visione più completa, sarebbe utile approfondire le opere di autori come Michel Foucault, che ha analizzato criticamente la storia della psichiatria e le dinamiche di potere che si celano dietro le istituzioni psichiatriche. Studiare la storia della follia e della psichiatria attraverso una lente critica può rivelare come il “progresso” scientifico e medico possa essere accompagnato da nuove forme di controllo e esclusione sociale.8. Lo Specchio Silenzioso della Ragione
L’idea che l’asilo psichiatrico possa essere un luogo di liberazione è sbagliata. Togliere le catene fisiche non significa rendere veramente libero chi soffre di malattie mentali. Anzi, si crea una nuova prigionia, che riguarda la morale e la mente. L’asilo, pensato da persone come Pinel e Tuke, diventa un ambiente silenzioso, dove si giudica di continuo e si costringe il malato a riconoscere la propria follia.Il Silenzio come strumento di controllo
Il silenzio diventa un modo per controllare i malati, prendendo il posto del dialogo e della discussione. Il malato, anche se non è più legato con catene, si ritrova solo con i suoi pensieri. La sua verità delirante non viene ascoltata, ma trova solo silenzio e mancanza di attenzione. Usando una specie di specchio, si spinge il folle a capire quanto è ridicolo il suo delirio, vedendolo riflesso negli altri. In questo modo, il malato inizia a giudicare sé stesso negativamente.L’Asilo come tribunale morale
L’asilo diventa come un tribunale nascosto, dove ogni cosa che si fa viene giudicata e punita. Il medico diventa la figura più importante, non tanto per la sua bravura scientifica, ma per la sua autorità morale. Il medico rappresenta il Padre, il Giudice, la Legge. Per il malato, il medico sembra quasi una persona magica, capace di rimettere a posto la morale attraverso la confessione e il pentimento.La psichiatria e la psicoanalisi
Questo nuovo modo di rinchiudere le persone, anche se nato con buone intenzioni, trasforma la follia in un oggetto e la imprigiona in un mondo fatto di morale. Si cambia la prigionia fisica con una prigionia invisibile fatta di sensi di colpa e vergogna. La psichiatria positivista, che continua questa tradizione, eredita anche questa incertezza. Oscilla tra la volontà di essere scientifica e l’uso di un potere morale nascosto e misterioso. Questo potere allontana ancora di più il malato, mettendolo nelle mani del medico. La psicanalisi di Freud, anche se smaschera alcuni aspetti negativi dell’asilo, in realtà continua questo modo di fare. Il medico diventa una figura onnipotente e il malato rimane alienato all’interno della relazione con il terapeuta.La nuova forma di prigionia
In conclusione, la liberazione dei folli nell’Ottocento si trasforma in una nuova forma di sottomissione. La verità della follia diventa la verità alienata della persona stessa, intrappolata in un meccanismo psicologico che definisce la psicologia moderna.Se la critica all’asilo come “tribunale morale” è valida, il capitolo considera adeguatamente le intenzioni originarie di figure come Pinel e Tuke, e il contesto storico in cui operavano?
Il capitolo presenta una visione critica dell’asilo psichiatrico, concentrandosi sugli aspetti di controllo e giudizio morale. Tuttavia, per una comprensione più completa, sarebbe utile esplorare se questa critica tenga conto delle motivazioni e del contesto storico in cui sono nati gli asili. Approfondire il pensiero di autori come Michel Foucault, ma anche studiare la storia della psichiatria e le biografie di Pinel e Tuke, potrebbe offrire una prospettiva più articolata e sfumata.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]