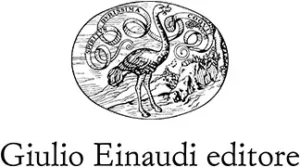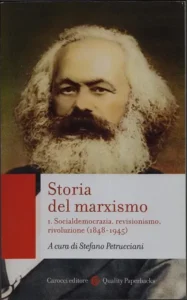1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Storia del marxismo. Comunismi e teorie critiche nel secondo Novecento” di Stefano Petrucciani ti porta in un viaggio super interessante attraverso come il pensiero marxista si è reinventato dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando l’ortodossia sovietica non bastava più e il capitalismo cambiava faccia. Non è solo una storia europea; il libro esplora percorsi diversi in posti come l’Italia, dove si è passati dallo storicismo all’operaismo che portava la lotta in fabbrica, la Francia con le sue correnti filosofiche e la critica dello spettacolo, ma anche l’Asia, specialmente la Cina con la “sinizzazione” di Mao Zedong, e l’America Latina, dove il marxismo si è legato alla teoria della dipendenza e alla teologia della liberazione. Si vede come pensatori e scuole diverse, dalla Scuola di Francoforte che analizzava il dominio nella cultura e nella psicologia, a figure come Bordiga o Althusser, hanno cercato di capire e criticare il nuovo capitalismo e le sue “astrazioni reali”, affrontando crisi e sconfitte ma continuando a sviluppare “teorie critiche” per interpretare il mondo. È una storia complessa e globale di idee che non si sono mai fermate.Riassunto Breve
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’interesse per le idee di Marx si è rinnovato in molte parti del mondo, ma non in modo uniforme. In Italia e Francia, ad esempio, si sono sviluppate interpretazioni molto diverse rispetto a quelle ufficiali dell’Unione Sovietica e si è cercato di capire i cambiamenti del capitalismo. In Italia, una corrente importante ha unito idee di Gramsci e Croce con il marxismo, concentrandosi sulla politica nazionale e la creazione di un grande partito, ma lasciando un po’ da parte l’analisi economica. Altri, come Bordiga, criticavano questa linea, insistendo sull’importanza della teoria economica di Marx e vedendo l’URSS come un capitalismo di Stato. Negli anni Sessanta, sono nate nuove scuole: il dellavolpismo ha visto il marxismo come un metodo scientifico per studiare la società, mentre l’operaismo è tornato a studiare il *Capitale* per capire come funziona il controllo sul lavoro nelle fabbriche, portando il conflitto politico direttamente lì, e poi ha guardato alla figura dell'”operaio sociale” e al conflitto fuori dalla fabbrica. In Francia, il marxismo si è legato di più alla filosofia e alla cultura, con pensatori che esploravano la critica della società attraverso la letteratura o l’analisi della “società dello spettacolo” come una forma di alienazione totale. Altri hanno cercato di unire il marxismo con l’esistenzialismo o la fenomenologia, o hanno proposto un marxismo più “scientifico” e meno legato al soggetto e alla storia. Parallelamente, la Scuola di Francoforte ha sviluppato una “teoria critica” che ha allargato l’analisi del dominio capitalistico oltre l’economia, includendo la psicologia e la cultura. Hanno studiato come l’autorità viene accettata, come il capitalismo moderno, con l’intervento dello Stato, diventa un “capitalismo di Stato” dove il controllo è più politico e burocratico. Hanno anche analizzato come la ragione stessa, nata per liberare, si sia pervertita portando a nuove forme di barbarie e come l’industria culturale manipoli le persone attraverso i consumi di massa. Altri pensatori hanno aggiunto l’importanza dell’utopia o hanno studiato la manipolazione nella vita di tutti i giorni. Le idee di Marx sono arrivate anche in Asia, adattandosi a contesti molto diversi dall’Europa. In Cina, in particolare, il marxismo è stato “sinizzato” sotto la guida di Mao Zedong, che ha messo l’accento sulla pratica, sulla contraddizione e sul ruolo delle masse, unendo elementi della tradizione cinese. Dopo Mao, l’ideologia ha cambiato ruolo, diventando uno strumento per giustificare la modernizzazione e adattandosi con concetti come il “socialismo con caratteristiche cinesi”, dove la scienza è diventata fondamentale. In America Latina, le idee sono arrivate con gli immigrati e si sono sviluppate in modo diverso nei vari paesi. Dopo un periodo dominato dal marxismo-leninismo di stampo sovietico, le critiche a Stalin e la Rivoluzione Cubana hanno portato a nuove correnti come la teoria della dipendenza, che analizza i rapporti tra paesi ricchi e poveri, e la teologia della liberazione, che unisce fede e impegno sociale. Nonostante le sconfitte politiche, la riflessione è continuata. Nel mondo anglosassone, il marxismo ha avuto meno peso all’inizio, ma dagli anni Sessanta c’è stato un maggiore interesse, con lo sviluppo dei cultural studies e dibattiti su autori europei. Anche se la caduta dell’URSS ha rappresentato un colpo duro, il marxismo continua a essere studiato nelle università e in correnti che cercano di unire teoria e azione. Questi percorsi diversi mostrano come il pensiero marxista abbia cercato di rinnovarsi e adattarsi per capire i cambiamenti del mondo e le crisi dei modelli politici esistenti.Riassunto Lungo
1. Percorsi Diversi del Pensiero Marxista nel Dopoguerra
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’interesse per il marxismo si riaccende sia in Italia che in Francia. Tuttavia, le interpretazioni che emergono si allontanano dall’ortodossia sovietica e cercano di confrontarsi con le nuove condizioni del capitalismo. Questo porta allo sviluppo di vie diverse e originali per pensare la teoria e la pratica rivoluzionaria.Il Pensiero Marxista in Italia
In Italia, una delle correnti più importanti è lo storicismo. Questa visione unisce elementi del pensiero di Gramsci, Croce e del marxismo sovietico. Palmiro Togliatti è tra i principali promotori di questa linea, che si concentra sulla strategia politica a livello nazionale, sull’importanza dell’unità antifascista e sulla costruzione di un grande partito di massa. Tuttavia, questa impostazione tende a trascurare l’analisi economica e a semplificare concetti complessi come quello di egemonia. Amadeo Bordiga si pone in forte critica rispetto a questa linea. Egli sostiene che il socialismo non può essere ridotto all’antifascismo o alla competizione tra blocchi internazionali. Bordiga riafferma la centralità della teoria economica di Marx, analizzando concetti come valore, plusvalore e rendita. Considera l’Unione Sovietica come una forma di capitalismo di Stato e vede la democrazia parlamentare come un’illusione. Per Bordiga, il compito fondamentale in un periodo di difficoltà per la rivoluzione è preservare intatta la teoria rivoluzionaria.Nuove Correnti Italiane negli Anni Sessanta
Negli anni Sessanta, il panorama del marxismo italiano si arricchisce con l’emergere di nuove correnti. Il dellavolpismo, legato alle figure di Galvano Della Volpe e Lucio Colletti, propone di considerare il marxismo non come una filosofia generale, ma come una metodologia scientifica specifica per le scienze sociali. Questa corrente si concentra sulla critica delle “astrazioni reali” prodotte dal capitalismo, come il concetto di lavoro astratto, e sviluppa una critica approfondita dell’economia politica. Parallelamente, la sociologia critica e l’operaismo, con esponenti come Raniero Panzieri e Franco Fortini, rifiutano le posizioni riformiste e contestano il primato della politica tradizionale. Questi pensatori tornano a studiare il Capitale di Marx per analizzare il modo in cui il capitalismo esercita il suo controllo sulla produzione e sulla forza-lavoro. L’obiettivo è riportare il conflitto politico direttamente all’interno della fabbrica. L’operaismo, in particolare con le idee di Mario Tronti e Antonio Negri, sposta l’attenzione sulla soggettività operaia, vista non solo come sfruttata ma anche come forza capace di spingere e al tempo stesso resistere al capitale. Si teorizza l’emergere di un “operaio sociale”, con il conflitto che si estende dalla fabbrica alla sfera più ampia della riproduzione sociale.Il Pensiero Marxista in Francia
In Francia, il marxismo si distingue per una forte tendenza a rifiutare le strutture dirigistiche e per un legame significativo con la filosofia tedesca e con movimenti culturali d’avanguardia come il surrealismo. Figure come Georges Bataille e Maurice Blanchot esplorano l’idea di una “rivoluzione” che passi attraverso la letteratura e una critica radicale di tutto ciò che nel capitalismo è considerato “utile”. Maurice Merleau-Ponty cerca di creare un ponte tra il marxismo e la fenomenologia. La sua riflessione si concentra sull’esperienza concreta dell’essere umano e del lavoro, offrendo anche una critica allo stalinismo da una prospettiva che mette al centro l’uomo. Jean-Paul Sartre tenta a sua volta di unire l’esistenzialismo con il marxismo, analizzando i gruppi sociali e il tema della libertà individuale e collettiva, pur mantenendo una posizione ambigua riguardo al ruolo del partito politico. Louis Althusser propone una visione del marxismo come scienza rigorosa e anti-umanistica, separata dalla storia intesa in senso tradizionale e dal concetto di soggetto. Per Althusser, la filosofia è una forma di lotta di classe che si manifesta sul piano teorico, e sviluppa una critica incisiva dello Stato borghese. Guy Debord, infine, analizza la “società dello spettacolo” come la forma estrema di alienazione che caratterizza il capitalismo avanzato, proponendo i consigli operai come una possibile alternativa radicale.Queste diverse scuole di pensiero, sia in Italia che in Francia, rappresentano importanti sforzi per ripensare il marxismo. Nascono dalla necessità di confrontarsi con i profondi cambiamenti sociali ed economici del dopoguerra e con le crisi dei modelli politici e teorici fino ad allora dominanti.Ma si può davvero mettere tutto questo sotto l’etichetta di “pensiero marxista”?
Il capitolo presenta un quadro molto ampio del pensiero francese, includendo figure i cui legami con il marxismo ortodosso o anche eterodosso sono complessi e spesso oggetto di dibattito. Alcuni di questi pensatori, pur dialogando con Marx, sviluppano critiche radicali che li pongono ai margini o addirittura al di fuori del marxismo inteso in senso più stretto. Per comprendere meglio queste sfumature e le intense discussioni che animavano il panorama intellettuale francese del dopoguerra, è necessario approfondire la storia delle idee politiche e filosofiche in Francia in quel periodo, esplorando le intersezioni (e le rotture) tra marxismo, esistenzialismo, strutturalismo, post-strutturalismo e le avanguardie artistiche e letterarie. Autori come Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, oltre a studi specifici sui singoli pensatori menzionati, possono aiutare a contestualizzare meglio queste figure e a capire i confini porosi (e contestati) del “pensismo marxista” francese.2. La Critica Estesa del Dominio nel Pensiero Marxista del Novecento
La Scuola di Francoforte, nata negli anni Trenta, ha sviluppato una “teoria critica”. Questo approccio rinnova il pensiero di Marx, mescolando lo studio dell’economia con quello della psicologia e della cultura. I pensatori di questa scuola si chiedono perché la rivoluzione che Marx aveva previsto non sia successa, anche se la produzione di beni è aumentata. Figure come Max Horkheimer ed Erich Fromm studiano come le persone imparano ad accettare l’autorità, anche dentro la famiglia, e questo le rende sottomesse e meno capaci di pensare in modo critico.Il Capitalismo di Stato e la Società Amministrata
Con la crescita di grandi aziende e l’intervento sempre maggiore dello Stato nell’economia, pensatori come Friedrich Pollock e Horkheimer parlano di un “capitalismo di Stato”. In questo sistema, il potere è più nelle mani della politica e della burocrazia che dell’economia pura. Questo rende il sistema più stabile e impedisce le crisi che Marx si aspettava. Theodor W. Adorno aggiunge che il dominio, cioè il controllo delle persone, non dipende solo da fattori economici, ma esisteva già nel vecchio capitalismo ed è ora più evidente. In questa “società amministrata”, dove tutto è organizzato, e con l'”industria culturale” (cinema, musica, media di massa), le persone perdono la loro unicità. Diventano standardizzate e facili da manipolare attraverso quello che comprano e un falso senso di essere diversi dagli altri. Questo porta a quella che viene chiamata la “decadenza dell’individuo”.La Critica della Ragione e la Ricerca di Liberazione
Horkheimer e Adorno, nel loro libro Dialettica dell’illuminismo, spiegano come il pensiero razionale occidentale, nato per capire e controllare la natura e gli uomini, si sia distorto nel tempo. Invece di portare libertà, ha generato forme di oppressione e violenza. Herbert Marcuse, invece, analizza come la società ci limiti psicologicamente, creando una “società a una dimensione” dove tutti pensano in modo simile. Il consenso si ottiene spingendo le persone a consumare e manipolandole. Marcuse cerca nuove strade per liberarsi, partendo dal cambiamento interiore delle persone e dei loro desideri.Altri Sguardi sulla Manipolazione e l’Utopia
Altri pensatori contribuiscono a questa critica allargata del dominio. Ernst Bloch vede l’utopia (l’idea di un futuro migliore) e la speranza come motori potenti per cambiare il presente, forze che spingono contro la realtà attuale. György Lukács, nei suoi ultimi lavori, studia cosa significa esistere in società e critica come le persone vengono manipolate nella vita di tutti i giorni.Ma davvero la mancata rivoluzione si spiega solo con lo ‘Stato capitalista’ e la manipolazione culturale?
Il capitolo offre una spiegazione della stabilità del capitalismo e della mancata rivoluzione che si concentra principalmente sull’evoluzione del sistema verso un “capitalismo di Stato”, sull’industria culturale e sulla manipolazione psicologica. Sebbene questi elementi siano certamente rilevanti, l’argomentazione potrebbe risultare più solida se considerasse anche altri fattori storici, politici ed economici che hanno contribuito a plasmare il XX secolo e a influenzare le dinamiche sociali e di classe, al di là della sola critica al dominio e alla ragione. Per approfondire questa tematica e comprendere meglio la complessità del periodo, sarebbe utile esplorare la storia politica ed economica del Novecento da diverse prospettive, analizzare le dinamiche interne dei movimenti operai e socialisti, e confrontare la “teoria critica” con altre teorie sociologiche e politologiche che hanno affrontato il tema della stabilità dei sistemi sociali complessi.3. Il Marxismo si Adatta in Asia, Specialmente in Cina
La critica all’economia politica di Marx guarda ai legami sociali tra le cose, non solo a quelli di causa ed effetto o logici. Questo richiede modi nuovi di pensare. Alcuni studiosi, come Backhaus, pensano che forse Marx stesso abbia reso difficile capire bene il suo metodo scientifico, portando a interpretazioni che mescolano logica e storia. Questo punto di vista critico suggerisce che Marx non ha pensato abbastanza in modo filosofico su come lavorava. Il pensiero di Marx è arrivato in Asia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Eventi importanti come le guerre tra Cina e Giappone e tra Russia e Giappone hanno aiutato la sua diffusione. In Asia, il marxismo ha dovuto cambiare per adattarsi a situazioni molto diverse dall’Europa. Spesso questo è successo grazie alle idee di Lenin. Il Giappone è stato uno dei primi paesi a conoscere il socialismo e il marxismo. Lì ci si è concentrati sulla critica morale e sociale del capitalismo. Le traduzioni in giapponese dei testi di Marx sono state fondamentali per far arrivare queste idee anche in Cina.Il Marxismo prende forma in Cina con Mao
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Cina è diventata il luogo più importante per il marxismo in Asia. Il Partito Comunista Cinese ha iniziato a “rendere cinese” il marxismo. Hanno detto che il pensiero di Mao Zedong era la guida principale. Documenti ufficiali dicevano che le idee di Mao erano diverse dalle “linee sbagliate”, criticando chi seguiva troppo rigidamente le idee di Stalin. Mao ha sviluppato le sue teorie basandosi su scritti importanti come “Sulla pratica” e “Sulla contraddizione”. Ha dato molta importanza al lavoro e alla produzione, e a come l’economia e le altre parti della società si influenzano a vicenda. La lotta tra le classi non era vista solo in termini economici, ma anche come una questione di idee e coscienza politica. Il pensiero di Mao ha preso spunto anche da vecchie idee cinesi, come l’importanza di avere un capo forte e l’idea che la gente comune debba essere guidata correttamente. Negli anni successivi, soprattutto durante la Rivoluzione Culturale, Mao ha persino suggerito che le masse potessero agire da sole, anche senza seguire la guida centrale del partito.Il Marxismo in Cina dopo Mao
Quando Mao è morto nel 1976 e sono iniziate le riforme, il ruolo delle idee politiche in Cina è cambiato. L’ideologia non era più la base da cui partiva la politica. È diventata invece uno strumento per dire che la realtà era giusta e per aiutare il paese a modernizzarsi. L’ideologia si è adattata, usando nuove idee come il “socialismo con caratteristiche cinesi”. Le campagne politiche più recenti mostrano che il partito e le sue idee devono cambiare per affrontare le sfide di oggi. Questo significa includere nuovi gruppi nella società e risolvere problemi come le differenze tra ricchi e poveri. Anche il rapporto tra le idee politiche e la scienza è cambiato. La scienza è diventata fondamentale per la modernizzazione del paese.[/membership]Se il marxismo in Cina è diventato uno “strumento” per la modernizzazione e la giustificazione della realtà, adattandosi con “caratteristiche cinesi”, come si concilia questa evoluzione con i principi fondamentali di una teoria nata per criticare il capitalismo e promuovere la lotta di classe?
Il capitolo descrive una significativa trasformazione del ruolo dell’ideologia in Cina, specialmente nel periodo post-Mao, dove sembra passare da principio guida a strumento pragmatico al servizio dello stato e della modernizzazione. Questa evoluzione solleva interrogativi complessi sulla natura del “socialismo con caratteristiche cinesi” e sulla sua relazione con il marxismo classico. Per approfondire questa apparente contraddizione e comprendere meglio il processo di adattamento ideologico, è utile studiare la storia del Partito Comunista Cinese dopo il 1976, le dinamiche delle riforme economiche e le giustificazioni teoriche fornite dal regime. Discipline come la scienza politica, la sociologia e la storia del pensiero politico contemporaneo in Cina offrono prospettive essenziali. Approfondire il lavoro di autori che hanno analizzato la Cina post-Mao e l’evoluzione del suo sistema politico e ideologico può fornire il contesto necessario.4. Percorsi e Crisi del Pensiero Marxista
Le idee di Marx ed Engels arrivano in America Latina alla fine del 1800, portate da immigrati europei. Questo segna l’inizio della diffusione del pensiero marxista nella regione.Diffusione e primi movimenti in America Latina
I primi partiti socialisti nascono in questo periodo, seguiti dalla creazione dei partiti comunisti negli anni Venti, fortemente influenzati dalla Rivoluzione russa. Il marxismo si adatta e si sviluppa in modo diverso nei vari paesi, riflettendo le loro specifiche realtà sociali ed economiche. Gli anni Venti sono fondamentali per la nascita di un pensiero marxista che guarda alle condizioni locali. Figure come Mariátegui in Perù analizzano la realtà nazionale, legando la lotta contro l’imperialismo all’obiettivo del socialismo.Il marxismo tra gli anni Trenta e Cinquanta
Tra gli anni Trenta e Cinquanta, il marxismo acquisisce una grande influenza in America Latina. Questo è favorito da eventi globali importanti, come la lotta contro il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale. In questi decenni, prevale il marxismo-leninismo ispirato al modello stalinista. Questo approccio, pur portando a importanti studi storici e sociali, tende a semplificare e a volte a limitare la complessità della teoria originale. Accanto a questa corrente principale, esiste anche il trotskismo, che critica le posizioni dei partiti comunisti ufficiali.Crisi e rinnovamento dalla metà degli anni Cinquanta
Dalla metà degli anni Cinquanta, il marxismo-leninismo entra in una fase di crisi. Questo è dovuto in parte alle critiche mosse alla figura di Stalin e, in modo significativo, all’impatto della Rivoluzione Cubana. I partiti comunisti non riescono più a mantenere un controllo esclusivo sul pensiero marxista. La teoria si rinnova aprendosi a diverse correnti di pensiero europee, come quelle di Gramsci e Lukács. In questo periodo nascono e si sviluppano nuove teorie originali, tra cui la teoria della dipendenza, la sociologia critica e la teologia della liberazione, che cercano di interpretare la realtà latinoamericana attraverso lenti marxiste ma con specificità locali.Sfide e persistenza negli anni successivi
Gli anni Settanta sono segnati da sconfitte politiche per i movimenti di sinistra in molti paesi. Nonostante ciò, la riflessione marxista continua a essere vivace. Negli anni Ottanta, la caduta dei regimi del socialismo reale in Europa Orientale provoca nuove crisi all’interno dei partiti comunisti e socialisti. Tuttavia, questo porta anche a importanti dibattiti sulla democrazia e stimola una produzione intellettuale che non rinuncia all’analisi critica. Oggi, il pensiero marxista in America Latina è molto diversificato e continua a essere attivo, anche grazie al contributo di nuove generazioni di studiosi che ne esplorano le potenzialità in contesti contemporanei.Il marxismo nel mondo anglosassone: un percorso diverso
Nel mondo anglosassone, l’influenza del marxismo è stata meno marcata, almeno prima degli anni Sessanta. Negli anni Trenta si registrano alcuni contributi significativi, e dopo la Seconda Guerra Mondiale emergono importanti storici di orientamento marxista, soprattutto in Gran Bretagna.La svolta degli anni Sessanta e le nuove correnti
Gli anni Sessanta rappresentano una svolta importante. La nascita della Nuova Sinistra e un crescente interesse per il marxismo sviluppato in Europa portano a una maggiore diffusione e approfondimento delle idee marxiste. In questo periodo si sviluppano i cultural studies, che applicano l’analisi marxista alla cultura e alla società. Si accendono dibattiti intensi su autori come Althusser, che propone nuove interpretazioni della teoria marxista.Crisi, nuove teorie e persistenza attuale
Negli anni Ottanta, il marxismo nel mondo anglosassone affronta una crisi, dovuta sia alle sconfitte politiche dei movimenti di sinistra sia all’emergere di nuove teorie critiche, come quelle proposte da Foucault. Nasce il marxismo analitico, una corrente che cerca di applicare un rigore filosofico e logico alla teoria marxista, portando però alcuni dei suoi esponenti a spostarsi verso la filosofia della giustizia. La caduta dell’Unione Sovietica tra il 1989 e il 1991 rappresenta un duro colpo per molti, ma il pensiero marxista non scompare. Continua a essere studiato e sviluppato nelle università, in particolare negli Stati Uniti, e attraverso diverse correnti che cercano di unire l’analisi teorica all’impegno pratico.Se il marxismo è andato incontro a ripetute ‘crisi’ e si è ‘rinnovato’ aprendosi a correnti diversissime e generando teorie ‘originali’, cosa resta esattamente del pensiero di Marx ed Engels in queste nuove forme?
Il capitolo descrive un percorso storico interessante, segnato da diffusione, influenza, crisi e rinnovamento. Tuttavia, pur elencando diverse correnti e autori che hanno caratterizzato le varie fasi, non approfondisce in modo sufficiente il contenuto specifico di queste “nuove teorie originali” o di come l’apertura a “diverse correnti di pensiero europee” abbia effettivamente trasformato o mantenuto i nuclei centrali del pensiero marxista. Questo lascia aperta la questione fondamentale della continuità o della rottura teorica. Per comprendere meglio la persistenza e la diversificazione del pensiero marxista, è utile approfondire le specifiche tesi della teoria della dipendenza, dei cultural studies, del marxismo analitico, e confrontarle con i concetti fondamentali elaborati da Marx ed Engels. Approfondire autori come Gramsci, Lukács, Althusser, Wallerstein, Thompson, Cohen, oltre naturalmente a Marx ed Engels stessi, può aiutare a delineare i confini e le trasformazioni di questo pensiero nel tempo.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]