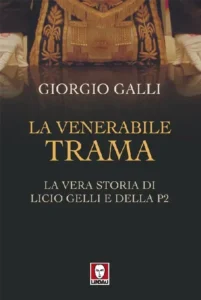1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Stalin e la sinistra parlarne senza paura” di Giorgio Galli è un libro che non ha paura di affrontare un argomento super complicato e spesso evitato: Stalin e il suo impatto, soprattutto per chi si riconosce nella sinistra oggi. Galli parte subito forte, dicendo che forse abbiamo sempre esagerato con le cifre delle vittime di Stalin, anche se pure i numeri più bassi che emergono dagli archivi restano comunque terribili. Non è per giustificare, ma per capire davvero la portata della repressione Staliniana nell’URSS, che è stata brutale ma forse diversa da come ce l’hanno sempre raccontata, legata anche all’arretratezza e all’isolamento della Russia di allora. Il libro non si ferma alle vittime: esplora come Stalin ha gestito la guerra, il patto con la Germania, l’attacco a sorpresa del ’41, e anche la corsa all’arma atomica, un capitolo cruciale della Guerra Fredda reso possibile anche grazie a scienziati che passavano informazioni. È affascinante vedere come la figura di Stalin venga vista oggi in Russia, quasi un eroe nazionale, un costruttore, un po’ come gli zar, staccato dal comunismo. Galli usa il concetto di “Mythistory” per spiegare come storia e mito si mescolino, soprattutto con personaggi così ingombranti. E in tutto questo, c’è la crisi della sinistra italiana, che fa fatica a fare i conti col passato, ma forse può trovare spunti nel ritorno di interesse per il Marxismo, per capire il capitalismo di oggi. È un invito a guardare la storia russa e il passato del comunismo senza filtri, per capire meglio il presente e trovare una strada per il futuro della sinistra.Riassunto Breve
L’opinione comune in Italia sulle vittime del regime di Stalin spesso esagera il numero, parlando di trenta milioni invece di stime più basse basate sugli archivi. Questa idea è influenzata da come la storia è stata raccontata, sia da chi è contro il liberalismo sia da chi è di sinistra ma contro Stalin. Anche se un milione di morti è già terribile, capire il numero esatto è importante per giudicare bene la storia e la politica, soprattutto per la sinistra di oggi. Le ricerche basate sui documenti aperti negli anni Novanta stimano le vittime dirette, tra esecuzioni e morti nei campi, intorno ai 2.700.000. Le vittime indirette, per via della collettivizzazione forzata e delle carestie, sono stimate tra i 4 e i 9 milioni. I deportati nei campi sono circa 12-13 milioni. Queste cifre, pur essendo enormi, sono inferiori alle stime più alte diffuse in passato. La repressione era molto dura, ma non perché ci fosse una forte opposizione organizzata. Nasceva dalla storia russa di potere assoluto, dalla povertà del paese e dal fatto che la rivoluzione era isolata. Ogni critica era vista come un complotto. L’industrializzazione veloce ha portato a un certo appoggio, anche per chi riusciva a migliorare la propria posizione sociale, ma creava anche problemi che il governo risolveva con la polizia invece che discutendo. Questa esperienza mostra che un governo autoritario può avere un po’ di consenso, ma a un costo umano altissimo. Sottolinea quanto sia fondamentale la democrazia e l’importanza di estenderla, anche nell’economia.Durante la Seconda Guerra Mondiale, i servizi segreti sovietici informavano Stalin sull’attacco tedesco e sul progetto atomico. Il patto del 1939 con la Germania serviva a entrambi per guadagnare tempo. Stalin lo usò per spostare i confini e creare una difesa. Nonostante le informazioni, Stalin non credeva che Hitler avrebbe attaccato nel giugno 1941, pensando che non avrebbe rischiato una guerra su due fronti. L’attacco fu una sorpresa. Stalin non si tirò indietro, ma reagì accentrando il potere per gestire la guerra.L’Unione Sovietica sviluppò l’arma atomica velocemente grazie anche a informazioni passate da scienziati comunisti occidentali. Stalin controllava tutto il progetto. Dopo il test americano del 1945, l’URSS accelerò e testò la sua prima bomba nel 1949, copiando il modello americano con l’aiuto dello spionaggio. La bomba all’idrogeno fu sviluppata dopo, senza questo aiuto. Si pensa che Stalin temesse un attacco nucleare americano. L’idea che preparasse una terza guerra mondiale è considerata una leggenda. Si concentrò sulla bomba all’idrogeno per avere un equilibrio di forze.Nella Russia di oggi, Stalin viene visto in modo diverso, a volte come un costruttore di industria e un eroe nazionale che ha reso la Russia grande, paragonato agli zar. Viene inserito più nella storia russa che solo in quella del comunismo.La storia si mescola con il mito, creando una “mitostoria”. Questo succede con figure come Stalin, viste sia per i dati sulle vittime sia come mostri inventati. Anche la storia “scientifica” crea miti. Oggi, la sinistra è in crisi, anche se ci sono più lavoratori e disuguaglianze. La maggior parte della sinistra non usa più il suo nome e si dice “riformista”. Alcuni criticano duramente il passato, vedendo i campi di lavoro (gulag) come il centro del sistema comunista, non solo un errore. La sinistra sembra non riuscire a proporre qualcosa di nuovo, divisa tra chi ripete vecchi schemi e chi copia il capitalismo. In questa situazione, c’è un nuovo interesse per le idee di Karl Marx. Nonostante i problemi dei regimi che si dicevano ispirati a lui, la sua analisi del capitalismo sembra ancora utile, specialmente dopo la crisi del 2008. Capire la “mitostoria” del passato serve per capire il presente e cercare nuove strade, magari pensando a come controllare in modo democratico il capitalismo finanziario.Riassunto Lungo
1. Stalin: Cifre, Percezione e Sfide per la Sinistra
Lo stalinismo è spesso associato a un numero esagerato di vittime, con stime che in Italia raggiungono i trenta milioni. Tuttavia, studi più accurati indicano circa nove milioni di morti, un dato comunque tragico ma inferiore alla percezione comune. Questa sovrastima è influenzata dalla storiografia liberaldemocratica e dall’antistalinismo di sinistra, che hanno contribuito a dipingere Stalin come un dittatore estremamente sanguinario.Cifre e contesto storico
Le vittime del regime stalinista includono coloro che morirono durante le purghe, le carestie e le deportazioni. Sebbene nove milioni siano una cifra enorme, rappresentano solo il 12% dei settantacinque milioni di morti causati dalle due guerre mondiali del Novecento. Questi conflitti, non iniziati dal comunismo, offrono un contesto per valutare la portata delle responsabilità di Stalin.Implicazioni per la sinistra
Lo stalinismo ha rappresentato un rifiuto della democrazia borghese occidentale, ma oggi la sinistra deve superare il senso di colpa legato a questo periodo. Per rafforzare la democrazia, non è sufficiente ispirarsi al liberalismo dell’Ottocento. È necessario creare un nuovo modello per il XXI secolo, basato su maggiore equità e partecipazione democratica.Perché il capitolo paragona le vittime dello stalinismo ai morti delle guerre mondiali senza considerare le differenze di contesto e intenzionalità?
Il capitolo, pur fornendo una riduzione delle cifre delle vittime dello stalinismo, commette un errore logico nel paragonarle ai morti delle guerre mondiali, ignorando il contesto storico e le intenzioni dietro tali eventi. Le guerre mondiali furono conflitti globali con molteplici attori e cause complesse, mentre lo stalinismo fu un sistema di governo che causò morti attraverso decisioni politiche interne. Per comprendere meglio queste dinamiche, è utile approfondire la storia del totalitarismo con autori come Hannah Arendt e studi specifici sulla politica stalinista, come quelli di Robert Conquest.2. Repressione e Consenso nell’URSS Staliniana
Le cifre delle vittime sotto Stalin, basate sugli archivi aperti negli anni Novanta, rivelano una repressione di vasta portata. Le vittime dirette, tra esecuzioni e morti nei campi, si stimano intorno ai 2.700.000. Quelle indirette, legate alla collettivizzazione forzata e alle carestie, oscillano tra i 4 e i 9 milioni. I deportati nei campi raggiungono i 12-13 milioni. Questi dati derivano da studi documentati, come quelli di Richard Overy e Alan Bullock, e si contrappongono a stime più elevate, come quelle di Robert Conquest.Origini della repressione
La spietatezza della repressione non era dovuta a una reale opposizione organizzata in grado di minacciare il regime. Non ci furono ribellioni significative, e il Partito era completamente allineato con Stalin. Le radici della repressione risiedono nella tradizione politica autocratica della Russia, unita all’arretratezza economica e all’isolamento della rivoluzione. Questo contesto portò alla soppressione di ogni forma di lotta politica legittima, trasformando critiche e alternative in accuse di cospirazione e sabotaggio.Industrializzazione e consenso
L’industrializzazione accelerata, pur vista come un successo, generava resistenze che il sistema autoritario non gestiva attraverso il dibattito, ma con l’apparato poliziesco e i processi. Nonostante ciò, il regime riuscì a creare un certo grado di consenso, legato alla mobilità sociale e ai privilegi per una nuova élite. Testimonianze dell’epoca, anche da osservatori stranieri, mostrano come l’inadeguatezza o la corruzione venissero trasformate in accuse di tradimento.Conseguenze e riflessioni
L’esperienza staliniana dimostra che un regime autoritario può generare consenso, ma a un prezzo altissimo in termini di vite umane e sofferenza. La democrazia, estesa anche alla sfera economica, rimane una sfida fondamentale per il presente e il futuro.Se la repressione non era dovuta a un’opposizione reale, come sostiene il capitolo, non si rischia di minimizzare il ruolo attivo del regime nello sterminio dei suoi stessi cittadini e compagni?
Il capitolo lega le origini della repressione a fattori strutturali e storici, come l’autocrazia russa e l’isolamento della rivoluzione. Tuttavia, questa prospettiva potrebbe non cogliere appieno la logica interna del regime staliniano, dove la creazione di “nemici del popolo” e la paranoia politica divennero motori autonomi del terrore, indipendentemente dall’esistenza di un’opposizione organizzata. Per approfondire questo aspetto, è utile considerare studi che analizzano le dinamiche interne del Partito, il ruolo dell’ideologia e la natura stessa del terrore come strumento di potere e controllo sociale. Autori come Robert Conquest o J. Arch Getty offrono prospettive diverse che possono aiutare a comprendere meglio la complessità delle cause della repressione staliniana.3. Il Patto, la Sorpresa e la Reazione di Stalin
I servizi segreti sovietici forniscono a Stalin informazioni cruciali sull’attacco tedesco e sul progetto atomico. Il patto di non aggressione tra Germania e URSS del 1939 è una mossa strategica di entrambi i leader per guadagnare tempo in vista di un conflitto ritenuto inevitabile. Stalin usa il patto per spostare i confini occidentali dell’URSS di centinaia di chilometri, creando un cuscinetto difensivo. Questa mossa, insieme alla resistenza dell’Armata Rossa, contribuisce al fallimento della Blitzkrieg tedesca nel 1941.La valutazione di Stalin e l’attacco tedesco
Nonostante le informazioni precise ricevute da spie come Richard Sorge e agenti britannici filo-sovietici (i cosiddetti “magnifici cinque”), Stalin non crede che Hitler attaccherà l’URSS nel giugno 1941. La sua valutazione si basa sull’idea che Hitler non rischierebbe una guerra su due fronti senza prima essersi assicurato il fronte occidentale. Questa convinzione è legata al misterioso volo di Rudolf Hess in Inghilterra nel maggio 1941. Stalin è informato del fallimento della missione di Hess, che non riesce a ottenere un accordo di pace con l’Inghilterra. Tuttavia, non considera la possibilità che Hitler attacchi comunque.La reazione di Stalin e l’accentramento del potere
L’attacco tedesco del 22 giugno 1941 coglie l’URSS di sorpresa, nonostante le informazioni ricevute. Contrariamente a quanto affermato in seguito da Krusciov, Stalin non si ritira né abbandona la leadership nei primi giorni di guerra. I registri delle visite al Cremlino mostrano un’intensa attività e riunioni continue. Stalin reagisce prontamente alla crisi, anche se l’attacco rappresenta un duro colpo per lui, che non ha utilizzato appieno le informazioni ricevute. Le esigenze della guerra portano a un ulteriore accentramento del potere nelle mani di Stalin. Viene istituito il Comitato per la Difesa dello Stato (GKO), che diventa il supremo organo decisionale, marginalizzando il Politburo e il Comitato Centrale. Stalin assume il titolo di Comandante in capo supremo, consolidando la sua dittatura personale. Il rinvio dell’Operazione Barbarossa, inizialmente prevista per maggio 1941, è causato dal colpo di Stato in Jugoslavia nel marzo 1941, influenzato dall’attività diplomatica e di intelligence sovietica e britannica, non dall’attacco italiano alla Grecia come sostenuto da Hitler.Perché il capitolo attribuisce a Stalin un ruolo così centrale nello sviluppo nucleare sovietico senza approfondire il contesto politico e scientifico dell’epoca?
Il capitolo sembra semplificare eccessivamente il ruolo di Stalin, presentandolo come l’unico decisore e motore del programma nucleare sovietico, senza considerare adeguatamente il contesto politico interno, le dinamiche del Partito Comunista e il contributo di altri attori chiave. Inoltre, non viene approfondito il contesto scientifico internazionale, né il ruolo delle reti di spionaggio al di là dei nomi citati. Per una visione più equilibrata, sarebbe utile approfondire autori come David Holloway, che analizzano il programma nucleare sovietico in modo più dettagliato, e studiare il contesto geopolitico della Guerra Fredda per comprendere meglio le pressioni e le motivazioni dietro le scelte di Stalin.5. Tra Storia e Mito: La Crisi della Sinistra e il Ritorno di Marx
La storia e il mito si intrecciano in un confine incerto chiamato “Mythistory”. Questo concetto si applica a figure storiche come Stalin, la cui immagine oscilla tra i dati scientifici delle milioni di vittime e la costruzione mitologica che lo ritrae come un mostro sadico e paranoico. Le morti dei dittatori sono spesso avvolte nel mistero, alimentando ulteriormente il mito. Anche la storia “scientifica”, fin dalle sue origini con Ranke e Humboldt, contribuisce alla creazione di miti, come i miti nazionali o quelli legati a figure politiche del XX secolo come Hitler e Mussolini. Persino la Bibbia, pur priva di riscontri archeologici per molte figure centrali, funziona come una saga mitica per la costruzione di un’identità nazionale.La crisi della sinistra
Oggi, la sinistra affronta una profonda crisi, specialmente in Italia. Nonostante l’aumento dei salariati e delle disuguaglianze, basi storiche della sua azione, la sinistra appare in difficoltà. La componente maggioritaria rinuncia al proprio nome, definendosi “riformista”. Voci interne criticano duramente il passato, vedendo il gulag non come un’ombra, ma come il cuore del sistema comunista, un fantasma che pesa ancora. La sinistra è percepita come incapace di offrire un’alternativa credibile, divisa tra chi ripete vecchi schemi e chi imita il capitalismo.Il ritorno di Marx
In questo contesto di crisi, si osserva un rinnovato interesse per il pensiero di Karl Marx. Nonostante le degenerazioni storiche associate a Lenin e Stalin, l’analisi teorica di Marx sul capitalismo riemerge, specialmente durante la crisi finanziaria del 2008. Università e persino figure politiche riconoscono la validità di alcune sue critiche al sistema economico. Questo ritorno di Marx suggerisce la necessità di confrontarsi con la “mitostoria” del passato per comprendere il presente e cercare nuove strade, forse esplorando l’idea di un controllo democratico sul capitalismo finanziario.Ma la “Mythistory” è davvero la chiave per capire la crisi della sinistra e il ritorno di Marx, o rischia di essere un’etichetta che confonde più che chiarire?
Il capitolo introduce l’interessante concetto di “Mythistory” per analizzare figure storiche e persino testi fondativi, ma il suo legame esplicito e funzionale con la crisi attuale della sinistra e il rinnovato interesse per Marx non è pienamente sviluppato. Sebbene sia chiaro che la sinistra debba confrontarsi con il proprio passato “mitostorico” (il peso del gulag, le figure dei dittatori), non è immediatamente evidente come l’analisi della storia come mito aiuti concretamente a superare la crisi politica o a rendere l’analisi marxiana più applicabile oggi. Per approfondire questo nodo cruciale, sarebbe utile esplorare studi sulla memoria collettiva e sul suo impatto politico, oltre a letture che analizzino le cause specifiche e multifattoriali della crisi dei partiti di sinistra nel XXI secolo, che vanno oltre la sola eredità storica. Approfondire autori che si occupano di teoria politica contemporanea e di storia delle idee può offrire strumenti critici per discernere quanto del passato sia un peso mitologico e quanto invece un’eredità politica concreta da affrontare.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]