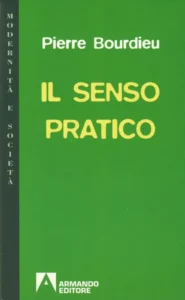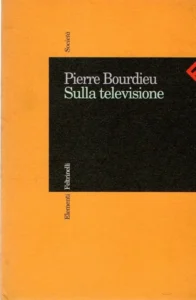1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Sociologia generale. La logica della ricerca sociale” di Pierre Bourdieu non è il solito manuale che ti spiega la società dall’alto. È più un’indagine profonda su come funziona davvero il mondo sociale, partendo da un’idea che sembra semplice ma è potentissima: la classificazione. Bourdieu ci fa vedere che la sociologia non solo classifica le persone e le istituzioni, ma deve fare i conti col fatto che sono loro stesse a classificare, e queste classificazioni non sono mai neutre. Sono il cuore di lotte sociali per decidere chi è chi e cosa conta. Il libro esplora come queste rappresentazioni sociali e le classificazioni ufficiali abbiano un potere simbolico enorme, capaci di creare la realtà e definire chi ha autorità. Per capire tutto questo, Bourdieu ci porta dentro la “doppia realtà del sociale”, introducendo concetti chiave come l’habitus, che è il sociale che ci portiamo dentro, incorporato nei nostri modi di fare, e il campo sociale, che sono le strutture oggettive in cui ci muoviamo. Non si tratta solo di teoria; è un modo per analizzare la logica della ricerca sociale, capire la differenza tra la conoscenza pratica di tutti i giorni e quella scientifica, e vedere come anche concetti come l’homo oeconomicus o il potere dello Stato siano parte di queste dinamiche di classificazione e delega. È un libro che ti fa guardare il mondo con occhi diversi, capendo che la lotta per definire la realtà è una battaglia costante e fondamentale.Riassunto Breve
Il mondo sociale è già diviso e organizzato dalle persone che lo abitano, a differenza di quello studiato dalle scienze naturali dove gli oggetti non classificano. Queste classificazioni sociali non sono solo modi per descrivere le cose, ma sono parte di lotte per decidere quale sia la visione giusta e riconosciuta della realtà. Le etichette, i titoli, le nomine, ma anche gli insulti, hanno un potere concreto: possono dare status, definire chi sei e come devi essere trattato. Questo potere di far esistere le cose dicendole è il potere simbolico. Il sociologo deve studiare questo mondo già classificato, capendo che le divisioni che sembrano naturali sono in realtà il risultato di queste lotte e dei principi su cui si basano. Una scienza sociale fatta bene non guarda solo le cose dall’esterno in modo oggettivo, né si limita a pensare come pensano le persone; deve mettere insieme l’analisi delle strutture sociali concrete con il modo in cui le persone percepiscono e dividono il mondo. Concetti come habitus e campo aiutano a capire come le strutture sociali entrano dentro di noi (habitus) e come esistono fuori di noi negli spazi sociali (campo), superando l’idea che ci sia una separazione netta tra l’individuo e la società. La classificazione di tutti i giorni è pratica, serve per agire, e chi classifica mette in gioco la propria autorità. La classificazione scientifica cerca invece di essere oggettiva, usando dati misurabili per creare categorie che esistono nella realtà sociale, anche se questa oggettività è a sua volta qualcosa per cui si lotta, sia tra gli scienziati che nella società. C’è una differenza tra la conoscenza scientifica, complessa e basata su criteri oggettivi, e la conoscenza pratica che le persone usano quotidianamente, spesso senza pensarci troppo, per orientarsi. Confondere queste due cose, per esempio chiedendo alle persone di spiegare in modo teorico perché fanno quello che fanno, porta a capire male. Il mondo sociale è un campo di battaglia dove si scontrano diverse visioni e modi di dividere la realtà. Le idee e le parole non solo descrivono il mondo, ma lo creano e lo rendono reale. Chi riesce a imporre la propria visione accumula capitale simbolico, che è una forma di autorità riconosciuta. L’autorità di classificare dipende dalla forza del gruppo che la riconosce. I gruppi si formano e diventano forti accumulando capitale simbolico, che si fissa in cose come nomi e titoli. L’ufficializzazione rende pubbliche queste gerarchie e le rende legittime. L’istituzionalizzazione, per esempio nello Stato, rende questo potere più stabile. I gruppi spesso danno il loro potere a rappresentanti, come una specie di magia sociale, anche se c’è sempre il rischio che il rappresentante usi il potere per sé. Lo Stato è l’esempio più grande di questo, con il monopolio del potere simbolico legittimo. La realtà sociale esiste in due modi: nelle strutture esterne (campo) e dentro le persone, nei loro modi di fare e pensare (habitus). La sociologia studia la relazione tra queste due forme. Un’istituzione funziona solo quando queste due dimensioni si incontrano. Il compito della scienza sociale è capire come il sociale diventa cose e come entra nei corpi, e come si influenzano a vicenda. La conoscenza pratica, quella dell’habitus, ci fa agire in modo giusto nelle situazioni senza dover calcolare tutto, è come un “senso del gioco”. Molte teorie, come quella dell’uomo economico che pensa solo a massimizzare il guadagno, sbagliano perché proiettano un modo di pensare razionale astratto sulle persone, ignorando che i loro “interessi” nascono dalla società e dalla loro storia. Le azioni non sono solo reazioni o piani, ma nascono dall’incontro tra la storia delle strutture sociali e la storia delle persone. Le scienze sociali sono nate dopo altre scienze e a volte copiano modelli da altre discipline, il che può essere un problema se non si adattano alla realtà sociale. A volte una teoria è debole scientificamente ma molto forte nella società perché serve a mantenere un certo ordine. Capire la sua forza richiede di analizzare le dinamiche sociali che la sostengono.Riassunto Lungo
1. La scienza sociale e l’arte di classificare chi classifica
Il mondo sociale è un luogo dove le persone e le istituzioni classificano continuamente. A differenza degli oggetti studiati dalle scienze naturali, gli ‘oggetti’ della sociologia sono soggetti che a loro volta classificano. Queste classificazioni non sono mai neutrali: sono parte di una lotta costante per imporre una visione del mondo che sia considerata legittima. Le classificazioni ufficiali, come i titoli di studio o le cariche, hanno un potere concreto: costruiscono la realtà sociale, assegnano uno status e influenzano il modo in cui le persone vengono trattate. Anche le etichette informali, come gli insulti, sono tentativi di definire e categorizzare, e la loro efficacia dipende da chi le usa.Riconoscere e Interrogare le Classificazioni Esistenti
È fondamentale riconoscere che il mondo sociale è già organizzato da queste classificazioni preesistenti. Spesso queste divisioni appaiono come qualcosa di naturale o scontato. Per questo, è essenziale mettere in discussione queste categorie e capire su quali principi si basano.Un Approccio Integrato: Strutture e Classificazioni
Un approccio scientifico alla società non può basarsi solo su una visione oggettiva che ignora come le persone percepiscono e classificano il mondo. Allo stesso modo, non può limitarsi a una visione soggettiva che proietta le idee dello studioso sulla mente degli altri. È necessario unire l’analisi delle strutture oggettive con lo studio delle rappresentazioni e delle pratiche di classificazione usate dalle persone. Concetti come ‘habitus’ e ‘campo’ sono utili per capire questa relazione complessa tra le strutture che abbiamo dentro di noi (habitus) e gli spazi sociali organizzati (campo). Questo aiuta a superare la vecchia separazione tra soggetto e oggetto.Come l’Ordine Sociale si Mantiene e la Critica ai Modelli Semplificati
Comprendere questa dinamica permette di analizzare come l’ordine sociale si crea e si mantiene nel tempo, spesso rendendo ‘naturali’ le classificazioni esistenti. Questo modo di vedere le cose critica modelli semplificati, come quello dell”homo oeconomicus’. Questi modelli proiettano sugli individui una razionalità astratta, senza considerare come gli interessi delle persone nascono dalla società e ignorando il potere politico che certe teorie economiche possono avere.Se il mondo sociale è dominato da classificazioni imposte e interiorizzate (habitus), come si spiega la possibilità di cambiamento sociale, di resistenza o semplicemente di agire in modo non completamente determinato dalle strutture?
Il capitolo offre una visione potente di come le classificazioni plasmino la realtà sociale, ma il rischio è quello di un determinismo eccessivo. Concentrandosi sulla riproduzione dell’ordine attraverso l’habitus e il campo, si potrebbe trascurare la capacità degli individui di riflettere criticamente, innovare o agire in modi che sfidano le classificazioni esistenti. Per bilanciare questa prospettiva e comprendere meglio la dialettica tra struttura e agenzia, può essere utile esplorare autori come Anthony Giddens, che ha sviluppato la teoria della strutturazione, o Erving Goffman, che ha analizzato l’interazione sociale quotidiana e la presentazione del sé, offrendo un’altra lente su come gli individui navigano e utilizzano le categorie sociali.2. La Classificazione come Battaglia Sociale
Classificare le cose o le persone nella vita di tutti i giorni è un’azione concreta, fatta per motivi precisi e che richiede impegno.Classificare significa agire
Alcuni atti, come insultare qualcuno o dargli un nome, sono capaci di creare o distruggere la posizione di una persona o di una cosa. L’insulto, per esempio, è un modo privato di definire qualcuno, ma chi lo fa si espone a rischi. Questo è diverso dai riti ufficiali che abbassano la posizione di qualcuno, perché questi ultimi sono compiuti da un’autorità riconosciuta dal gruppo. Questo dimostra che dietro ogni classificazione c’è sempre una questione di potere e di chi ha l’autorità di definire.La classificazione scientifica e il mondo sociale
La classificazione usata nella scienza, specialmente nella sociologia, si trova di fronte a un mondo sociale che è già stato classificato dalle persone che ci vivono. Le persone usano classificazioni pratiche, spesso per migliorare la propria immagine o per affermare la propria posizione rispetto agli altri, non solo per capire meglio la realtà. Il sociologo, invece, cerca di creare una classificazione che sia il più possibile oggettiva. Cerca indicatori che possano mostrare aspetti della realtà sociale che le persone o le istituzioni non vedono o preferiscono nascondere.Le scelte non sono neutrali
Anche le azioni compiute nella ricerca, come organizzare e dare un codice ai dati raccolti, sono modi per costruire una certa visione del mondo sociale. Scegliere quali criteri usare per classificare non è una decisione neutra. Queste scelte riflettono e influenzano le lotte che avvengono nella società per stabilire quale sia la definizione “giusta” e riconosciuta della realtà. Una classificazione che vuole essere oggettiva cerca di descrivere la realtà basandosi su legami misurabili tra diversi criteri, creando gruppi che esistono in modo indipendente dalle opinioni. Tuttavia, questa stessa oggettività è un obiettivo per cui si lotta, sia tra gli scienziati che nella società in generale.Ma se la classificazione è intrinsecamente una ‘battaglia sociale’ legata al potere, come può la classificazione scientifica sfuggire a questa logica e rivendicare un’oggettività ‘indipendente dalle opinioni’?
Il capitolo giustamente sottolinea come ogni atto di classificazione, dalla vita quotidiana alla scienza, sia intriso di potere e rifletta le lotte sociali per imporre una visione della realtà. Tuttavia, la distinzione netta tra classificazione quotidiana (strategica) e classificazione scientifica (oggettiva) merita un approfondimento critico. È davvero possibile per la scienza sociale creare categorie che esistono “in modo indipendente dalle opinioni”, o l’oggettività scientifica è essa stessa un costrutto sociale, un risultato (temporaneo) di una specifica “battaglia” all’interno del campo scientifico? Per esplorare questa tensione, è utile confrontarsi con la sociologia della scienza e l’epistemologia delle scienze sociali, in particolare con autori come Pierre Bourdieu, che ha analizzato a fondo la costruzione sociale della realtà e il ruolo dei campi (incluso quello scientifico) nelle lotte per la definizione legittima del mondo sociale.3. La lotta per definire il mondo sociale
Nel mondo sociale, le persone usano classificazioni per capire la realtà. Ci sono due modi principali di farlo. Uno è la classificazione scientifica: è oggettiva, usa dati precisi e analizza la realtà in modo complesso. Non è il modo in cui la gente comune pensa ogni giorno. L’altro è la classificazione pratica: è quella che usano tutti, spesso senza pensarci. Si basa su idee semplici che aiutano a muoversi e agire nella vita di tutti i giorni.L’errore di confondere le prospettive
C’è un errore che capita spesso: si confondono questi due modi di conoscere la realtà. È come se si pensasse che le persone comuni usino il metodo scientifico per capire la propria vita. Questo succede, per esempio, nelle interviste. Quando si chiede a qualcuno di spiegare la sua posizione nella società, spesso non parla di come vive davvero, ma ripete idee che ha imparato. L’intervista stessa, come situazione, può cambiare le risposte.La lotta per imporre una visione
Il mondo sociale non è pacifico. C’è una lotta continua tra i diversi modi di classificare le cose e le persone. Questa lotta non è solo fatta di idee, ma serve a imporre un modo di vedere la realtà che diventi quello accettato da tutti. Il modo in cui le persone vedono il mondo sociale non è qualcosa di esterno alla realtà, ma ne fa parte. Le idee e le parole non solo raccontano il mondo, ma aiutano a crearlo e a farlo diventare reale.Il potere di dare significato
Questo potere di rendere reale quello che si dice è chiamato potere simbolico. Funziona quando si dà un nome a qualcosa o qualcuno, o quando lo si rende ufficiale. Questo trasforma le differenze che esistono nella realtà in distinzioni che tutti riconoscono e accettano come giuste. La lotta per il potere simbolico è quindi la lotta per far accettare la propria visione del mondo sociale come quella giusta. Chi ha questo potere accumula “capitale simbolico”, che significa avere riconoscimento e autorità. L’autorità di decidere come classificare le cose viene dal fatto che un gruppo di persone la riconosce. Più forte è il gruppo, più forte è l’autorità. Questa lotta include anche cercare di cambiare i confini tra i gruppi o di far sembrare sbagliati i modi di classificare degli altri.Ma come si studia un sapere che non è riflessivo senza cadere nell’errore intellettualista che si intende criticare?
Il capitolo propone l’idea di una “gnoseologia inferiore” per studiare il sapere pratico e incorporato che guida l’azione sociale, distinguendolo nettamente dalla conoscenza scientifica e razionale. Tuttavia, la sfida metodologica rimane aperta: come può una scienza, per sua natura basata sulla riflessione, sull’analisi e sulla costruzione di modelli teorici (anche se “inferiore”), accedere e descrivere adeguatamente un “senso del gioco” che per definizione opera al di sotto della soglia della coscienza e della razionalità esplicita? Il rischio è quello di reintrodurre, nel tentativo di analizzare il pratico, proprio le categorie intellettualistiche che il capitolo critica. Per esplorare questa tensione, può essere utile approfondire le metodologie della ricerca sociologica qualitativa, l’etnografia, e gli studi sulla cognizione implicita. Autori come Erving Goffman o Harold Garfinkel potrebbero offrire prospettive su come analizzare le pratiche quotidiane e il sapere incorporato senza ridurli a schemi puramente razionali.7. Scienze Sociali: Ritardo e Potere Sociale
Le scienze sociali sono nate più tardi rispetto ad altre discipline. Questo ritardo ha avuto un effetto sul loro sviluppo. Una conseguenza è stata la tendenza a copiare modelli da scienze considerate più avanti, come la matematica. Copiare questi modelli può creare problemi. A volte, chi li usa cerca di applicarli a situazioni sociali specifiche, invece di creare modelli che si adattino alla realtà che sta studiando. Questo modo di fare è considerato dannoso.Teorie deboli ma socialmente forti
Esiste una situazione in cui una teoria non è molto solida dal punto di vista scientifico, ma ha una grande forza nella società. La teoria economica viene spesso usata come esempio di questo. La sua forza non dipende dalla sua validità scientifica, ma dal fatto che ha funzioni importanti nella società. Aiuta a definire come è organizzata la società e influenza il modo in cui pensiamo. Cercare di criticare queste teorie solo con argomenti scientifici non funziona bene. Questo perché la loro vera forza sta nelle dinamiche sociali che le sostengono. Per capire perché sono così influenti, bisogna analizzare le forze sociali che le rendono potenti. Affrontare un’idea scientificamente debole ma molto forte nella società rende il lavoro sulle questioni sociali molto difficile.Ma se una teoria è “scientificamente debole”, come può la sua “forza sociale” giustificare la sua persistenza e la difficoltà di una critica basata sui fatti?
Il capitolo solleva un punto cruciale sulla distinzione tra validità scientifica e influenza sociale. Tuttavia, l’affermazione che una teoria possa essere “scientificamente debole” ma “socialmente forte” merita un’analisi più profonda. Cosa intendiamo esattamente per “debolezza scientifica” in questo contesto? E quali sono precisamente le “forze sociali” che sostengono tali teorie, rendendo inefficace la sola critica scientifica? Per esplorare queste complesse dinamiche, è fondamentale approfondire la sociologia della conoscenza e gli studi sulla scienza e la tecnologia. Autori come Michel Foucault o Pierre Bourdieu hanno offerto strumenti concettuali per analizzare come il potere e le strutture sociali influenzino la produzione e l’accettazione del sapere, fornendo una prospettiva diversa sulla presunta neutralità della scienza e sulle ragioni della persistenza di certe idee al di là della loro validità empirica.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]