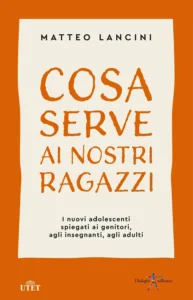Contenuti del libro
Informazioni
è un libro che ti fa pensare un sacco a come sono cambiate le cose tra genitori e figli oggi. Non siamo più nella famiglia di una volta, quella autoritaria, ma nemmeno in quella “narcisistica” dove contava solo il successo. Ora siamo in un’epoca post-narcisistica, segnata dalla fragilità adulta, dove gli adulti, invece di capire i bisogni veri dei ragazzi, proiettano le loro ansie, chiedendo ai figli di essere come li immaginano loro, creando un vuoto identitario. Il libro esplora questo disagio adolescenziale, non cercando una causa unica, tipo lo smartphone, ma il senso profondo dietro i comportamenti, anche quelli difficili. Parla di come la scuola spesso si concentra sui voti invece che sulla crescita, di come la funzione paterna sia in crisi, e di come gli adulti abbiano paura del mondo connesso, vietando invece di educare all’uso della tecnologia nella società onlife. Lancini dice che dobbiamo smetterla di controllare troppo, imparare l’alfabetizzazione emotiva, accettare il fallimento e usare la mentalizzazione per capire davvero chi sono gli adolescenti, rispettando la loro unicità invece di imporre divieti o cercare colpevoli esterni. È un invito a cambiare prospettiva sulla fragilità adulta e il mondo giovanile, a mettere da parte le paure per costruire un rapporto basato su fiducia, ascolto e comprensione.Riassunto Breve
La famiglia e la società cambiano, passando da un modello basato sull’autorità a uno più affettivo, fino alla fase attuale dove la fragilità degli adulti è evidente. In questa fase, gli adulti proiettano sui figli le proprie insicurezze e bisogni, chiedendo loro di essere una versione di sé stessi che corrisponde all’idea adulta, negando così i bisogni autentici del bambino. Questo crea un vuoto nell’identità dei giovani, che manifestano sofferenza non più per colpa o fallimento, ma per mancanza di un Sé vero. Di fronte ai comportamenti degli adolescenti, adulti e istituzioni cercano spesso una causa esterna, come la tecnologia, per placare l’ansia, invece di cercare il senso profondo di ciò che il giovane comunica. Comprendere significa accogliere il significato delle azioni, identificandosi con il disagio. Comportamenti difficili non sono sempre malattia, ma espressioni di dolore o tentativi di evitare sofferenze maggiori; banalizzarli impedisce di capire e aiutare. La scuola riflette questa tendenza, concentrandosi su voti e controllo invece che su apprendimento e sviluppo individuale. La figura paterna fatica a lasciare un’eredità e a sostenere il futuro dei figli, rischiando di essere assente o debole. Gli adulti devono superare la propria fragilità e concentrarsi sul supporto, riconoscendo l’unicità di ogni giovane. Attribuire alla tecnologia la colpa dei disagi ignora che sono gli adulti a promuoverne l’uso e che Internet è l’ambiente in cui i giovani crescono, spesso spinti online dalla paura adulta del mondo esterno. La scuola deve integrare la tecnologia, insegnando l’uso consapevole. Manca l’alfabetizzazione emotiva negli adulti, che evitano temi difficili come dolore e fallimento, impedendo ai giovani di esprimere le proprie sofferenze. La società orientata al successo rende il fallimento inaccettabile. L’eccessivo controllo adulto limita l’autonomia fisica dei ragazzi, spingendo le esperienze nel virtuale. La semplificazione dei conflitti in “bullismo” deriva dall’incapacità adulta di gestire la complessità delle relazioni giovanili. Punizioni come togliere lo smartphone sono inefficaci perché non affrontano le cause. Fondamentale è la mentalizzazione adulta, la capacità di comprendere i propri stati mentali e quelli degli altri per rispondere ai bisogni reali. Invece di incolpare la tecnologia, gli adulti devono rivedere i propri comportamenti, inclusa la sovraesposizione sui social media. È cruciale aggiungere fiducia, autonomia, mentalizzazione e ascolto nella relazione con i ragazzi, riducendo controllo e paure. La società è “onlife”, vita reale e virtuale sono unite. Le difficoltà dei giovani con la tecnologia riflettono fragilità adulte. Invece di vietare, che è inefficace e mina l’autorevolezza, si deve aiutare i giovani a vivere in questa realtà, sviluppando talenti. I videogiochi possono essere strumenti utili. Le campagne preventive basate sull’allarme non funzionano. Vietare è una reazione facile per l’ansia adulta, ma il compito è educare a gestire i rischi. Governare la rivoluzione digitale significa educare e responsabilizzare. Comportamenti a rischio sono spesso segnali di sofferenza profonda, legati a mancanza di prospettive e difficoltà emotive. La società evita il dolore (“algofobica”). La disregolazione emotiva nei giovani non dipende solo da mancanza di limiti, ma dal mancato riconoscimento dei loro bisogni ed emozioni da parte degli adulti. L’eccesso di narcisismo impedisce di riconoscere l’altro. La forza degli adulti fragili sta nel porre domande, cercando di capire chi è il giovane, interessandosi a come si definisce. Educare e sostenere è l’alternativa al vietare. Le azioni educative si basano su pensiero e affetto. È fondamentale far sentire ai giovani che le loro emozioni, anche dolorose, possono essere espresse. Chiedere ai figli cosa pensano di sé stessi e dei genitori richiede coraggio adulto. Esempi come squadre senza allenatore o scuole senza voti mostrano che dare autonomia e responsabilità è possibile, richiedendo agli adulti di uscire dalla zona di comfort, “togliendo qualcosa a noi stessi per aggiungere a loro”. Non esiste una ricetta standard; la base è conoscere e rispettare l’unicità di ogni giovane.Riassunto Lungo
1. Il Sé del Bambino nell’Era Postnarcisistica
Nel corso del tempo, la struttura della famiglia e il tessuto sociale hanno subìto profondi cambiamenti. Si è passati da un modello familiare basato su regole rigide e sul rispetto dell’autorità, dove il comando principale era “Devi obbedire!”, a un tipo di famiglia differente, che poneva al centro la relazione tra genitori e figli e l’espressione degli affetti. Questa evoluzione ha modificato profondamente il modo in cui i bambini crescono e sviluppano la propria identità.Dalla Famiglia Normativa alla Famiglia Narcisistica
Nella famiglia che potremmo definire “normativa”, l’accento era posto sul dovere e sull’obbedienza incondizionata. Le regole erano chiare e l’autorità dei genitori non veniva messa in discussione. Con il passaggio alla famiglia “narcisistica”, l’approccio è cambiato radicalmente. I genitori hanno abbandonato l’atteggiamento autoritario per privilegiare il legame affettivo e la promozione dell’espressività e della felicità dei figli.L’Investimento sull’Ideale e le Aspettative
In questo nuovo modello familiare, le regole vengono spiegate e motivate, e c’è un forte impegno da parte dei genitori nel sostenere l’ideale del sé del bambino e nel puntare al suo successo personale. Questo porta spesso i bambini a essere spinti a crescere troppo in fretta, quasi “adultizzati”, e a sentirsi addosso il peso di aspettative molto alte riguardo alle loro capacità e ai loro risultati.L’Avvento dell’Era Post-Narcisistica
Oggi ci troviamo in una fase successiva, definita post-narcisistica, influenzata anche da eventi globali come la pandemia. In questo contesto, un elemento cruciale è diventata la fragilità emotiva degli adulti. Nonostante l’attenzione e l’affetto che dimostrano verso i figli, molti adulti incontrano difficoltà a comprendere e riconoscere i veri bisogni dei bambini.La Proiezione degli Adulti sui Bambini
Accade spesso che gli adulti proiettino sui figli le proprie insicurezze e i propri desideri irrealizzati. Chiedono al bambino, in modo implicito o esplicito, di essere “se stesso”, ma in realtà intendono “se stesso nel modo in cui io ti immagino o desidero che tu sia”. Questo meccanismo impedisce al bambino di esprimere liberamente la propria autenticità.La Negazione dei Bisogni Autentici
Questa dinamica porta a una negazione profonda dei bisogni più genuini del bambino. Il bambino impara a sentirsi adeguato e accettato solo quando riesce a corrispondere all’immagine ideale che l’adulto ha costruito per lui. Viene quasi forzato a provare le emozioni e a pensare i pensieri che l’adulto gli attribuisce, anche se questo significa dover nascondere o negare le proprie vere sensazioni e paure.Il Rovesciamento dei Ruoli e il Vuoto Identitario
Non si tratta più di inseguire un ideale esterno imposto dalla società o dalla famiglia normativa. Ora il bambino è chiamato a confermare l’idea che l’adulto si è fatto di lui. Si verifica così un vero e proprio rovesciamento dei ruoli, dove i bisogni e le aspettative dell’adulto finiscono per prevalere su quelli del bambino. Questo processo può generare un profondo senso di vuoto e incertezza sull’identità nel bambino e nell’adolescente.Nuove Manifestazioni della Sofferenza
La sofferenza che ne deriva non è più legata al senso di colpa per non aver raggiunto un ideale o al fallimento nel rispettare le regole. Si manifesta piuttosto come una mancanza di un sé autentico, una difficoltà a sapere chi si è veramente, che si esprime attraverso nuove forme di disagio emotivo e comportamentale.Ma siamo sicuri che etichettare intere epoche familiari come ‘normativa’, ‘narcisistica’ e ‘post-narcisistica’ sia scientificamente fondato o non rischi di essere una semplificazione eccessiva?
Il capitolo presenta una progressione di modelli familiari, ma la definizione e la validazione empirica di queste categorie, in particolare “famiglia narcisistica” e “post-narcisistica”, non sono chiaramente esposte. Non è evidente se si tratti di costrutti ampiamente riconosciuti e supportati da consenso scientifico o di un’interpretazione specifica dell’autore. Per approfondire la complessità delle trasformazioni familiari e sociali, è utile esplorare la sociologia della famiglia e la psicologia dello sviluppo, confrontandosi con autori che hanno studiato i cambiamenti sociali e le loro ripercussioni sull’individuo e le relazioni, come Ulrich Beck, Anthony Giddens, Zygmunt Bauman o Erik Erikson.2. Oltre la Causa, Verso il Senso
Di fronte ai cambiamenti o ai comportamenti degli adolescenti, adulti come genitori e insegnanti spesso cercano una causa singola e esterna. Pensano subito allo smartphone, a un evento difficile, o a qualcosa di preciso che spieghi tutto. Questa ricerca nasce spesso dall’ansia degli adulti, dal loro bisogno di trovare una spiegazione rapida o un colpevole per ciò che non capiscono. Però, l’identità di un adolescente oggi si forma sotto l’influenza di tantissime cose diverse, e questo rende quasi impossibile trovare una causa unica per i loro comportamenti.Cercare il senso, non la causa
È molto più utile provare a capire il senso del comportamento di un adolescente. Comprendere significa entrare con la mente nel significato di quello che l’adolescente sta comunicando con le sue azioni. Bisogna tenere conto della sua età, della sua storia personale e di tutto quello che lo circonda. Non basta ascoltare le parole; è fondamentale provare a mettersi nei panni dell’adolescente e sentire il disagio che sta provando.Capire i segnali di disagio
Comportamenti come essere tristi, isolarsi dagli altri o pensare al suicidio non sono sempre un segno di malattia mentale da etichettare subito. Spesso, questi modi di fare sono un tentativo di mostrare un dolore molto forte o di evitare qualcosa di ancora peggio. Minimizzare questi segnali o dare una diagnosi affrettata impedisce di capire il vero significato della sofferenza dell’adolescente e, di conseguenza, di offrirgli l’aiuto giusto.La scuola e la valutazione
Anche la scuola, a volte, riflette questa tendenza degli adulti. L’uso dei voti con numeri, delle note e delle bocciature si concentra più sul risultato e sul controllo che sull’aiutare l’apprendimento e lo sviluppo di ogni ragazzo. Il voto numerico è spesso una valutazione personale dell’insegnante, crea una competizione che fa male e può togliere la voglia di imparare, allontanando l’attenzione dallo scopo vero dell’istruzione. Un modo di valutare che descrive i progressi, dà consigli e offre supporto è molto più utile per aiutare uno studente a crescere.La funzione paterna oggi
Oggi si vede anche una crisi nel ruolo del padre, che fa fatica a lasciare qualcosa di importante ai figli e a sostenerli nel presente e per il loro futuro. La figura del padre, che di solito aiuta a staccarsi dalla famiglia per andare verso il mondo esterno, rischia di essere assente, debole o troppo legata al rapporto di coppia. Il ruolo del padre oggi dovrebbe essere quello di mostrare che sbagliare e affrontare difficoltà fa parte della vita. Dovrebbe aiutare i figli a costruire il loro futuro, mettendo le loro esigenze al primo posto.La responsabilità degli adulti
Adulti e istituzioni devono superare le proprie insicurezze. Devono smettere di proiettare le loro paure sugli adolescenti e concentrarsi invece sull’offrire supporto e comprensione. È importante riconoscere che ogni giovane è unico e che i loro comportamenti hanno un significato profondo, sono espressione del loro percorso di crescita.Eliminare i voti numerici risolve davvero i problemi della scuola, o ne crea di nuovi in termini di valutazione e selezione?
Il capitolo critica giustamente l’uso dei voti numerici e delle bocciature, evidenziandone i limiti nel promuovere l’apprendimento e il benessere degli studenti. Tuttavia, non affronta in modo approfondito le sfide pratiche che sorgerebbero in un sistema educativo su larga scala basato esclusivamente su valutazioni descrittive. Come si garantirebbero standard uniformi? Come si effettuerebbero selezioni per percorsi di studio superiori o professionali che richiedono una qualche forma di comparazione oggettiva? Per esplorare queste complessità, è utile approfondire la teoria della valutazione educativa e le diverse metodologie di assessment. Le opere di autori come Alfie Kohn offrono una critica radicale dei sistemi di valutazione tradizionali, mentre altri studiosi del settore analizzano le necessità di standardizzazione e le alternative possibili.3. La Fragilità Adulta e il Mondo Connesso
Quando si parla dei problemi e delle difficoltà degli adolescenti, spesso gli adulti indicano come colpevoli Internet, gli smartphone e i social network. Questa idea, però, non considera che la rete è ampiamente usata e promossa dagli stessi adulti, dalle aziende e dalle istituzioni. Il mondo online non è solo una fonte di distrazione, ma l’ambiente in cui i ragazzi di oggi crescono e interagiscono. La tendenza dei giovani a cercare spazi di incontro virtuali è anche una conseguenza della paura che gli adulti provano verso il mondo esterno, visto come pieno di pericoli, e riflette la fragilità di chi ha il compito di educare.La Scuola e la Tecnologia
L’ambiente scolastico, fondamentale per la crescita, dovrebbe accogliere la tecnologia invece di escluderla. È importante che le scuole abbiano connessioni veloci e permettano l’uso dei dispositivi per imparare. In questo modo, si può insegnare ai ragazzi a usare la rete in modo responsabile, a capire l’importanza della privacy, a cercare informazioni affidabili e a riconoscere le notizie false. Strumenti come l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale offrono nuove e importanti possibilità per l’educazione, che non dovrebbero essere rifiutate per timore. La scuola ha il compito di preparare i giovani con le capacità che servono nel mondo di oggi e di domani.L’Alfabetizzazione Emotiva degli Adulti
Un punto cruciale è la capacità degli adulti di affrontare le emozioni, sia le proprie che quelle dei ragazzi. Spesso genitori e insegnanti evitano argomenti difficili come il dolore, il fallimento, la morte o il suicidio. Li considerano tabù o li trovano troppo pesanti da gestire a causa della loro stessa fragilità emotiva. Questo comportamento impedisce ai giovani di esprimere le proprie sofferenze e di imparare a gestire le emozioni negative. La società attuale, che spinge molto sul successo e sulla performance, rende il fallimento quasi inaccettabile. Questo porta i giovani a nascondere le loro difficoltà, a volte con conseguenze estreme. È fondamentale che gli adulti imparino ad ascoltare il disagio dei ragazzi, a dare spazio alle loro emozioni e a mostrare che sbagliare fa parte della vita e può essere un’occasione per crescere.Controllo, Esplorazione e Relazioni
La tendenza degli adulti a controllare troppo i figli, limitando la loro possibilità di esplorare il mondo fisico in autonomia, contribuisce a spostare le loro esperienze verso il virtuale. Inoltre, quando i conflitti normali tra ragazzi vengono subito etichettati come “bullismo”, questo spesso dipende dall’incapacità degli adulti di capire e gestire la complessità delle relazioni giovanili. Per affrontare questi temi in modo efficace, gli adulti devono prima riflettere sui propri comportamenti e sul modo in cui educano, invece di cercare sempre colpevoli fuori, nella tecnologia o nei giovani stessi.Se il capitolo critica il controllo eccessivo e le punizioni, quali sono i limiti di un approccio basato solo su fiducia e mentalizzazione?
Il capitolo presenta una critica forte e condivisibile all’eccesso di controllo e all’inefficacia delle punizioni basate su una logica semplicistica. Tuttavia, concentrandosi quasi esclusivamente sulla necessità di fiducia, autonomia e mentalizzazione, non esplora a sufficienza come stabilire confini e regole necessarie per lo sviluppo, né quali strumenti educativi siano efficaci quando la sola comprensione non basta. Per approfondire questo aspetto, è utile esplorare le diverse teorie sullo sviluppo adolescenziale e sui modelli educativi che bilanciano autonomia e struttura. Autori come D. Winnicott o S. Scharmer offrono spunti interessanti sulla relazione educativa e sulla gestione dei conflitti.5. Oltre i divieti: educare nella società onlife
La società di oggi è definita “onlife”, un ambiente dove la distinzione tra vita reale e vita virtuale è ormai superata e internet è diventato parte integrante dell’esistenza quotidiana. Le difficoltà che i giovani incontrano nell’uso di strumenti come smartphone, social network e videogiochi non sono solo un problema loro, ma spesso riflettono le insicurezze e le fragilità degli adulti. Invece di ricorrere a divieti e limitazioni, che si dimostrano inefficaci e danneggiano l’autorevolezza degli adulti, è fondamentale accompagnare i giovani a vivere pienamente in questa nuova realtà, aiutandoli a scoprire e sviluppare i propri talenti e a realizzare sé stessi.Strumenti digitali: non solo rischi
I videogiochi, ad esempio, non vanno visti unicamente come causa di dipendenza. Possono essere potenti strumenti per imparare, per la riabilitazione e persino per esplorare e accedere alle emozioni. Il gioco in generale ha la capacità di allenare la mente a gestire l’imprevisto e a trovare soluzioni creative. Le campagne preventive basate unicamente sull’allarme e sul divieto non ottengono i risultati sperati e finiscono per rendere gli adulti poco credibili agli occhi dei giovani. Vietare rappresenta spesso una reazione facile per gli adulti, un modo per placare le proprie ansie, ma il vero compito educativo è quello di insegnare ai giovani a muoversi nella società ipertecnologica, comprendendo e gestendo i rischi che essa comporta.Intelligenza Artificiale e la sfida educativa
Anche le discussioni sull’intelligenza artificiale seguono uno schema simile: la tentazione di vietare è forte perché sembra la via più semplice, ma non affronta le questioni complesse alla radice. La responsabilità di regolare la rete e le nuove tecnologie spetta alla politica e alle istituzioni. Il ruolo di genitori ed educatori è invece quello di fornire ai giovani gli strumenti per navigare in questa realtà in evoluzione. Gestire la rivoluzione digitale significa soprattutto educare e responsabilizzare le nuove generazioni, piuttosto che imporre regole che, nella pratica, vengono spesso aggirate o non rispettate. I giovani hanno un profondo bisogno di essere capiti e visti nelle loro esigenze di crescita e sviluppo.Comportamenti a rischio: segnali di sofferenza
Molti comportamenti considerati “a rischio”, come gli incidenti stradali tra giovani o i gesti di autolesionismo, non sono semplicemente il risultato di irresponsabilità o mancanza di regole chiare. Spesso sono manifestazioni evidenti di una sofferenza interiore profonda, legata alla mancanza di prospettive future, a difficoltà emotive non espresse o a un senso di inadeguatezza. La società attuale tende a fuggire dal dolore, manifestando una sorta di “algofobia”, negando o minimizzando la reale portata della sofferenza umana, soprattutto tra i più giovani. Le campagne di prevenzione efficaci dovrebbero invece affrontare con coraggio temi difficili e spesso tabù, come la morte o il suicidio, che purtroppo toccano da vicino molti adolescenti e giovani adulti.Emozioni non riconosciute e il ruolo adulto
La difficoltà dei giovani nel gestire le proprie emozioni (disregolazione emotiva) non deriva solo dall’assenza di limiti esterni. È spesso causata dal mancato riconoscimento e accoglimento dei loro bisogni e delle loro emozioni da parte delle figure adulte di riferimento. È urgente e necessaria una vera e propria “alfabetizzazione emotiva” rivolta agli adulti stessi. Un eccessivo ripiegamento su sé stessi, una forma di narcisismo, impedisce agli adulti di riconoscere l’altro, il giovane, come un individuo con propri bisogni, sentimenti e unicità.La forza delle domande e l’alternativa al divieto
La vera forza degli adulti, anche quando si sentono fragili, risiede nella capacità di porre le domande giuste. Si tratta di un impegno attivo per cercare di capire chi è veramente il giovane che si ha di fronte, interessandosi profondamente a come definisce sé stesso e a cosa motiva il suo comportamento. Educare e sostenere attivamente è l’unica alternativa valida e costruttiva al semplice atto di vietare. Le azioni educative efficaci devono essere guidate dal pensiero critico e dall’affetto sincero, non dalla ricerca di soluzioni rapide e superficiali ai problemi. È essenziale creare un ambiente in cui i giovani sentano che le loro emozioni, anche quelle più difficili e dolorose, possono essere liberamente espresse e comunicate senza paura di giudizio. Avere il coraggio di chiedere ai propri figli, o ai giovani con cui si interagisce, cosa pensano di sé stessi e del rapporto con gli adulti è un atto di profondo valore educativo che richiede coraggio e vulnerabilità da parte dell’adulto.Nuovi approcci educativi
Esistono già esempi concreti che dimostrano la possibilità di adottare approcci educativi diversi, capaci di promuovere l’autonomia e la responsabilità nei giovani. Pensiamo a squadre sportive giovanili che imparano a gestire le partite senza la presenza costante di un allenatore in panchina, o a scuole che sperimentano sistemi di valutazione diversi dai tradizionali voti numerici. Questi modelli richiedono agli adulti di uscire dalla propria “zona di comfort”, di essere disposti a “togliere qualcosa a noi stessi per aggiungere a loro”, cedendo un po’ di controllo per favorire la crescita dei giovani. Non esiste una “ricetta perfetta” o standardizzata valida per tutti nell’educazione. La base fondamentale è l’impegno costante a conoscere e rispettare l’unicità di ogni singolo giovane, proprio come uno chef esperto rispetta e valorizza la materia prima con cui lavora per creare qualcosa di unico.Se i comportamenti a rischio dei giovani sono “manifestazioni evidenti di una sofferenza interiore profonda”, non si rischia di minimizzare la responsabilità individuale o l’impatto di altri fattori sociali ed educativi, oltre alla presunta “algofobia” degli adulti?
Il capitolo lega in modo molto stretto i comportamenti a rischio dei giovani a una sofferenza interiore e alle fragilità degli adulti, in particolare a una presunta “algofobia” sociale. Questa visione, pur evidenziando aspetti cruciali, potrebbe non esaurire la complessità del fenomeno. Esistono forse altre concause, legate ad esempio a dinamiche sociali, culturali, o a specifici contesti educativi, che contribuiscono a tali comportamenti? Per approfondire la comprensione di queste dinamiche complesse, può essere utile esplorare studi nell’ambito della psicologia sociale, della sociologia dell’educazione e della criminologia minorile. Autori come Urie Bronfenbrenner o Albert Bandura offrono prospettive diverse sullo sviluppo umano e l’influenza dell’ambiente.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]