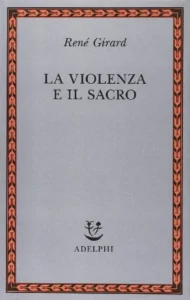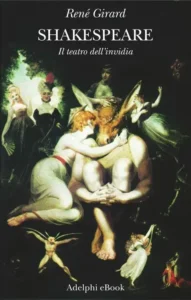Contenuti del libro
Informazioni
“Shakespeare. Il teatro dell’invidia” di René Girard ti fa vedere le opere del Bardo con occhi completamente diversi. Non si tratta solo di storie d’amore o di potere, ma di come il desiderio umano non sia mai spontaneo, ma nasca dall’imitazione del desiderio altrui, un concetto che Girard chiama “desiderio mimetico”. Questo libro esplora come questa dinamica, l’invidia e la rivalità che ne derivano, siano il vero motore dietro personaggi iconici e trame complesse in commedie come Sogno di una notte di mezza estate o Molto rumore per nulla, dove gli innamorati si inseguono in un caos di desideri copiati, o in tragedie come Giulio Cesare e Otello, mostrando come la gelosia e la violenza politica affondino le radici in questa imitazione. Girard analizza anche il meccanismo del sacrificio e del capro espiatorio, fondamentale per ristabilire un ordine sociale fragile, come si vede in opere che vanno da Troilo e Cressida a Il racconto d’inverno. È un viaggio affascinante nel teatro shakespeariano che svela le oscure dinamiche che legano il desiderio, la rivalità mimetica e la violenza, dimostrando quanto Shakespeare avesse capito la natura umana.Riassunto Breve
Nelle opere di Shakespeare, il desiderio non nasce da sé, ma imita quello degli altri, un fenomeno chiamato desiderio mimetico. Questo si vede chiaramente in “I Due Gentiluomini di Verona”, dove Proteo si innamora di Silvia solo perché il suo amico Valentino la desidera. L’amicizia stessa diventa un terreno dove l’imitazione può portare sia armonia che conflitto. Anche in “Lo Stupro di Lucrezia”, il desiderio di Tarquinio è innescato dall’elogio che Collatino fa della moglie, mostrando come l’invidia e le parole altrui possano scatenare passioni violente. “Sogno di una Notte di Mezza Estate” complica questo quadro con quattro innamorati che cambiano continuamente partner, non per capriccio, ma perché desiderano l’oggetto desiderato da un altro. L’instabilità amorosa diventa normale, con i personaggi che inseguono un’idea astratta di amore più che la persona reale, in un gioco di imitazione e rivalità senza fine. Elena, in particolare, desidera Demetrio non solo per sé, ma perché Ermia lo desidera, arrivando a voler “essere” come Ermia per ottenere quell’amore. Questo desiderio può assumere sfumature omoerotiche, non come deviazione, ma come conseguenza logica del mimetismo dove il mediatore diventa desiderabile. La rivalità mimetica destabilizza le identità, portando i personaggi a sentirsi ora bestie, ora divinità. Anche gli artigiani, come Rocchetto che vuole fare tutti i ruoli, mostrano una crisi di identità simile, legata all’imitazione. Il desiderio di imitare, nell’amore come nel teatro, ha la stessa radice: voler essere come l’altro.In “Molto Rumore per Nulla”, la paura di Beatrice e Benedetto di dichiararsi per primi nasce dalla consapevolezza del desiderio mimetico. L’intervento di Don Pedro come mediatore è fondamentale. Claudio desidera Ero solo finché pensa che il Principe Don Pedro la desideri, mostrando come il valore di una persona dipenda dal desiderio del mediatore. Il Principe stesso non sfugge a questa dinamica. “Come vi piace” usa il genere pastorale per mostrare il desiderio mimetico in modo quasi comico, come quando Rosalinda dice a Celia “Amalo perché io lo amo”. La superbia di Febe è uno specchio del desiderio di Silvio per lei; il suo amore di sé è costruito sull’ammirazione altrui. “La Dodicesima Notte” riprende questo tema con Olivia, il cui narcisismo è messo in crisi dall’indifferenza di Viola, spingendola a desiderare proprio chi la rifiuta. L’amore di sé non è fisso, ma dipende dal desiderio degli altri.In “Troilo e Cressida”, il desiderio mimetico influenza sia l’amore che la politica. Ulisse vede la rivalità tra i capi greci come una minaccia all’autorità, causata dall’imitazione reciproca. La fragilità dell’orgoglio di Achille dipende dagli “sguardi” altrui. Pandaro incarna il principio mimetico, manipolando i desideri di Troilo e Cressida. La crisi del “Degree”, l’ordine gerarchico, porta a un’indifferenziazione caotica, dove la rivalità distruttiva dilaga. Il teatro stesso, rappresentato da Pandaro, può amplificare questa “malattia” mimetica. La crisi del “Degree” si manifesta anche in “Sogno”, dove Ermia rifiuta l’autorità paterna per seguire desideri influenzati dai pari, e in “Re Lear”, dove Lear stesso scatena rivalità tra le figlie. In “Giulio Cesare”, la cospirazione contro Cesare nasce da rivalità e invidia mimetica, portando a una violenza indifferenziata. L’assassinio di Cesare è un atto mimetico, subito imitato dalla folla contro Cinna. Cesare diventa un capro espiatorio, una vittima scelta dalla violenza collettiva. L’assassinio è visto come un sacrificio per ristabilire l’ordine, ma il tentativo di Bruto di controllarlo fallisce; la violenza genera solo altra violenza. Shakespeare mostra come sacrificio e politica siano legati alla violenza mimetica.Il meccanismo sacrificale è visto come fondamento della cultura. In “Giulio Cesare” si vede l’assassinio fondatore che genera un nuovo ordine, anche se violento. In “Troilo e Cressida”, la “guerra di tutti contro tutti” si risolve in una violenza sacrificale (l’uccisione di Ettore). Anche in “Sogno”, Puck agisce come sostituto sacrificale, deviando la violenza potenziale. La catarsi teatrale stessa è legata al sacrificio, purificando dalla violenza mimetica. “Il Mercante di Venezia” e “Riccardo III” mostrano come la vendetta e la cupidigia siano diffuse, non solo in singoli personaggi, e come il meccanismo del capro espiatorio possa essere manipolato. L’ironia shakespeariana offre catarsi ma anche una critica profonda. Joyce riconosce in Shakespeare la centralità del desiderio mimetico e della frustrazione. L’esitazione di Amleto può essere vista come consapevolezza della spirale infinita della vendetta.In “Otello”, la gelosia nasce da un’insicurezza interna che spinge a cercare mediatori; Otello ammira Cassio e lo rende un modello, innescando la gelosia. Il desiderio si intensifica quando l’oggetto amato è desiderato da altri. Figure come Iago catalizzano dinamiche mimetiche preesistenti. Anche i sonetti shakespeariani mostrano la paradossalità del desiderio mimetico (amore/odio) e la gelosia nei triangoli amorosi. “Racconto d’inverno” porta la gelosia mimetica all’estremo con Leonte, che senza manipolazione esterna proietta le proprie insicurezze, causando disastro. La sua gelosia è un dramma interiore, non causato da un “villain” esterno come Iago o Don Juan. L’assenza di un antagonista smaschera la verità mimetica del desiderio, dove la colpa è nella dinamica stessa dei rapporti. L’opera esplora il peccato originale attraverso l’amicizia infantile, mostrando come il potenziale per il male sia intrinseco. Shakespeare critica anche l’ossessione per il realismo nell’arte; la statua di Ermione, che sembra imitazione ma è realtà, e il ritratto di Porzia che incanta più della persona, mostrano una crisi dove l’arte si allontana dall’Essere. Le opere tarde come “Racconto d’inverno” e “La Tempesta” mostrano una svolta, con temi di pentimento e resurrezione (“Racconto”) e autoriflessione (“Tempesta”, con Prospero/Shakespeare). Queste opere indagano illusione/realtà e desiderio/redenzione, segnando un’evoluzione nella riflessione shakespeariana sulla condizione umana e l’arte.Riassunto Lungo
1. L’Eco del Desiderio: Amore e Imitazione nel Teatro Shakespeariano
Il desiderio come imitazione
Nelle opere di Shakespeare, il desiderio non nasce in modo spontaneo. Sembra piuttosto che nasca dall’imitazione di qualcun altro. Questo tipo di desiderio, chiamato “desiderio mimetico”, è la forza che spinge le azioni in molte commedie, come “I Due Gentiluomini di Verona”.L’esempio dei “Due Gentiluomini di Verona”
In questa commedia, Proteo si interessa a Silvia non perché la trova attraente di persona, ma perché Valentino la ammira molto. Quindi, l’amicizia stessa diventa un terreno fertile per l’imitazione del desiderio. Questa imitazione può creare armonia, ma anche portare a conflitti molto distruttivi.L’esempio di “Lo Stupro di Lucrezia”
Anche nel poema “Lo Stupro di Lucrezia”, si vede come il desiderio nasce dall’imitazione. Tarquinio desidera Lucrezia perché Collatino, suo marito, la descrive in termini entusiastici. Questo esempio mostra come l’invidia e le parole degli altri possono scatenare passioni violente. L’opera mette in luce che la responsabilità del desiderio è condivisa: sia chi provoca il desiderio con le parole, sia chi lo mette in pratica con le azioni sono responsabili. In questo modo, la differenza tra eroe e persona cattiva si annulla.L’esempio di “Sogno di una Notte di Mezza Estate”
La commedia “Sogno di una Notte di Mezza Estate” rende questo schema ancora più complesso. In quest’opera, ci sono quattro innamorati che interagiscono tra loro in modo mimetico. Le loro infedeltà e i cambiamenti improvvisi nei loro affetti non sono semplicemente capricci. Sono, invece, il risultato di un desiderio che si nutre di ciò che desidera l’altro.Instabilità amorosa e dipendenza dal desiderio altrui
In questa commedia, l’amore è instabile e cambia continuamente. I personaggi non sono innamorati di persone reali, ma di un’idea astratta di amore. Così, entrano in un gioco continuo di imitazione e competizione. La commedia mostra una società in cui l’individualismo è solo apparente. In realtà, le persone dipendono profondamente dal desiderio degli altri, in un ciclo senza fine di attrazione e rifiuto reciproco.Ma il capitolo non rischia di ridurre la complessità del desiderio umano shakespeariano, focalizzandosi eccessivamente sul solo meccanismo dell’imitazione?
Il capitolo presenta un’analisi interessante del desiderio mimetico nelle opere di Shakespeare, supportata da esempi testuali pertinenti. Tuttavia, la centralità attribuita all’imitazione come unica origine del desiderio potrebbe risultare limitante. È utile considerare se altri fattori, come pulsioni individuali, contesti sociali specifici o dinamiche di potere, non contribuiscano in modo significativo alla genesi e all’evoluzione del desiderio nei personaggi shakespeariani. Approfondire le teorie psicoanalitiche di Freud, o le analisi sociologiche del desiderio in autori come Bourdieu, potrebbe offrire una prospettiva più ampia e articolata sul tema.2. La Notte Mimetica
Il desiderio mimetico di Elena
Nel “Sogno di una notte di mezza estate”, Elena è fondamentale per capire il desiderio mimetico. Il suo desiderio per Demetrio sembra costante, ma in realtà non è autonomo. Elena imita il desiderio degli altri, soprattutto quello rivolto a Ermia. Questo legame di imitazione con Ermia, simile a quello tra Valentino e Proteo, si fa sempre più forte. Elena arriva a desiderare non solo Demetrio, ma anche il modo di essere di Ermia.L’oggetto del desiderio diventa secondario
Il desiderio mimetico funziona così: l’oggetto desiderato passa in secondo piano rispetto alla persona che influenza il desiderio, chiamata mediatore. Elena è ossessionata da Ermia ed esprime un desiderio di tipo ontologico. Vuole “essere” come l’amica, perché la vede come un modello da imitare per conquistare l’amore di Demetrio.Il desiderio ontologico e l’omoerotismo
Questo desiderio di “essere” come Ermia porta con sé aspetti omoerotici. Non si tratta di una deviazione psicologica, ma di una conseguenza logica del desiderio mimetico. In questo meccanismo, il mediatore, cioè Ermia, diventa a sua volta oggetto di desiderio.Rivalità mimetica e instabilità delle identità
La notte di mezza estate amplifica la rivalità tra i personaggi, creando incertezza nelle loro identità. L’uso di paragoni con animali e divinità mostra questa instabilità. I personaggi si sentono ora come bestie, ora come dei, a seconda della loro posizione nella dinamica del desiderio. Questa confusione genera figure mostruose, che uniscono elementi opposti. Questi mostri sono il risultato della perdita di punti di riferimento e della confusione causata dalla competizione nel desiderio.La crisi mimetica degli artigiani
Anche gli artigiani, guidati da Rocchetto, vivono una crisi simile, legata all’imitazione. Il loro amore per il teatro e il desiderio di interpretare ruoli diversi li portano a perdere la propria identità, proprio come succede agli innamorati. Rocchetto vuole interpretare tutti i ruoli e rappresenta la natura contagiosa del desiderio mimetico.Rocchetto e il legame tra realtà e finzione
La trasformazione di Rocchetto in asino e il suo “matrimonio” con Titania sono il punto più alto di questa crisi. In questa situazione limite, la realtà e la finzione si mescolano completamente.Desiderio mimetico e imitazione estetica
Shakespeare mette in luce il legame profondo tra desiderio mimetico e imitazione nel campo dell’arte. La commedia dimostra che il desiderio di imitare, sia in amore che nel teatro, nasce dalla stessa radice: il desiderio di essere come un altro. Questa connessione tra desiderio e imitazione mette in discussione la tradizionale divisione filosofica tra amore e imitazione artistica. Shakespeare propone una visione unitaria e profonda della natura umana e dell’origine del mito, dove desiderio e imitazione sono forze strettamente intrecciate.Se il capitolo descrive il desiderio mimetico come una forza trainante universale, non rischia di semplificare eccessivamente la complessità delle motivazioni umane e le molteplici interpretazioni possibili di un’opera letteraria come “Sogno di una notte di mezza estate”?
Il capitolo presenta il desiderio mimetico come chiave interpretativa centrale, ma è fondamentale considerare se questa lente teorica non rischi di appiattire la ricchezza di significati e la varietà di approcci critici possibili al testo shakespeariano. Per rispondere a questa domanda, potrebbe essere utile esplorare altre teorie del desiderio, come quelle psicoanalitiche o sociologiche, e confrontarle con l’approccio mimetico. Inoltre, approfondire la critica letteraria su “Sogno di una notte di mezza estate” potrebbe rivelare interpretazioni alternative che tengono conto di fattori storici, culturali e retorici, oltre al meccanismo del desiderio mimetico.3. L’Eco Mimetico del Desiderio
Il desiderio mimetico nei drammi di Shakespeare
Nei drammi di Shakespeare, il desiderio si presenta come un meccanismo complesso e diffuso, basato sull’imitazione. Questo significa che, nelle opere come “Sogno di una Notte di Mezza Estate” e “Molto Rumore per Nulla”, i personaggi non desiderano in modo autonomo, ma sono spinti a desiderare ciò che desiderano gli altri.Il mito e il desiderio in “Sogno di una Notte di Mezza Estate”
Nel “Sogno di una Notte di Mezza Estate”, un dialogo tra Teseo e Ippolita introduce l’argomento della natura del mito. Ippolita sembra comprendere che il mito non è semplicemente frutto della fantasia individuale di Teseo, ma possiede una struttura e una dimensione collettiva. All’interno della commedia, si possono trovare diversi esempi di come il desiderio mimetico sia presente nelle dinamiche amorose. Un esempio è l’espressione “lasciar decidere d’amore gli occhi degli altri”, che mette in luce come le scelte in amore siano spesso influenzate dal desiderio che si osserva negli altri.La paura e la mediazione in “Molto Rumore per Nulla”
In “Molto Rumore per Nulla”, la relazione tra Beatrice e Benedetto offre un esempio di come la paura di dichiarare il proprio amore per primi sia legata al desiderio mimetico. I personaggi temono di esporsi perché sono consapevoli che il desiderio è influenzato dagli altri. In questo contesto, l’intervento di Don Pedro come mediatore assume un ruolo importante. La sua presenza evidenzia come le dinamiche sociali e la mediazione tra persone siano fondamentali nel far nascere e nel risolvere le questioni legate al desiderio amoroso. Un’altra frase chiave che riassume il concetto di desiderio mimetico è “amore che ferisce soltanto a sentir dire”. Questa espressione mostra come il desiderio possa diffondersi e intensificarsi semplicemente attraverso il racconto e le parole degli altri.L’influenza del mediatore sul desiderio di Claudio
Claudio, sempre in “Molto Rumore per Nulla”, rappresenta un esempio di quanto il desiderio mimetico possa essere fragile e mutevole. Il suo interesse per Ero cambia a seconda di quello che percepisce come il desiderio del Principe Don Pedro. Questo comportamento dimostra che il valore di ciò che si desidera non è intrinseco, ma dipende dal desiderio di una figura di riferimento, in questo caso Don Pedro, che funge da mediatore. È interessante notare che anche il Principe stesso, nonostante la sua posizione di autorità e influenza, non è immune al desiderio mimetico. Infatti, diventa sia mediatore del desiderio di Claudio, influenzandolo, sia imitatore, in quanto anche il suo desiderio può essere a sua volta influenzato dal contesto sociale.Conclusioni sul desiderio mimetico in Shakespeare
Shakespeare, attraverso queste opere, analizza a fondo come il desiderio umano non nasca spontaneamente, ma derivi dall’imitazione e dalla mediazione sociale. Il desiderio si plasma e si trasforma attraverso questi meccanismi, influenzando profondamente sia le relazioni tra individui che le dinamiche all’interno della società.Se la gelosia di Leonte è presentata come puramente auto-generata e derivante dal “peccato originale” e dal desiderio di imitazione, non si rischia di trascurare la complessità psicologica e sociale di tale emozione, riducendola a una mera condizione umana innata?
Il capitolo sembra concentrarsi eccessivamente sull’aspetto filosofico e teologico della gelosia, trascurando potenziali influenze psicologiche e sociali che potrebbero contribuire al comportamento di Leonte. Per una comprensione più completa, sarebbe utile esplorare le teorie psicologiche sulla gelosia, magari approfondendo autori come Freud o Melanie Klein, che hanno analizzato le dinamiche interne e le proiezioni psicologiche. Inoltre, una prospettiva sociologica potrebbe arricchire l’analisi, considerando come le dinamiche di potere e le aspettative sociali influenzino l’espressione e la percezione della gelosia.13. Dalla Pietra alla Tempesta: Conversione e Autoironia Shakespeariana
Le ultime opere di Shakespeare, in particolare “Il Racconto d’Inverno” e “La Tempesta”, segnano un cambiamento importante nel suo modo di scrivere. In questi lavori, si nota una maggiore attenzione all’autoriflessione e una comprensione più profonda del desiderio mimetico.Il Racconto d’Inverno: Pentimento e Rinascita
“Il Racconto d’Inverno” si concentra su temi come il pentimento e la rinascita, che si vedono chiaramente nella trasformazione di Leonte. La scena della statua di Ermione è molto importante e ha un significato simbolico profondo. All’inizio, la statua sembra essere un ostacolo alla verità e al riconoscimento. In realtà, diventa il mezzo attraverso cui avviene una rinascita spirituale. La diffidenza iniziale di Leonte verso la statua mostra la sua difficoltà ad accettare una realtà più profonda. Solo attraverso un percorso interiore di purificazione, Leonte riesce a superare questa resistenza.La Tempesta: Allegoria e Autoironia
“La Tempesta” è diversa e si presenta come un’opera allegorica e piena di autoironia. Prospero può essere visto come una rappresentazione di Shakespeare stesso, che riflette sul suo percorso artistico. I personaggi di Calibano e Ariel rappresentano due aspetti diversi del modo di creare di Shakespeare. Calibano simboleggia gli elementi più istintivi e meno controllati delle sue prime opere. Ariel, invece, rappresenta la parte più raffinata e elevata della sua arte matura.Illusione, Realtà e Redenzione nelle Opere Tarde
Sia “Il Racconto d’Inverno” che “La Tempesta”, pur essendo diverse, analizzano il rapporto tra apparenza e realtà, tra desiderio e redenzione. Questi temi mettono in luce un percorso di autocritica e di ricerca spirituale da parte di Shakespeare. Il tema della “resurrezione” ne “Il Racconto d’Inverno” e l’autoironia presente ne “La Tempesta” dimostrano un cambiamento importante nel modo in cui Shakespeare vedeva l’arte e la vita. Queste opere rappresentano un punto di arrivo nella sua riflessione sulla condizione umana e sulla natura stessa della scrittura.Se Prospero è davvero un autoritratto di Shakespeare, e Calibano e Ariel sue “muse”, non si rischia di ridurre la complessità di personaggi così ricchi a mere allegorie di un percorso artistico personale?
Il capitolo propone un’interpretazione allegorica affascinante, ma potrebbe semplificare eccessivamente la ricchezza dei personaggi shakespeariani. Per approfondire questa analisi, sarebbe utile esplorare la critica letteraria focalizzata sull’allegoria e il simbolismo, e confrontarsi con critici che offrono interpretazioni alternative di questi personaggi. Un autore da approfondire per comprendere meglio l’allegoria è Northrop Frye.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]