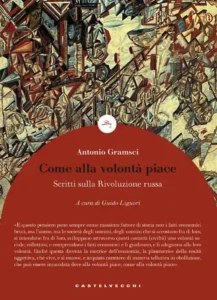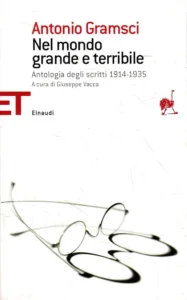Contenuti del libro
Informazioni
“Scritti scelti” di Antonio Gramsci è un libro che ti catapulta dentro la testa di uno che guardava l’Italia e il mondo in un momento pazzesco, tra la fine della Prima Guerra Mondiale e l’inizio del fascismo. Non è una storia, ma un’analisi super lucida su come cambiare la società. Gramsci parla della lotta di classe, di come il Partito Socialista, e poi quello Comunista, debbano essere la guida per la classe operaia e i contadini poveri. Spiega che non basta votare o fare riforme, serve una rivoluzione vera che crei uno Stato nuovo, basato sui Consigli operai nelle fabbriche, soprattutto nel Nord industriale come Torino e Milano. Critica un sacco la borghesia italiana, il fascismo che sta nascendo, e pure i partiti di sinistra che non capiscono cosa sta succedendo. C’è anche un’analisi della Rivoluzione Russa e di Lenin, vista come un esempio di volontà che cambia la storia. Gramsci insiste sull’importanza di avere una coscienza chiara, di studiare la storia d’Italia, anche la questione meridionale, per capire come agire. È un testo fondamentale per capire il pensiero comunista italiano e la storia di quegli anni, che ti fa vedere la politica non come un gioco di poltrone, ma come una battaglia per costruire un mondo diverso.Riassunto Breve
Il momento storico è grave e richiede soluzioni ai problemi del passato. Il Partito Socialista Italiano agisce come uno Stato in formazione contro quello borghese, basando la sua azione sulla lotta di classe. La “neutralità attiva e operante” del proletariato significa riportare la vita nazionale alla lotta di classe, spingendo la classe dominante a mostrare la sua incapacità e preparando il proletariato a sostituirla. La cultura non è solo sapere, ma organizzazione interiore e coscienza del proprio valore storico e della propria funzione, che si forma attraverso la critica della civiltà capitalistica. La forza dei socialisti italiani sta nel carattere, superando il sentimentalismo e agendo con volontà orientata a fini storici. La loro solidarietà è di classe, la loro nazione è l’Internazionale. L’ipocrisia è un tratto italiano, legato alla mancanza di libertà e fiducia. I massimalisti russi rappresentano la continuità della rivoluzione, impedendo compromessi e spingendo avanti il processo rivoluzionario, incarnando il pensiero che la volontà sociale può plasmare la storia. In Italia, le “scimmie giacobine” sono figure superficiali che imitano la storia senza comprenderla, contrastando con i “nuovi italiani” coscienti. L’intransigenza nell’azione richiede una volontà basata sulla ragione e tolleranza nella discussione che precede la decisione. La classe borghese italiana è più politica che economica, generando confusione. Il proletariato italiano ha sviluppato una coscienza di classe internazionale. La rivoluzione russa si basa sulla volontà collettiva, superando gli schemi storici previsti da Marx e usando le esperienze capitalistiche per costruire il collettivismo. Lo scioglimento della Costituente russa e l’ascesa dei Soviet rappresentano il superamento del parlamento borghese e la creazione di una rappresentanza diretta del proletariato. La società borghese, basata su diritti individuali e proprietà, concentra la libertà in pochi; la società proletaria, basata su diritti collettivi e lavoro organizzato, mira alla libertà per tutti attraverso l’associazione e l’eredità collettiva. Marx offre un metodo per comprendere la storia attraverso i rapporti di produzione e la lotta di classe. Lo Stato italiano è l’organizzazione della classe borghese, e il Partito socialista deve puntare a sostituirlo, non a conquistarlo. L’intransigenza di classe è necessaria per accelerare il processo storico. La rivoluzione russa non è utopica, ma basata sull’analisi della realtà e sulla lotta di classe, con i bolscevichi che guidano la dittatura del proletariato come strumento temporaneo per organizzare la società. La crisi delle ideologie e la formazione di nuovi partiti riflettono i cambiamenti sociali. Il fascismo emerge come forza violenta privata che serve gli interessi borghesi, indebolendo lo Stato. La crisi politica in Spagna mostra l’alleanza tra borghesia e militari contro il proletariato organizzato nei consigli. Lo Stato socialista esiste potenzialmente nelle istituzioni della classe lavoratrice (commissioni interne, circoli, comunità contadine); collegarle crea una democrazia operaia che si prepara a sostituire lo Stato borghese. La forza che porta al cambiamento è l’azione diretta delle masse. Lo Stato socialista è una creazione nuova, basata sull’esperienza associativa proletaria, che elimina concorrenza e classi. La guerra ha concentrato le masse e creato una nuova psicologia collettiva che deve essere organizzata in istituzioni permanenti (Consigli). La rivoluzione comunista è un problema di organizzazione e disciplina, unendo operai industriali e contadini poveri. La rivoluzione italiana si concentra nelle città industriali del Nord (Torino, Milano) come centri del nuovo Stato operaio. Lo Stato italiano non è mai stato liberale, ma una dittatura della classe proprietaria. La fabbrica è la cellula base del nuovo Stato operaio, rappresentando la classe operaia come forza produttiva organizzata. La crisi dei partiti riflette i cambiamenti nelle classi sociali; il fascismo incarna la decomposizione della piccola borghesia. Solo la classe operaia, con il comunismo, ha un programma per la ricostruzione e può creare uno Stato forte basato sui Soviet. Il Partito Socialista Italiano è eterogeneo e inefficace; i gruppi comunisti devono organizzarsi in un Partito Comunista disciplinato e centralizzato, l’unico strumento per costruire lo Stato operaio. Il Congresso di Livorno segna la separazione tra la classe operaia rivoluzionaria e le correnti corrotte, necessaria per l’indipendenza proletaria e l’alleanza tra operai del Nord e contadini del Sud. La rivoluzione italiana si inserisce nella rivoluzione mondiale e richiede disciplina verso l’Internazionale comunista. La legalità è definita dagli interessi della classe dominante; la legalità formale inganna le masse, mentre la legalità sostanziale (forza) prevale quando gli interessi padronali sono minacciati. La crisi del Partito Socialista riflette la crisi delle masse, frammentate dopo il fallimento dell’occupazione delle fabbriche. Il Partito Comunista nasce come organizzazione del solo proletariato industriale. La burocrazia sindacale si oppone ai partiti, agendo come “banchieri d’uomini” e non come cellula della società futura. La debolezza dei partiti proletari italiani deriva dalla mancanza di ideologia e conoscenza della realtà italiana; è necessario studiare il materialismo storico e la storia italiana. La crisi italiana si manifesta nel rapporto Stato-Mezzogiorno e nell’opposizione di settori borghesi. La questione meridionale è centrale per la rivoluzione, richiedendo l’alleanza tra proletariato e contadini del Sud. Il fallimento dei movimenti passati è dovuto alla mancanza di un’organizzazione capace di guidare le masse verso la conquista del potere e la creazione di un nuovo Stato. La crisi del regime fascista non è risolta dalla repressione, ma peggiora le condizioni delle classi medie e accelera la rovina economica. La crisi trova soluzione solo nel proletariato inserito nella rivoluzione mondiale. La crisi del fascismo si manifesta nelle elezioni e dopo il delitto Matteotti, creando un dualismo di poteri. Le opposizioni democratiche sono esitanti e temono l’insurrezione operaia. I comunisti si distaccano per mantenere il contatto con le masse e rompere il monopolio d’opinione. La crisi del fascismo risiede nella sua natura di organizzazione di massa della piccola borghesia senza un programma economico. La legge contro le associazioni segrete mira a colpire le organizzazioni operaie. Le debolezze strutturali del capitalismo italiano persistono. La crisi si svolge tra eventi parlamentari e il processo Matteotti. Il compito del partito comunista è conquistare la maggioranza della classe lavoratrice. La tattica del fronte unico avanza, mentre il blocco fascista si disgrega e si forma un blocco democratico di sinistra. La crisi capitalistica internazionale influenza i paesi periferici come l’Italia, con un raggruppamento a sinistra delle classi medie. La filosofia della praxis offre una chiave di lettura, vedendo la storia come produzione umana e lotta di classe, dove le ideologie sono realtà storiche legate alla struttura economica. La politica è volontà organizzata e razionale. La filosofia è presente in ogni individuo; elaborarla significa criticare la visione spontanea e diventare protagonisti storici. Il partito politico è l’organismo che forgia la volontà collettiva nazionale-popolare. L’azione politica si basa sull’analisi dei rapporti di forza e sulla costruzione dell’egemonia. In equilibrio instabile, può emergere il cesarismo. Il Risorgimento fu una “rivoluzione passiva” guidata dai moderati, che non integrò le masse popolari (contadini), creando un divario tra Nord e Sud e una mancanza di coesione nazionale profonda. La cultura italiana riflette questa distanza tra intellettuali e popolo.Riassunto Lungo
1. La Volontà e il Carattere Socialista
Il momento storico che stiamo vivendo è molto serio. Dobbiamo risolvere i problemi lasciati aperti dal passato per evitare che accadano nuove, gravi crisi. Il Partito Socialista Italiano (PSI) ha un compito preciso in Italia, essendo parte dell’Internazionale socialista. Agisce come se stesse costruendo un nuovo tipo di Stato, diverso da quello attuale guidato dalla borghesia, e crea gli strumenti per superarlo. Il Partito decide da solo come e quando portare avanti la sua lotta, che deve sempre rimanere una lotta tra classi sociali diverse.La Neutralità Attiva
Quando si parla di “neutralità” della classe lavoratrice, ci si riferisce a come agire in certe situazioni. All’inizio di una crisi grave, la “neutralità assoluta” può servire a creare una difesa forte e unita. Ma dopo questo primo momento, la neutralità assoluta aiuta solo chi non vuole agire e osserva gli eventi senza intervenire. Chi vuole il cambiamento, invece, trasforma questa posizione in una “neutralità attiva”.Essere attivamente neutrali significa riportare la vita del paese a essere una lotta tra le classi. La classe lavoratrice spinge chi sta al potere a prendersi le proprie responsabilità e a mostrare a tutti che non è capace, come quando ha portato il paese in una situazione difficile senza via d’uscita. Questo modo di agire rende di nuovo chiara la divisione tra le classi e libera il PSI dalle influenze della borghesia. Si dimostra a tutto il paese che chi governa non è all’altezza, e questo prepara la classe lavoratrice a prendere il suo posto e a realizzare un cambiamento profondo.La Cultura e la Coscienza di Classe
La cultura non è solo imparare tante cose a memoria. È un modo di organizzarsi dentro di sé, di essere padroni della propria persona e di raggiungere una maggiore consapevolezza. Permette di capire il proprio valore nella storia, il proprio ruolo nella vita, i propri diritti e i propri doveri. Questa consapevolezza non arriva da sola, ma si costruisce pensando e mettendo in discussione le cose. Ogni grande cambiamento nella società è stato preparato da un intenso lavoro culturale. Mettere in discussione la società capitalistica aiuta la classe lavoratrice a formare una coscienza unica e condivisa. Capire sé stessi significa avere il controllo di sé, distinguersi dal disordine generale, agire seguendo un proprio ordine e un proprio obiettivo. Per fare questo, è necessario anche conoscere gli altri e la storia.Il Carattere Socialista
La forza dei socialisti italiani sta nel loro carattere. Loro capiscono che esistono degli avversari, ma si sorprendono che questi avversari non riescano a capire che i socialisti esistono e sono diversi. Questa mancanza di comprensione da parte degli avversari nasce dalla loro mancanza di carattere. Il loro modo di pensare cambia facilmente, non hanno obiettivi chiari e si basano sui sentimenti, cosa che impedisce loro di essere coerenti.I socialisti italiani hanno mantenuto un carattere forte. Hanno superato il sentimentalismo e le emozioni passeggere come unica spinta ad agire insieme. Hanno costruito un modo di essere orientato verso obiettivi storici importanti, senza farsi ingannare dalle illusioni. La classe socialista, vista come un gruppo unito, non ha un “cuore” fatto di sentimenti, ma una volontà e un carattere che nascono dalla consapevolezza di essere una classe sociale, di avere i propri scopi e il proprio futuro. La sua solidarietà è solo tra persone della stessa classe, la sua lotta è solo una lotta di classe, la sua nazione è l’insieme dei lavoratori di tutto il mondo. Il suo cuore è la consapevolezza di essere una classe. Questo carattere è un contributo importante all’identità italiana.Come può una “neutralità attiva” essere davvero neutrale quando il suo scopo dichiarato è esacerbare la lotta di classe?
Il capitolo introduce il concetto di “neutralità attiva” come strategia, ma la sua definizione appare internamente contraddittoria. Se l’obiettivo è riportare la vita del paese alla lotta tra le classi e smascherare la classe dirigente, l’azione non è più neutrale, ma chiaramente orientata. Per comprendere meglio le dinamiche delle strategie politiche e la potenziale ambiguità dei termini, potrebbe essere utile approfondire la teoria politica, in particolare gli studi sulle strategie di movimento sociale e le teorie del conflitto. Autori come Machiavelli o Clausewitz (per l’analisi strategica) o teorici del conflitto sociale (come Simmel o Coser) potrebbero offrire prospettive diverse sulla coerenza tra mezzi e fini nell’azione politica.2. Caratteri, Rivoluzione e Stagnazione
L’ipocrisia è un tratto distintivo del carattere italiano, presente nella vita familiare, nella politica e negli affari. Questa sfiducia reciproca nasce dalla mancanza di libertà e da tradizioni basate su governi oppressivi e un’educazione rigida. L’ipocrisia diventa così una forma di difesa e una conseguenza diretta dell’assenza di garanzie per l’indipendenza morale e la sicurezza personale. La questione della libertà è fondamentale in Italia. La lettera anonima è un esempio concreto di questa ipocrisia e della mancanza di coraggio diffusa. Chi invece agisce con sincerità, si assume le proprie responsabilità e denuncia gli abusi, viene spesso punito con la perdita del lavoro o addirittura con l’incarcerazione. Questo accade a causa di una mentalità repressiva che soffoca la franchezza.Vecchie Mentalità e Stagnazione in Italia
Nel contesto italiano, emergono figure politiche che sono state definite “scimmie giacobine”. Si tratta di piccoli borghesi che si limitano a gesti superficiali, influenzati da una visione libresca e rigida della storia. La loro azione si basa su un’imitazione vuota della Rivoluzione francese, senza comprenderne la complessità. Non afferrano le vere leggi storiche e agiscono solo per obiettivi immediati e personali. Sono disposti a sacrificare la verità e la giustizia pur di distruggere i loro avversari. Rappresentano una vecchia mentalità italiana, meschina e populista. La loro agitazione, paradossalmente, serve a mettere in risalto i “nuovi italiani”. Questi ultimi hanno sviluppato una coscienza e un carattere più solidi, sentendo la necessità di distinguersi nettamente da queste figure vuote e superficiali.Il Contrasto: La Spinta Rivoluzionaria dei Massimalisti Russi
In forte contrasto con questa stagnazione, i massimalisti russi incarnano la continuità della rivoluzione. Il loro obiettivo è il raggiungimento del socialismo completo e impediscono compromessi definitivi che fermerebbero il processo. Essi fungono da simbolo della meta finale da raggiungere. Il loro compito è assicurarsi che i problemi del momento non blocchino la possibilità di ulteriori progressi e realizzazioni. La rivoluzione russa, grazie a loro, evita di chiudersi in un modello rigido, permettendo la diffusione di idee e la formazione di gruppi sempre più audaci che spingono avanti il cambiamento. I massimalisti sono uno stimolo costante contro la pigrizia e la staticità. Rovesciando i tentativi di fermare il processo rivoluzionario, dimostrano di essere autentici rivoluzionari, non semplici evoluzionisti. Sono convinti che sia possibile realizzare il socialismo in qualsiasi momento. Il loro pensiero prende forma in individui concreti, suscitando energie e creando forze capaci di controllare e sostituire coloro che si stancano lungo il cammino. La rivoluzione continua, trasformando la vita in un’attività incessante che impedisce la cristallizzazione delle idee e la formazione di minoranze autoritarie.Davvero i “massimalisti russi” rappresentano la pura e ininterrotta spinta rivoluzionaria, o il capitolo offre una visione eccessivamente semplificata e priva del necessario contesto storico?
Il capitolo contrappone la stagnazione italiana a una visione idealizzata della rivoluzione russa, incarnata dai massimalisti. Tuttavia, presentare questi ultimi come una forza pura e ininterrotta che evita compromessi definitivi e spinge costantemente verso il “socialismo completo” ignora le complessità, le lotte interne, i compromessi reali e le derive autoritarie che caratterizzarono il processo rivoluzionario russo nel corso del tempo. Per comprendere appieno questa dinamica e valutare la validità del contrasto proposto nel capitolo, è fondamentale approfondire la storia della rivoluzione russa e le diverse interpretazioni storiografiche al riguardo. Utile sarebbe la lettura di autori che hanno analizzato criticamente questo periodo, o studi più ampi sulla storia del comunismo.3. Volontà, Storia e Azione Collettiva
Perché un organismo sociale sia vivo e abbia uno scopo chiaro, è fondamentale l’intransigenza nell’azione. Questo significa che ogni sua parte deve essere coerente con il tutto, e che l’intero organismo deve basarsi su principi ben definiti. L’azione intransigente richiede che il gruppo abbia una volontà guidata dalla ragione, e che tutti i membri siano profondamente convinti della validità di questo scopo razionale. Tuttavia, questa intransigenza nell’azione è possibile solo se c’è stata tolleranza nella discussione che precede la decisione. La discussione collettiva è il momento cruciale per cercare la verità e la ragione, permettendo alle volontà individuali di fondersi in una volontà sociale condivisa. È necessaria la massima apertura e tolleranza durante questa fase affinché tutti possano comprendere appieno la decisione e sentirsi responsabili del suo esito. Questa tolleranza, però, non significa accettare l’errore, ma promuovere un dialogo sincero tra coloro che condividono i principi fondamentali. Al contrario, l’intolleranza rende impossibili accordi duraturi, portando a incertezza e alla disgregazione del tessuto sociale.La borghesia e il proletariato in Italia
In Italia, la classe borghese ha mostrato finora una natura più politica che economica. Questa distinzione ha creato confusione e favorito la corruzione. Il nazionalismo economico, ad esempio, è l’espressione dell’organizzazione di specifiche categorie borghesi che, attraverso un programma protezionistico, riescono a trasferire ricchezza sfruttando il potere dello Stato. Questo tipo di nazionalismo ha delle somiglianze con il riformismo che si osserva nel campo proletario: entrambi organizzano le persone per raggiungere obiettivi immediati, ma non riescono a far emergere una vera e profonda coscienza di classe. La coscienza di classe autentica, infatti, è per sua natura internazionale. Al contrario, il proletariato italiano ha raggiunto una maggiore maturità di pensiero aderendo al socialismo rivoluzionario. Attraverso questa visione, ha compreso i propri interessi di classe su scala internazionale, superando le limitazioni del riformismo. Sebbene la dottrina liberale sia la vera espressione della classe borghese, in Italia non è mai riuscita ad affermarsi pienamente.La Rivoluzione Russa e la forza della volontà
La rivoluzione russa guidata dai bolscevichi si fonda più sulla forza delle idee e della volontà che sulla rigida previsione dei fatti storici. In un certo senso, questa rivoluzione sembra andare “contro” quanto previsto nel “Capitale” di Marx, poiché i fatti concreti hanno superato gli schemi storici attesi per la Russia, che secondo la teoria avrebbe dovuto attraversare una fase capitalistica sviluppata. I bolscevichi dimostrano di non seguire Marx in modo dogmatico, ma di vivere il cuore del suo pensiero: l’idea che l’uomo e la volontà sociale collettiva siano i veri motori della storia, capaci di modellare la realtà economica stessa. La Prima Guerra Mondiale ha avuto un ruolo fondamentale nell’accelerare la formazione di questa forte volontà collettiva in Russia. Il popolo russo, avendo avuto modo di conoscere le esperienze socialiste maturate in altri paesi, sente di non dover attendere passivamente lo sviluppo capitalistico “previsto” da Marx. Sfrutterà piuttosto le esperienze del capitalismo occidentale per costruire il collettivismo in modo più rapido, creando attivamente le condizioni necessarie per realizzare il proprio ideale. Anche se inizialmente questo collettivismo potrebbe significare miseria, le stesse sofferenze sarebbero comunque presenti sotto un regime borghese, ma risulterebbero ancora meno sopportabili per un proletariato insoddisfatto. I bolscevichi, in questo contesto, rappresentano una forza indispensabile per impedire il collasso totale della società russa, riuscendo a incanalare le energie popolari verso un percorso di rigenerazione.Il capitolo dipinge il partito politico come l’incarnazione moderna del ‘Principe’, l’unico organismo capace di forgiare una volontà collettiva. Ma in un’epoca caratterizzata da reti diffuse, movimenti fluidi e crisi di rappresentanza, questa visione non rischia forse di essere anacronistica o, peggio, di ignorare altre forme emergenti di organizzazione e agency collettiva?
Il capitolo pone una forte enfasi sul ruolo centrale del partito politico nella costruzione della volontà collettiva, presentandolo quasi come l’unico attore capace di svolgere questa funzione nel mondo moderno. Tuttavia, questa prospettiva potrebbe trascurare la crescente complessità della società civile e l’emergere di diverse forme di organizzazione collettiva al di fuori delle strutture partitiche tradizionali, come i movimenti sociali, le reti civiche o le comunità digitali. Per approfondire questa tematica e comprendere meglio il panorama contemporaneo dell’azione collettiva e della rappresentanza, è utile esplorare gli studi nel campo della scienza politica e della sociologia, con particolare attenzione alle teorie sui movimenti sociali e sulla trasformazione dei partiti politici. Autori come Peter Mair hanno analizzato la crisi dei partiti di massa e l’evoluzione delle loro funzioni, offrendo spunti critici sulla loro capacità attuale di rappresentare e organizzare la volontà popolare in modo esclusivo.21. Il Risorgimento e il Popolo Assente
Le interpretazioni storiche del Risorgimento offrono punti di vista diversi. Alcuni studiosi lo vedono come un movimento nato in Italia, mentre altri pensano che derivi soprattutto dalla Rivoluzione francese. I rapporti tra gli stati europei e l’indebolimento del potere del Papa nel Settecento hanno creato le condizioni favorevoli all’unificazione. Tuttavia, una vera consapevolezza politica e la spinta a lottare per l’unità si sono sviluppate concretamente solo dopo il 1789. Questo sviluppo è stato fortemente influenzato dagli eventi in Francia.La Guida dei Moderati
Il processo di unificazione è stato guidato principalmente dai moderati. Questo gruppo sociale era piuttosto unito e compatto. Sono riusciti a imporre la loro direzione sia in politica che nella morale pubblica. Hanno gradualmente integrato al loro interno le persone più attive di altri schieramenti. Questo assorbimento è avvenuto anche a scapito del Partito d’Azione, attraverso un processo che è stato chiamato “trasformismo”.
Le Debolezze del Partito d’Azione
Il Partito d’Azione, invece, non è riuscito a diventare una forza capace di guidare il processo da solo. Gli mancava un programma chiaro e concreto. In particolare, non aveva idee precise su come affrontare la questione della terra, che avrebbe potuto mobilitare i contadini, specialmente quelli del Sud. La sua azione è rimasta spesso teorica e si è limitata a fare agitazione. Per questo motivo, ha finito per favorire, anche se indirettamente, gli interessi dei moderati. A differenza dei giacobini francesi, che seppero imporsi alla borghesia e unire la città con la campagna, il Partito d’Azione non è riuscito a creare un legame forte e reale con il popolo.
L’Esclusione Popolare e il Divario Nord-Sud
Un aspetto cruciale del Risorgimento è stata la mancata partecipazione delle masse popolari al processo unitario. I contadini, in particolare, sono rimasti esclusi. Le loro rivolte, come quella avvenuta in Sicilia nel 1860, sono state represse. Questa esclusione e repressione hanno portato a definire il Risorgimento come una “rivoluzione passiva”. Esiste ancora oggi una grande differenza tra il Nord e il Sud del paese. Questa differenza si manifesta come un rapporto tra una zona più sviluppata e industriale (il Nord) e una prevalentemente agricola (il Sud). Il Nord ha esercitato e continua a esercitare un dominio economico e politico sul Sud. Questo rapporto non è basato sull’uguaglianza. Contribuisce a una mancanza di unità nazionale profonda e sentita da tutti.
Cultura e Distanza dal Popolo
Anche la letteratura e la cultura italiane mostrano questa distanza tra chi scrive e il popolo. Manca una letteratura che sia veramente “nazionale e popolare”. Una letteratura che sappia sia esprimere i sentimenti delle masse che aiutarle a formare la propria coscienza. Per questo motivo, il pubblico ha spesso preferito leggere opere scritte da autori stranieri. Gli intellettuali italiani sono rimasti spesso legati a tradizioni astratte e lontane dalla realtà quotidiana. Non sono riusciti a svolgere un ruolo di educatori per il popolo.
Ma è davvero così semplice liquidare il divario Nord-Sud come una mera conseguenza dell’esclusione popolare nel Risorgimento?
Il capitolo lega strettamente la persistenza del divario tra Nord e Sud alla natura del processo unitario e alla mancata partecipazione popolare. Tuttavia, questa prospettiva rischia di trascurare le profonde differenze economiche, sociali e istituzionali che caratterizzavano le diverse aree della penisola prima dell’unificazione. Per comprendere appieno la complessità di questo rapporto, è fondamentale approfondire la storia economica e sociale pre-unitaria e post-unitaria, studiando autori che hanno analizzato le strutture agrarie, i sistemi produttivi e le politiche economiche dei diversi stati italiani e del Regno d’Italia, come ad esempio Rosario Romeo o Emilio Sereni.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]