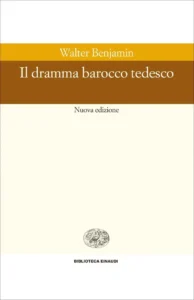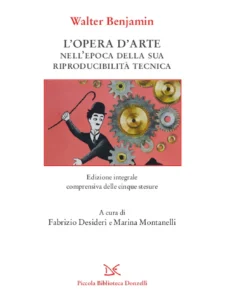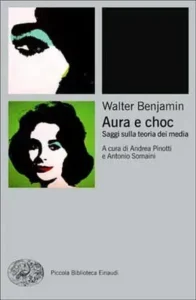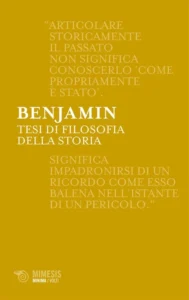Contenuti del libro
Informazioni
“Scritti 1938-1940” di Walter Benjamin raccoglie saggi potenti scritti in un periodo super difficile, quello dell’esilio e della crescente incertezza in Europa. Benjamin, una figura chiave della teoria critica, guarda con occhi nuovi all’eredità culturale e alla crisi della modernità, mettendo in discussione le idee tradizionali. Il libro spazia tantissimo, portandoci dalla Berlino della sua infanzia, piena di ricordi e scoperte urbane, alla Parigi di Baudelaire, esplorata attraverso la figura del flâneur e lo spleen della metropoli. Analizza l’opera d’arte nell’era della riproducibilità tecnica, pensando a come la fotografia e il cinema cambiano tutto, dalla percezione all’aura. Non mancano riflessioni profonde sulla storia, vista non come un progresso tranquillo ma come un campo di battaglia, e sulla letteratura, da Kafka a Brecht, fino al romanticismo tedesco e figure meno note come Jochmann. È un viaggio intellettuale che usa la critica culturale e la filosofia della storia per capire il presente, un mix di arte, storia e teoria che ti fa pensare in modo diverso.Riassunto Breve
In un periodo di grande incertezza politica in Europa, si sviluppa un forte bisogno di guardare in modo critico alla cultura e alla società. Non si accetta più l’idea di una cultura vista come qualcosa di fisso e intoccabile, ma si cerca di capire come le opere culturali nascono, vengono accolte e tramandate, considerando sempre il contesto storico e sociale. Questo approccio critico si vede, per esempio, nel modo in cui si rivaluta la pittura cinese delle dinastie Ming e Ch’ing, che prima era messa in ombra da altre epoche, riconoscendo il valore della calligrafia che unisce pensiero e immagine. Anche l’analisi della società borghese mette in luce come le strutture familiari e sociali influenzino le persone e come la critica all’egoismo sia più efficace di una sua difesa. L’esperienza di crescere in una grande città, come Berlino, mostra come i luoghi dell’infanzia (cortili, strade, giardini) diventino un modo per imparare a leggere i segni del mondo e anticipino le esperienze future, rivelando anche la perdita della sicurezza infantile. Figure come il flâneur, che vaga per la città, incarnano l’ozio in una società che invece esalta il lavoro, e diventano un simbolo della modernità urbana e della sua complessità. Si osserva come l’arte e la letteratura cambino profondamente in questo mondo moderno. L’opera di autori come Kafka e Brecht, per esempio, riflette la realtà politica e sociale, mostrando come la menzogna diventi un elemento centrale sotto regimi oppressivi e cercando nuove forme teatrali per rappresentare la crisi. Baudelaire è visto come una figura chiave per capire la modernità parigina, con il suo spleen, la sua esplorazione della folla e della prostituzione, e l’uso dell’allegoria come risposta alla crisi dell’arte. In questa epoca, l’arte subisce una trasformazione radicale a causa della riproducibilità tecnica, come la fotografia e il cinema. L’opera d’arte perde la sua “aura”, quella sensazione di unicità legata al suo essere qui e ora, e diventa accessibile a molti, cambiando il modo in cui le persone la percepiscono. Il cinema, in particolare, è una forma d’arte pensata per essere riprodotta e vista da un pubblico distratto e collettivo. Questa trasformazione dell’arte ha anche risvolti politici: mentre alcuni usano l’arte per scopi di propaganda, altri la vedono come uno strumento per aumentare la consapevolezza sociale. Anche l’idea di storia viene ripensata. Non si crede più a un progresso lineare e inevitabile, ma si vede la storia come un susseguirsi di eventi complessi e spesso catastrofici. Si propone un modo di guardare al passato che non sia passivo, ma che cerchi di recuperare le speranze e le esperienze degli oppressi nel presente. La diminuzione dell’importanza della poesia nella società moderna, vista da alcuni come un regresso, viene interpretata invece come un segno di progresso della ragione e del benessere sociale, dove altre forme di espressione diventano più rilevanti. Il percorso intellettuale di figure come Walter Benjamin, che studia il romanticismo, traduce Baudelaire, analizza il dramma barocco e riflette sull’opera d’arte nell’era della tecnica e sulla filosofia della storia, incarna questo sforzo continuo di comprendere criticamente la modernità e la sua eredità culturale in un mondo in crisi.Riassunto Lungo
1. Sguardi Critici sull’Eredità Culturale
In Europa, negli anni Trenta, un clima di incertezza politica crescente influenza profondamente il mondo intellettuale. Figure come Walter Benjamin vivono l’esperienza dell’esilio, e in questo contesto difficile si sente forte il bisogno di ripensare criticamente diversi aspetti della cultura e del sapere.La rivalutazione della pittura cinese
Un esempio di questa riflessione critica si trova nel mondo dell’arte, con un nuovo interesse per la pittura cinese. In particolare, si guarda con occhi nuovi alle dinastie Ming e Ch’ing, periodi storici spesso considerati meno importanti rispetto alle più famose dinastie Sung e Yuan. Questo nuovo punto di vista mette in discussione i preconcetti occidentali, apprezzando la profondità filosofica e la grande abilità tecnica della calligrafia cinese. La calligrafia viene vista come un’arte che unisce pensiero e immagine, superando la distinzione tra pittura e scrittura.La Scuola di Francoforte e la critica alla coscienza borghese
Parallelamente, a causa della fuga degli studiosi tedeschi iniziata nel 1933, l’Istituto per la Ricerca Sociale di Francoforte si dedica a un’analisi critica della mentalità borghese e delle tradizioni filosofiche occidentali. Questo istituto mette in discussione il positivismo e il pragmatismo, proponendo un metodo scientifico che tenga conto del contesto storico e sociale. Vengono studiate le dinamiche familiari e sociali, cercando di capire come le strutture di potere influenzino la vita interiore e le emozioni delle persone. Si nota come, nella società borghese, criticare l’egoismo sia più efficace che difenderlo apertamente.La crisi dell’idea di eredità culturale
In questo periodo di crisi, si mette in discussione l’idea stessa di eredità culturale, soprattutto quella tedesca e occidentale. Si critica un’idea di cultura “affermativa”, vista come qualcosa di statico e autocelebrativo. A questa visione si contrappone un approccio critico che esamina le condizioni concrete, il modo in cui le opere culturali vengono accolte e trasmesse. La sopravvivenza dell’eredità culturale dipende dalla capacità di trovare, nel difficile presente, gli elementi che possono ancora essere utili per una società futura e proteggere i valori umani fondamentali.Ma il capitolo definisce chiaramente cosa intende per “crisi dell’idea di eredità culturale”, o rischia di usare un termine vago per descrivere un cambiamento complesso e sfaccettato?
Il capitolo introduce la “crisi dell’idea di eredità culturale” come un punto centrale della riflessione degli anni Trenta, ma non approfondisce in modo specifico cosa si intenda per “crisi”. Per comprendere meglio l’argomentazione, sarebbe utile esplorare diverse interpretazioni del concetto di crisi culturale. Approfondire le opere di autori come Reinhart Koselleck, che ha analizzato la semantica storica del concetto di crisi, o studiosi della Scuola di Francoforte come Jürgen Habermas, che ha discusso la crisi di legittimazione nel capitalismo avanzato, potrebbe fornire strumenti concettuali più precisi per valutare se si tratti effettivamente di una crisi o di una trasformazione culturale profonda.2. Echi dell’Infanzia Berlinese
Ricordi d’infanzia nella grande città
L’infanzia passata in una grande città lascia ricordi particolari, diversi da quelli di chi è cresciuto in campagna. Questi ricordi urbani anticipano quello che succederà nella storia, mostrando come la sicurezza tipica dell’infanzia possa sparire. I cortili con i portici scuri diventano come delle culle in città, dove la città stessa mette al mondo i nuovi cittadini. Il ritmo del treno e il suono dei battipanni accompagnano i sogni dei bambini, fatti di viaggi e pioggia. Il cortile diventa un luogo dove si imparano i segni e i messaggi nascosti nei rumori delle tapparelle e delle serrande dei negozi.Esperienze e scoperte dell’infanzia
Il Kaiserpanorama permette di viaggiare in paesi lontani attraverso immagini vecchie, accompagnate da un campanello che ricorda l’addio. La Colonna della Vittoria è come una lapide di una storia mondiale sepolta, mentre il telefono, all’inizio strano e incomprensibile, diventa una consolazione quando si è soli, testimoniando un periodo che cambia. La caccia alle farfalle nei giardini d’estate rappresenta la voglia di qualcosa e la fiducia, un modo per imparare le regole segrete tra chi caccia e chi è cacciato.Il Tiergarten è come un labirinto pieno di scoperte per i bambini, un posto misterioso dove l’amore nasce tra difficoltà e problemi. La scuola, con i suoi libri vecchi e le lezioni difficili da capire, è diversa dalla magia dei libri di avventura, che aprono le porte verso mondi lontani e dentro di noi. Le mattine d’inverno, illuminate dalla stufa e profumate di mela cotta, rappresentano i desideri dei bambini che si avverano in modo inaspettato nella vita.Le zie, sempre uguali nelle finestre sporgenti, controllano intere strade con la loro presenza silenziosa, custodi dei ricordi di famiglia e di un tempo borghese che sembra non finire mai. La malattia trasforma il letto in un luogo pubblico, dove si pensa e la mamma racconta storie, e il corpo con la febbre vuole sentire storie e ricordi antichi.La lontra, un animale che vive in acqua nel giardino zoologico, rappresenta il legame segreto con la pioggia, simbolo di sicurezza e segno di quello che accadrà. L’estate porta ai giardini delle famiglie nobili, luoghi dove i bambini giocano e subiscono sconfitte inaspettate, come quando non si riesce a conquistare l’Isola dei Pavoni. La notizia della morte di un cugino fa capire ai bambini che la vita è breve e misteriosa.La casa della nonna, chiamata Blumeshof, è un posto sicuro, un piccolo mondo borghese aperto al mondo, dove il tempo sembra fermarsi e la morte non esiste. La Krumme Straße, con la piscina, il monte dei pegni e il negozio di penne, diventa un percorso di crescita tra cose belle e pericoli della città. Il gioco dei bambini con un calzino mostra che c’è un legame profondo tra l’aspetto e il contenuto, tra quello che contiene e quello che è contenuto.La figura spaventosa della Comarehlen rappresenta le paure dei bambini e presenze misteriose, mentre i nascondigli in casa diventano rifugi magici, luoghi di cambiamenti e lotte contro le paure interiori. Il ricordo di un fantasma di notte precede un furto vero, mescolando sogno e realtà in una paura infantile unica. L’angelo di Natale, una presenza leggera nella stanza buia, annuncia la gioia della festa che sta arrivando, ma anche la solitudine e l’ombra nascoste dietro le luci di Natale.La città e le sue promesse
La città promette cose brutte e crimini, ma non si fa vedere quando dovrebbero succedere, lasciando solo tracce veloci e misteriose. I colori, le vetrate colorate, le bolle di sapone, catturano lo sguardo dei bambini in un gioco di cambiamenti e sensazioni forti. Il cesto da lavoro della mamma, con i suoi strumenti e segreti, diventa simbolo di un potere gentile e capace, fonte di attesa e impazienza per i bambini. La luce della luna trasforma la camera in un posto strano, pieno di paure notturne e domande sulla vita.Le musiche militari e quelle allegre sul lago ghiacciato creano atmosfere diverse, dalla bellezza della città alla purezza limpida dell’inverno dei bambini. L’omino con la gobba, una figura che scappa e fa dispetti, rappresenta la parte oscura e difficile da capire dell’infanzia, una presenza costante e nascosta che anticipa e ostacola il cammino dei bambini.Il romanzo di Anna Seghers e la realtà sociale
La storia dei disoccupati tedeschi, raccontata nel romanzo di Anna Seghers, mostra la crisi dei lavoratori e le difficoltà degli scrittori a raccontare la vita della gente comune. Il romanzo si allontana dalla fortuna individuale dei borghesi, per raccontare in modo più antico, come una cronaca, la sofferenza e la resistenza dei disoccupati. La figura di Bentsch, un minatore senza lavoro, rappresenta la solitudine e la dignità di chi è solo, lontano dalle idee politiche troppo semplici.Il romanzo racconta la vita di tutti i giorni dei disoccupati, prigionieri di abitudini inutili e di una povertà che rovina il corpo e l’anima. La cucina e la piazza diventano simboli di un posto dove non ci si può riparare, di una vita incerta e senza futuro. La narrazione si concentra sul racconto dei fatti, senza seguire il tempo e la storia del singolo, per testimoniare insieme la tragedia della società.Il salvataggio di sette minatori da una frana diventa un simbolo di aiuto reciproco messo alla prova dalla disoccupazione e dalla crisi economica. L’anniversario del salvataggio, un tempo giorno di speranza, si trasforma in simbolo di dimenticanza e sconfitta, invaso dalla paura nazista. La speranza per il futuro sta nei bambini, testimoni silenziosi della sofferenza dei lavoratori, nei loro occhi si vede il desiderio di una vita dignitosa e felice, rappresentata dai vetri puliti sognati da Katharina.Ma in che modo, precisamente, i ricordi d’infanzia berlinese si trasformano in una critica sociale della disoccupazione nella Germania di Weimar?
Il capitolo sembra suggerire un legame tra le esperienze infantili e la coscienza sociale, ma la connessione tra la descrizione nostalgica dei ricordi e l’analisi della crisi economica rimane poco chiara. Per rendere più robusta l’argomentazione, sarebbe utile esplorare in modo più esplicito come le esperienze urbane dell’infanzia possano plasmare una sensibilità critica verso le ingiustizie sociali. Approfondimenti sulla psicologia sociale e sulla sociologia dell’infanzia, con autori come Walter Benjamin o Erving Goffman, potrebbero fornire un quadro teorico più solido per collegare la dimensione individuale dei ricordi con la realtà collettiva della crisi sociale.3. Romanticismo tra Crisi e Misticismo
Lettere e la fine del primo romanticismo tedesco
La fine del primo romanticismo tedesco viene raccontata attraverso una vasta raccolta di lettere. Queste lettere descrivono gli ultimi anni di vita dei protagonisti di questo periodo. Scritte tra il 1804 e il 1812 e indirizzate soprattutto a A. W. Schlegel, queste lettere offrono una visione dettagliata e complessa delle loro vite private e delle loro idee. Queste lettere mostrano un periodo di difficoltà, caratterizzato da separazioni personali, come quella di Sophie Bernardi, e da discussioni filosofiche, come la difesa di A. W. Schlegel dalle critiche di Fichte.Isolamento e difficoltà del circolo romantico
Le lettere mostrano un senso di isolamento del gruppo romantico. Questo isolamento era reso più forte dalla situazione storica, segnata dal dominio di Napoleone. Le difficoltà nel comunicare e le reazioni contro il potere di Napoleone si vedono chiaramente, specialmente negli scritti di Friedrich Schlegel. La divisione del gruppo romantico, con persone come Friedrich Tieck e Friedrich Schlegel costrette all’esilio o a lottare per vivere, è molto diversa dal periodo di grande energia di Jena.La critica di Hülsen e le tensioni interne al Romanticismo
Tra le lettere, una di August Ludwig Hülsen è particolarmente importante. In questa lettera, Hülsen critica il cambiamento reazionario dei fratelli Schlegel. Hülsen denuncia l’immaturità della borghesia tedesca e il pericolo di un ritorno a ideali cavallereschi che non sono più adatti ai tempi. Questa lettera mette in luce la tensione tra illuminismo e romanticismo e mostra le contraddizioni che esistevano all’interno del movimento romantico stesso.Romanticismo, mistica e secolarizzazione
Il romanticismo viene interpretato come il punto più alto di un processo di allontanamento dalla tradizione mistica, iniziato nel Settecento. L’esoterismo romantico appare quindi come un tentativo di riportare in auge il passato, che in modo strano anticipa un ritorno della scienza occulta all’interno della Chiesa. La crisi del romanticismo si manifesta anche con la conversione di figure importanti e con la fuga di altri verso l’irrazionale e l’inconscio. Questi sono segni di un percorso mistico ormai in crisi.La critica all’interpretazione di Béguin e la necessità di una prospettiva storica
Un libro di Albert Béguin sul romanticismo tedesco considera questo movimento come l’esempio principale di romanticismo, un modo per iniziare a capire un linguaggio fatto di simboli e sogni. Però, viene criticato il modo in cui Béguin affronta l’argomento, perché troppo soggettivo e senza una visione storica adeguata. Si sostiene che l’interesse per il romanticismo non dovrebbe limitarsi a cercare conferme delle idee romantiche sul sogno. Invece, è necessario studiare il contesto storico da cui queste idee sono nate. Per capire veramente il romanticismo, quindi, serve una conoscenza storica che vada oltre le interpretazioni personali e che comprenda la sua eredità complessa.Ma come si concilia la sua precoce passione per la letteratura tedesca con il suo successivo interesse per Proust e l’arte moderna? Non rischia questa apparente ecletticità di disperdere il valore del suo pensiero?
Il capitolo descrive il percorso intellettuale di Benjamin come una successione di interessi diversi, dalla letteratura tedesca a Proust, fino alla riflessione sull’arte moderna. Tuttavia, non chiarisce pienamente come questi interessi si integrino in una visione filosofica coerente. Per comprendere meglio l’unità del pensiero di Benjamin, sarebbe utile approfondire concetti chiave come l’allegoria, il “Trauerspiel”, e l’aura, studiando autori come Adorno e Scholem, che hanno interpretato e sviluppato le sue idee.16. Riflessioni Filosofiche in Tempo di Guerra
L’analisi di Baudelaire al centro del pensiero di Benjamin
Nel periodo finale della sua attività, Baudelaire diventa centrale per Benjamin. La rielaborazione del saggio sul poeta francese rappresenta un cambiamento importante nel suo modo di lavorare. Benjamin smette di usare paragoni metaforici tra la società e la cultura, e preferisce concentrarsi sugli aspetti materiali presenti nella creazione artistica. In questo modo, la storia dell’arte diventa una sorta di registrazione nascosta della società, e l’importanza sociale dell’arte si rivela proprio quando l’arte si allontana dagli eventi storici concreti.L’esperienza come elemento chiave
L’esperienza che Benjamin ha accumulato nel tempo diventa fondamentale per capire il legame tra l’economia e la poesia di Baudelaire. L’esperienza permette di andare oltre a semplici deduzioni immediate e di riconoscere che la cultura ha una sua autonomia. Questo nuovo modo di vedere le cose segna un passo importante verso la filosofia della storia, apprezzato anche dai suoi colleghi. Anche se il progetto di un libro su Baudelaire non sarà mai completato a causa della guerra e della stesura delle Tesi Sul concetto di storia, il saggio Su alcuni motivi in Baudelaire viene pubblicato e riconosciuto come un testo essenziale.L’interesse per Carl Gustav Jochmann
Nello stesso periodo, Benjamin si interessa a Carl Gustav Jochmann, una figura riscoperta dallo stesso Benjamin e considerata un anticipatore del pensiero moderno. In particolare, Benjamin apprezza il saggio di Jochmann intitolato “I regressi della poesia”. In questo saggio, Jochmann sostiene in modo provocatorio che i momenti di declino della poesia corrispondono a momenti di progresso nella cultura. Benjamin decide di pubblicare questo testo, scrivendone anche l’introduzione e partecipando a un dibattito sulla scoperta di Jochmann.Le Tesi Sul concetto di storia come opera conclusiva
Le Tesi Sul concetto di storia rappresentano l’ultimo lavoro completo di Benjamin. Queste tesi nascono da riflessioni che Benjamin ha sviluppato nel tempo, soprattutto a causa della guerra e delle esperienze della sua generazione. Nelle Tesi, Benjamin critica l’idea comune di progresso storico inteso in modo positivo. Al contrario, propone una visione diversa della storia che avrà una grande influenza sul pensiero degli anni successivi. La pubblicazione di questi scritti dopo la morte di Benjamin rivela l’importanza del suo contributo filosofico, interrotto tragicamente ma destinato a lasciare un segno duraturo.Se l’importanza sociale dell’arte emerge quando si allontana dagli eventi storici concreti, non si rischia di confinare l’arte in una torre d’avorio, lontana dalle reali problematiche sociali che dovrebbe invece illuminare?
Il capitolo afferma che l’importanza sociale dell’arte si rivela quando si allontana dagli eventi storici concreti. Questa affermazione appare controintuitiva e necessita di maggiore chiarezza. Per comprendere meglio questa prospettiva, sarebbe utile approfondire il pensiero di autori come Adorno, che ha ampiamente discusso il rapporto tra autonomia dell’arte e impegno sociale, o considerare le teorie sulla funzione critica dell’arte elaborate dalla Scuola di Francoforte.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]