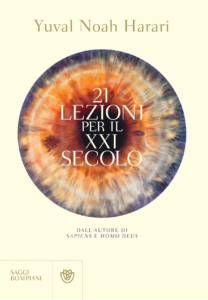Introduzione
In un contesto saturo di informazioni irrilevanti, la chiarezza è fondamentale. Sebbene tutti possano partecipare al dibattito sul futuro dell’umanità, mantenere una visione chiara è complesso. Molti sono troppo impegnati con le esigenze quotidiane per approfondire questioni cruciali. Se il futuro viene deciso senza il loro contributo, ne subiranno comunque le conseguenze. La storia non è giusta, e chi si occupa di storia può solo cercare di portare chiarezza.Il primo libro, “Sapiens. Da animali a dèi”, analizza il passato dell’umanità, mentre il secondo, “Homo Deus”, esplora le potenzialità future degli esseri umani. Questo libro si concentra sul presente e sulle sfide attuali delle società umane, ponendo domande su cosa stia accadendo, quali siano le sfide più grandi e quali opzioni siano disponibili. Le esperienze quotidiane delle persone, come una madre single a Mumbai o un rifugiato nel Mediterraneo, evidenziano che le questioni globali possono sembrare lontane rispetto ai problemi immediati.Il programma di questo libro è globale e analizza le forze che plasmano le società nel mondo. Il cambiamento climatico, ad esempio, può sembrare una preoccupazione remota per chi affronta emergenze quotidiane, ma ha il potenziale di influenzare profondamente le vite di molte persone. Il libro esamina vari aspetti della situazione globale, senza pretendere di essere esaustivo, e mira a stimolare riflessioni.I capitoli affrontano temi come tecnologia, politica, religione e arte, e cercano di rispondere a domande cruciali, come l’ascesa di figure politiche, la diffusione di notizie false e la crisi della democrazia liberale. Si sottolinea l’importanza di considerare le connessioni tra le grandi rivoluzioni e le esperienze individuali. Problemi come il terrorismo e la crisi democratica non riguardano solo le istituzioni, ma anche le esperienze personali.L’interconnessione globale influisce sui comportamenti e sull’etica individuale. Ogni azione quotidiana ha ripercussioni su scala globale. La dimensione globale delle vite personali richiede di affrontare pregiudizi e complicità nell’oppressione. Tuttavia, si pone la questione di come trovare un solido riferimento etico in un mondo complesso e in continua evoluzione.Il libro inizia analizzando la situazione politica e tecnologica attuale. Alla fine del XX secolo, il liberalismo sembrava aver prevalso, ma ora sta affrontando sfide significative. La convergenza delle tecnologie informatiche e biologiche presenta rischi per la libertà e l’uguaglianza, con il potenziale di creare una società dominata da una ristretta élite.Il libro non intende esplorare ogni aspetto delle nuove tecnologie, ma piuttosto mettere in evidenza le minacce e i rischi associati. Nella seconda parte, si analizzeranno possibili soluzioni alle sfide attuali. Si discuterà se l’intelligenza artificiale possa contribuire a una comunità globale che salvaguardi i diritti umani o se sia necessario un ritorno al potere degli stati-nazione.La terza parte esplorerà come l’umanità possa affrontare le sfide, mantenendo il controllo sulle proprie paure e coltivando visioni più umili. Si affronteranno temi come il terrorismo e il rischio di conflitti globali. La quarta parte si concentrerà sulla nozione di post-verità e sulla capacità di distinguere tra realtà e finzione.Infine, la quinta parte sintetizzerà le minacce e rifletterà sulla vita in un’epoca di disorientamento. Si porrà la questione del senso della vita in un contesto in cui le vecchie narrazioni sono in crisi. La filosofia, la religione e la scienza devono affrontare una crescente urgenza nel dibattito sul senso della vita, specialmente in un’epoca di crisi ecologica e tecnologica.Il libro si propone di affrontare le sfide del liberalismo e della democrazia, riconoscendo che queste sono le forme politiche più efficaci per affrontare le sfide moderne. Tuttavia, è necessario esplorare i limiti di questo modello e come adattarlo alle nuove realtà. La libertà di espressione è fondamentale per il progresso del pensiero critico, e il libro è scritto in un contesto in cui tale libertà è ancora presente.Capitolo 1: DISILLUSIONE
Gli esseri umani tendono a pensare in termini di storie piuttosto che di fatti. Durante il XX secolo, le élite globali hanno sviluppato tre narrazioni principali: fascista, comunista e liberale. La seconda guerra mondiale ha portato alla sconfitta del fascismo, lasciando il mondo in una lotta tra comunismo e liberalismo. Con la caduta del comunismo, il liberalismo è diventato il principale riferimento per comprendere il passato e il futuro.La narrazione liberale enfatizza il valore della libertà, sostenendo che l’umanità ha vissuto a lungo sotto regimi oppressivi. I regimi democratici hanno sostituito le dittature, e le libere imprese hanno superato le restrizioni economiche. Tuttavia, la narrazione riconosce anche che molti problemi persistono, come la povertà e l’oppressione. La soluzione proposta è aumentare la libertà, proteggere i diritti umani e garantire la circolazione di idee e merci.Negli anni ’90 e 2000, questa narrazione ha dominato a livello globale, ma dopo la crisi finanziaria del 2008, è emersa una crescente disillusione. Muri e firewall sono tornati in voga, e i governi democratici hanno iniziato a limitare diritti e libertà. Eventi come la Brexit e l’elezione di Trump nel 2016 hanno segnato un cambiamento significativo, con molte persone che hanno iniziato a vedere la visione liberale come indesiderabile.Nel corso del tempo, le narrazioni globali sono diminuite. Nel 1938 c’erano tre narrazioni, nel 1968 due, e nel 2018 nessuna. Le élite liberali si trovano ora disorientate e incapaci di interpretare la realtà. La mancanza di una narrazione chiara porta a pensieri apocalittici e a una percezione di crisi imminente.La rapida evoluzione tecnologica amplifica questo senso di disorientamento. Le tecnologie informatiche e biologiche stanno cambiando il mondo, e il sistema politico liberale fatica a rispondere. La complessità del sistema finanziario e l’emergere dell’intelligenza artificiale pongono interrogativi sul futuro della governance. La possibilità di un governo che dipenda da algoritmi per prendere decisioni è inquietante.Le tecnologie informatiche e biologiche offrono il potere di controllare il mondo interiore umano, ma le conseguenze di tali cambiamenti sono imprevedibili. La storia mostra che l’umanità è brava a inventare strumenti, ma meno a usarli saggiamente. Le rivoluzioni tecnologiche potrebbero portare a un collasso ecologico e a una crisi della realtà psichica.Attualmente, il liberalismo affronta una crisi di fiducia, ma non ha un avversario ideologico coerente. La narrazione liberale ha dimostrato capacità di adattamento, ma ora deve affrontare la sfida di una società che si sente sempre più irrilevante. Le masse, che un tempo si ribellavano contro lo sfruttamento, ora temono l’irrilevanza.Il liberalismo ha storicamente superato crisi precedenti, ma oggi non si confronta con ideologie forti. La crescente superpotenza cinese e la Russia, con il loro approccio pragmatico e autoritario, offrono modelli alternativi, ma non ideologici. Le élite liberali temono il ritorno di fantasie nostalgiche e nazionaliste che minacciano i principi liberali.La crisi del liberalismo potrebbe non essere così grave come in passato, poiché l’umanità non ha alternative praticabili. Tuttavia, il vuoto lasciato dal liberalismo è riempito da nostalgie locali. La gente cerca di tornare a un passato glorioso, come dimostrano le promesse di Trump e i sostenitori della Brexit.Le élite liberali sperano in un ritorno alla narrazione liberale, ma devono affrontare problemi globali come il collasso ecologico e le sfide tecnologiche. La crescita economica non risolverà i conflitti e non salverà l’ecosistema. La narrazione liberale deve evolversi per affrontare queste sfide e trovare un nuovo consenso.Il futuro richiede una narrazione aggiornata che integri le rivoluzioni tecnologiche e biotecnologiche. La capacità di affrontare la crisi del liberalismo dipenderà dalla creazione di una nuova visione che risponda alle esigenze del XXI secolo. La sfida principale sarà comprendere e gestire le implicazioni delle tecnologie emergenti, in particolare nel mercato del lavoro, dove l’automazione potrebbe escludere milioni di persone.Capitolo 2: Lavoro
Il futuro del mercato del lavoro nel 2050 è incerto. Si prevede che l’apprendimento automatico e la robotica influenzeranno profondamente quasi ogni professione. Esistono opinioni contrastanti riguardo alla portata e alla velocità di questi cambiamenti. Alcuni esperti sostengono che miliardi di persone diventeranno superflue, mentre altri ritengono che l’automazione creerà nuovi posti di lavoro e prosperità.Le preoccupazioni per la disoccupazione di massa a causa dell’automazione richiamano eventi storici, ma la storia ha dimostrato che per ogni lavoro perso ne è emerso almeno uno nuovo. Tuttavia, l’attuale contesto tecnologico potrebbe differire dai precedenti. Le macchine competono ora anche nelle abilità cognitive, superando gli esseri umani in compiti che richiedono comprensione emotiva e decisionale.L’intelligenza artificiale (IA) sta iniziando a eguagliare e superare le capacità umane in vari ambiti, inclusa la comprensione delle emozioni. Le neuroscienze e l’economia comportamentale hanno rivelato che le decisioni umane sono influenzate da processi biochimici, il che implica che l’IA potrebbe apprendere a riconoscere e prevedere il comportamento umano. Ciò suggerisce che l’IA potrebbe sostituire professioni tradizionali come autisti, banchieri e avvocati.La rivoluzione dell’IA non riguarda solo l’aumento dell’intelligenza dei computer, ma anche le scoperte nelle scienze biologiche e sociali. I computer, dotati di sensori adeguati, potrebbero analizzare le dinamiche emotive e i desideri umani in modo più efficace degli esseri umani stessi. La minaccia alla forza lavoro non deriva solo dall’IA, ma dalla combinazione di tecnologie informatiche e biologiche.L’IA ha capacità di connettività e aggiornamento che superano quelle umane. Gli esseri umani, essendo individui, sono difficili da connettere e aggiornare simultaneamente. Al contrario, i computer possono essere integrati in reti flessibili, riducendo il rischio di errori e aumentando l’efficienza. Questo porta a considerare che i lavoratori umani potrebbero essere sostituiti da sistemi integrati di IA.Nonostante l’automazione, è improbabile che l’IA elimini completamente interi settori. I lavori che richiedono una combinazione di abilità fisiche e cognitive, come l’assistenza sanitaria, potrebbero rimanere umani per un lungo periodo. Tuttavia, l’industria della cura alla persona potrebbe crescere, mentre la creatività potrebbe affrontare sfide significative dall’automazione.Sebbene alcuni lavori scompariranno, potrebbero emergere nuove professioni. Gli esseri umani potrebbero collaborare con l’IA, creando opportunità in settori come la sicurezza e la banca. Tuttavia, queste nuove posizioni richiederanno competenze elevate, il che potrebbe lasciare indietro i lavoratori meno qualificati. Ciò potrebbe portare alla nascita di una nuova classe di individui “inutili”, con disoccupazione e mancanza di competenze.La continua automazione potrebbe rendere difficile organizzare i diritti dei lavoratori, poiché molte professioni diventeranno temporanee o freelance. Le squadre composte da umani e IA potrebbero affrontare sfide di collaborazione e gerarchia. L’esempio degli scacchi mostra come l’IA possa superare le prestazioni umane, suggerendo che anche in altri settori le squadre umani-IA potrebbero diventare obsolete.La rivoluzione dell’IA non sarà un evento isolato, ma una serie di cambiamenti continui. La resistenza emotiva degli individui ai cambiamenti sarà cruciale. La crescente volatilità del mercato del lavoro potrebbe richiedere nuove tecniche per gestire lo stress e la salute mentale.Le soluzioni per affrontare la perdita di posti di lavoro possono includere il rallentamento dell’automazione, la creazione di nuovi posti e la progettazione di modelli sociali post-lavoro. Il reddito minimo universale è una proposta per garantire un sostegno economico a tutti, mentre l’idea di riconoscere attività non retribuite come lavoro potrebbe ampliare le opportunità occupazionali.Tuttavia, la definizione di “essenziale” e “minimo” rimane complessa. Le disuguaglianze globali potrebbero aumentare, e le aspettative personali influenzeranno la soddisfazione. L’esperienza degli ebrei ultraortodossi in Israele mostra che legami comunitari e significato possono compensare la mancanza di lavoro.Infine, la sfida principale sarà trovare un equilibrio tra il progresso tecnologico e il benessere umano, evitando il trasferimento di autorità dagli individui agli algoritmi, che potrebbe minacciare la libertà e la democrazia.Capitolo 20: Senso
La vita non è una narrazione. Gli esseri umani si pongono domande sul senso della vita da sempre, e ogni generazione cerca nuove risposte. La ricerca di significato spesso si traduce in narrazioni, poiché l’Homo sapiens è un animale narratore che comprende la realtà attraverso storie. Queste storie offrono un ruolo all’individuo nel dramma cosmico, conferendo significato alle esperienze e alle scelte.Una narrazione antica, presente nel poema indù Bhagavadgītā, racconta del principe Arjuna, che, in guerra, esita a combattere contro amici e parenti. Il dio Krishna gli spiega che ogni essere ha un “dharma”, un dovere specifico. Seguire il proprio dharma porta pace e liberazione dai dubbi; ignorarlo disturba l’equilibrio cosmico. Arjuna accetta il suo ruolo di guerriero e, nonostante le difficoltà, diventa un eroe.Il film “Il re leone” rielabora questa storia, con Simba che cerca il suo posto nel Cerchio della Vita. Mufasa, suo padre, spiega che ogni creatura ha un ruolo nel ciclo della vita. Dopo la morte di Mufasa, Simba fugge dal suo destino, ma alla fine comprende il suo dovere e ripristina l’armonia nel regno. Questa narrazione circolare suggerisce che il ciclo della vita è eterno e che ogni individuo deve seguire il proprio ruolo.Altre religioni e ideologie presentano narrazioni lineari. Nel contesto musulmano, Allah crea l’universo e stabilisce leggi, rivelate nel Corano. La vita ha senso seguendo questi dettami, e il Giorno del Giudizio determina il destino di ciascuno. Analogamente, il nazionalismo e il comunismo offrono storie che definiscono l’identità e il ruolo degli individui nella società.Tuttavia, molte narrazioni sono limitate e non considerano l’intero universo. La miopia di queste storie può portare a conflitti, come nel caso della città di Gerusalemme, considerata eterna da alcuni nazionalisti. La narrazione sionista, ad esempio, ignora la vastità della storia umana e dell’universo.La ricerca di significato può anche manifestarsi nel desiderio di lasciare un’eredità, sia culturale che biologica. Tuttavia, la maggior parte degli organismi non lascia tracce durature. Anche il tentativo di migliorare il mondo può risultare insoddisfacente, poiché non si comprende il senso di questa catena di gentilezza.L’amore rappresenta un’altra via per dare significato alla vita, concentrandosi sul momento presente. Tuttavia, la ricerca dell’amore può diventare un obiettivo in sé, distogliendo l’attenzione dalla realtà.Le narrazioni, pur essendo frutto della fantasia, forniscono identità e senso. Tuttavia, nessuna storia è completamente vera, poiché l’universo non funziona come una narrazione. La fede nelle storie è radicata nell’educazione e nelle istituzioni sociali, rendendo difficile mettere in discussione le proprie credenze.I riti e i rituali rendono le narrazioni più concrete, conferendo loro un senso di realtà. Il sacrificio, in particolare, rafforza la fede in una storia, spingendo le persone a credere in essa, anche quando le prove sono fragili. La storia del buddismo, ad esempio, mostra come la fede possa essere distorta per giustificare azioni violente.In questo contesto, è importante riconoscere che le identità sono complesse e che le persone spesso gestiscono più narrazioni contemporaneamente. Il fascismo, al contrario, richiede una fede assoluta in un’unica narrazione, negando altre identità.La modernità ha aperto un “supermercato” di idee, dove le persone possono scegliere le storie in cui credere. Tuttavia, questa libertà può portare a confusione e incertezza. La narrazione liberale sostiene che il significato della vita si crea attraverso le proprie scelte, ma le scelte stesse sono influenzate da fattori biologici e culturali.Infine, il buddismo propone che la vita non ha senso e che la sofferenza deriva dall’attaccamento a idee e identità. La verità risiede nell’accettazione dell’impermanenza e nella liberazione dai legami. La sofferenza è l’unica realtà concreta, e la ricerca di significato dovrebbe concentrarsi su di essa, piuttosto che su storie fittizie.Capitolo 21: MEDITAZIONE
L’autore espone la propria esperienza personale con la meditazione, sottolineando come, nonostante il suo scetticismo, riesca a svegliarsi ogni giorno con una disposizione positiva verso il mondo. Riconosce che la sua prospettiva è influenzata dalla sua storia personale e dal suo dharma, e non necessariamente applicabile a tutti. Da adolescente, si sentiva tormentato e confuso, incapace di trovare risposte alle sue domande esistenziali, in particolare riguardo alla sofferenza. Le spiegazioni che riceveva, sia da persone che da libri, apparivano come miti privi di sostanza.Durante gli studi universitari, l’autore sperava di trovare risposte, ma si sentì deluso. Sebbene il mondo accademico offrisse strumenti per decostruire miti, non forniva risposte ai grandi interrogativi della vita. La svolta avvenne quando un amico lo incoraggiò a partecipare a un ritiro di meditazione Vipassana. Inizialmente scettico, alla fine si iscrisse a un ritiro di dieci giorni.Il corso di meditazione si rivelò pragmatico e non mistico. L’insegnante, S.N. Goenka, insegnò a concentrarsi sul respiro, osservando semplicemente il flusso dell’aria senza tentare di controllarlo. Questo approccio portò l’autore a comprendere che la vera comprensione della vita deve precedere la comprensione della morte. Le domande sulla morte presuppongono l’esistenza di un “io” immutabile, ma l’autore sottolinea che nulla rimane costante nel tempo.L’osservazione del respiro rivelò all’autore la sua mancanza di controllo sulla mente. Scoprì che, nonostante i suoi sforzi, non riusciva a mantenere la concentrazione sul respiro per più di pochi secondi. Questo lo portò a rendersi conto di non essere il padrone della propria vita, ma piuttosto un semplice osservatore. Durante il ritiro, imparò a osservare anche le sensazioni corporee, comprendendo che le reazioni mentali sono collegate a queste sensazioni. La sofferenza, quindi, non è una condizione oggettiva, ma una reazione mentale.Dopo il ritiro, l’autore iniziò a meditare regolarmente, dedicando due ore al giorno alla pratica. La meditazione divenne uno strumento per osservare la realtà e contribuì alla sua scrittura. Non entrò in conflitto con la ricerca scientifica, ma la integrò, specialmente nella comprensione della mente umana.L’autore discute le difficoltà della scienza nel comprendere la mente, spesso confusa con il cervello. Il cervello è una rete materiale, mentre la mente è un flusso di esperienze soggettive. Nonostante i progressi nella ricerca cerebrale, non è possibile osservare la mente direttamente. La meditazione offre un metodo per l’osservazione diretta della mente, nonostante sia spesso associata a pratiche religiose.Esistono molte tecniche di meditazione, ma l’autore si concentra sulla Vipassana, che si basa sull’osservazione delle sensazioni corporee e delle reazioni mentali. La meditazione non deve essere confusa con la ricerca di esperienze speciali; è un metodo per comprendere la realtà della mente. La scienza ha iniziato a interessarsi alla meditazione, ma spesso in modo indiretto, perdendo così intuizioni importanti.L’autore sottolinea l’importanza di osservare la propria mente in modo diretto, piuttosto che limitarsi a studiare le attività cerebrali di altri. La meditazione non sostituisce gli strumenti scientifici, ma li integra. È necessario un impegno serio per comprendere la mente, simile agli sforzi richiesti da antropologi e astronauti.Infine, l’autore avverte che l’osservazione di se stessi diventa sempre più difficile a causa delle narrazioni elaborate che gli esseri umani creano su se stessi. Queste storie, pur essendo utili per mantenere l’armonia sociale, complicano la comprensione della propria identità. Con l’avanzamento della tecnologia, la possibilità di osservare la realtà potrebbe diminuire, rendendo essenziale l’impegno immediato per comprendere chi siamo davvero.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]