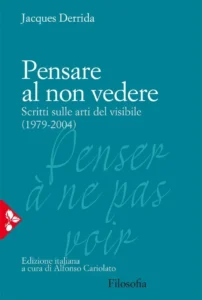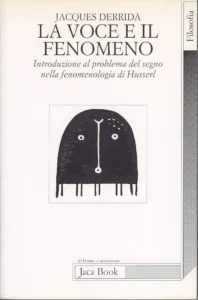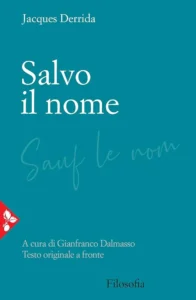“Il Nome e l’Innominabile” invita a un’indagine profonda sulla natura del nome e sull’atto stesso di nominare. Attraverso una serie di saggi interconnessi, il libro esplora come il linguaggio si confronta con l’ineffabile, con ciò che sfugge alla definizione. Il lettore è guidato in un percorso che parte dall’analisi del concetto platonico di *Khôra*, uno spazio che resiste alle opposizioni binarie, per poi addentrarsi nei paradossi del dovere e del debito, e culminare nell’esplorazione del “SurNom” all’interno della teologia negativa. Si interroga il desiderio di Dio, l’esperienza del deserto del linguaggio e il significato del “lasciare essere”, aprendo prospettive inedite sul pensiero politico futuro e sulla possibilità di una comunità universale.
1. L’Enigma del Nome
Il significato del nome
Dare un nome a qualcosa non è solo assegnargli una parola per identificarlo. Dare un nome è un atto più profondo, quasi come donare qualcosa che non si possiede veramente. Questo modo di intendere il nome è analizzato attraverso tre studi diversi, ma collegati tra loro.Il concetto di Khôra
Il primo studio si concentra sull’idea platonica di Khôra. Khôra è un concetto difficile da definire con le normali categorie di pensiero. Non è qualcosa di puramente materiale, percepibile con i sensi, ma non è nemmeno qualcosa di puramente intellettuale. Partecipa sia al mondo sensibile che a quello intelligibile, ma allo stesso tempo non appartiene completamente a nessuno dei due. Khôra rappresenta uno spazio che va oltre le semplici parole e i discorsi, e in questo modo rivela anche un aspetto politico, legato al modo in cui organizziamo e comprendiamo la realtà.Dovere, debito e SurNom
Il secondo studio esamina i paradossi che nascono quando parliamo di dovere e di debito. Si mette in discussione cosa significhi veramente il ‘dovere’, analizzando le conseguenze che questo concetto ha sia dal punto di vista etico, cioè morale, sia dal punto di vista politico, cioè legato alla società. Infine, l’ultimo studio si concentra sul ‘SurNom’ all’interno della teologia negativa. Il ‘SurNom’ è qualcosa che nomina ciò che non può essere nominato direttamente. Va oltre i limiti del linguaggio e del nome stesso, aprendo riflessioni sulla salvezza e su come pensare la politica nel futuro.Conclusioni sul significato del nome
Questi studi mostrano quanto sia complesso dare un nome alle cose, specialmente quando ci troviamo di fronte a realtà che sfuggono alle parole e alla nostra capacità di definirle. Il capitolo esplora quindi le difficoltà e le sfide che incontriamo quando cerchiamo di nominare ciò che, per sua natura, è difficile da definire.Se il capitolo afferma che dare un nome è così complesso e legato alla politica attraverso concetti come Khôra e SurNom, non dovrebbe forse fornire esempi più concreti per ancorare queste idee astratte e dimostrarne la rilevanza nel mondo reale?
Il capitolo sembra mancare di esempi concreti che illustrino la complessità del ‘dare un nome’ e il suo legame con la politica. Per comprendere meglio queste connessioni, sarebbe utile approfondire la filosofia politica, la semiotica e magari esplorare le opere di autori come Platone per Khôra, Derrida per la decostruzione del linguaggio e teologi della teologia negativa per il concetto di SurNom.2. Sul Nome e Ciò Che lo Circonda
Riflessione sul nome
Il nome viene analizzato da diverse prospettive, per capire la sua natura e il suo ruolo. Ci si chiede cosa suscita un nome, come possiamo pensare al nome stesso di un nome, e cosa succede quando diamo un nome a qualcosa. Dare un nome non significa offrire un oggetto concreto, ma è un evento che ricorda l’idea platonica del Bene, cioè dare qualcosa che non si possiede.Soprannome, pseudonimo e criptonimo
Un punto importante è capire cosa vuol dire dare un soprannome o cambiare nome, soprattutto quando sembra che manchi un nome adatto. Si cerca di capire cosa trasforma un nome proprio in un soprannome, uno pseudonimo o un “criptonimo”, mettendo in evidenza quanto questi nomi siano unici e difficili da tradurre.Il concetto di chōra
Il concetto platonico di chōra è un esempio di problema testuale. La chōra, descritta nel Timeo come luogo o spazio, è qualcosa che genera ma non dà nulla di definito. Non offre modelli perfetti né copie, e non si lascia convincere o manipolare con la retorica. La chōra non rientra nelle categorie di ciò che si percepisce con i sensi e ciò che si comprende con la mente, di metafora e significato letterale, partecipando alle divisioni ma allo stesso tempo superandole. Anche se viene definita “matrice” o “nutrice”, la chōra è paragonata a un pre-nome particolare, materno e puro, che silenziosamente richiama il soprannome che le viene dato, restando distinta dalle figure materne, femminili o religiose. Il silenzio della chōra non è un tipo di parola, e non è legato alla teologia negativa o al pensiero del Bene o di Dio trascendente. Questa esperienza ha anche un significato politico, anticipando una riflessione sulla politica stessa. Socrate, nel suo discorso sulla politeia, è paragonato alla chōra perché riesce a dare forma a ciò che non si può afferrare, accogliendo tutto al di là dello scambio e del dono, come una Necessità senza obbligo.Il segreto assoluto
Il tema del segreto assoluto è affrontato con la frase “questo è il mio corpo”, analizzando le stranezze della cortesia e la sensazione di un debito impossibile da pagare. Ci si interroga sulla natura del dovere, suggerendo che potrebbe essere il non dover fare, il dovere senza obbligo, o il dovere di non agire per dovere. Vengono sollevate questioni di etica e politica sul significato di “dovere” e sulla responsabilità che comporta.Salvezza e SopraNome
Infine, la riflessione si concentra sulla salvezza e sul SopraNome, attraverso un dialogo immaginario che esplora il nome del nome e il nome di Dio nella teologia negativa. Il SopraNome indica ciò che non si può nominare, ciò che sfugge alle definizioni e alla conoscenza, sottraendosi all’esistenza. Questa teologia negativa sembra aprire nuove prospettive politiche, seguendo le orme di figure come Angelus Silesius. Il SopraNome si presenta come qualcosa di superiore al nome, che lo sostituisce, ma il suo ruolo di salvezza rimane incerto tra la salvezza del nome stesso e una salvezza più ampia, simile a un saluto o un addio.Ma in che modo questo continuo richiamo a concetti filosofici astratti come la chōra platonica e la teologia negativa ci aiuta a comprendere concretamente le dinamiche del “nome” e del “soprannome” nella vita reale, e soprattutto le loro implicazioni politiche ed etiche?
Il capitolo sembra indulgere in un linguaggio filosofico eccessivamente specialistico, rendendo difficile capire come le riflessioni sul “nome” e sul “soprannome”, attraverso il prisma concettuale della chōra e del “SopraNome”, si traducano in una comprensione più profonda delle questioni etiche e politiche sollevate. Per colmare questa lacuna, sarebbe utile confrontare queste riflessioni con autori che hanno affrontato temi simili con un approccio più pragmatico e orientato all’azione, come ad esempio Hannah Arendt, o esplorare discipline come la filosofia politica e l’etica applicata.3. L’Ombra del Nome
La teologia negativa
La teologia negativa usa il linguaggio per mettere in discussione i limiti del linguaggio stesso. Con l’apofasi, la teologia negativa dice e allo stesso tempo nega, arrivando vicino all’ateismo ma esprimendo un forte desiderio di Dio. Questo modo di parlare di teologia va oltre la ragione e la comunità, cercando ciò che sembra impossibile.Il desiderio di Dio
Il desiderio di Dio è molto importante nella teologia apofatica e si mostra nel continuo superamento di sé. È un movimento che va oltre il voler possedere o definire Dio. Il linguaggio apofatico è come una confessione e non vuole informare o insegnare in modo tradizionale. Il suo scopo è piuttosto testimoniare e far crescere l’amore tra le persone. In questo senso, la scrittura è come un “post-scriptum”, una traccia che viene dopo l’esperienza della conversione e si rivolge a un gruppo di lettori.La teologia negativa come disciplina
La teologia negativa è coltivata come studio e tradizione, ma si svuota di contenuti specifici, diventando formale e meccanica. Questo svuotamento la rende però universale e facile da tradurre, aprendola al dialogo tra culture e religioni diverse. La sua caratteristica principale è un movimento esagerato che va oltre l’essere e Dio stesso, portandosi “al di là di Dio”, in un deserto metaforico dove il linguaggio si confronta con i suoi limiti.Amicizia e traduzione
Questo andare “oltre” è legato all’idea di amicizia e traduzione. Suggerisce un’esperienza di linguaggio condiviso che supera le differenze culturali e religiose. La teologia negativa si interroga sul nome di Dio, riconoscendo che non è sufficiente e che bisogna andare oltre. Si muove verso un luogo impossibile e indescrivibile, dove si sente una parola che è anche il luogo stesso. Questo luogo, dentro e fuori di noi, crea uno spazio di gioco divino. In questo spazio, la creazione partecipa a un processo continuo di cambiamento e superamento, in un movimento che si realizza “senza” il nome, ma proprio attraverso il nome.Ma se la teologia negativa ci dice solo cosa Dio non è, cosa ci dice concretamente su Dio?
Il capitolo descrive efficacemente l’approccio apofatico, ma lascia in sospeso la questione della sua utilità pratica. Se il linguaggio è intrinsecamente limitato e può solo negare attributi divini, come possiamo realmente progredire nella comprensione del divino attraverso questa via? Per rispondere a questa domanda, potrebbe essere utile esplorare più a fondo le opere di autori come Pseudo-Dionigi l’Areopagita, figura chiave nello sviluppo della teologia apofatica, o approfondire studi sulla filosofia del linguaggio e sulla semiotica, per comprendere meglio i limiti e le potenzialità espressive del linguaggio umano quando applicato a concetti trascendenti.6. L’Abbandono e l’Ospitalità nel Deserto del Linguaggio
L’Europa e il suo Vicolo Cieco Logocentrico
L’Europa di oggi si richiama ai valori cristiani per trovare unità e giustificare le sue azioni internazionali. Nonostante questo, sembra trovarsi in una situazione difficile, come in un vicolo cieco, perché è troppo concentrata sulla logica e sulla ragione. Però, è proprio lavorando ai margini di questo modo di pensare tipicamente europeo che si può trovare una via d’uscita verso l’incontro con gli altri. Questo “lasciare” significa un abbandono totale, una sorta di rinuncia a ogni cosa per avvicinarsi a Dio, arrivando persino a lasciare andare l’idea stessa di Dio, mantenendo solo il suo nome in silenzio.Abbandono, Gioia e Ospitalità
Questo abbandono non vuol dire tristezza, anzi, apre la strada alla gioia, creando uno spazio per qualcosa di divino. Lasciare spazio agli altri significa essere ospitali, un’ospitalità che ha due aspetti: da un lato, il desiderio di costruire una lingua universale come la Torre di Babele; dall’altro, la necessità di distruggere Babele. Entrambi gli aspetti puntano a creare una comunità che comprenda tutti, ma si scontrano con qualcosa di difficile da gestire e controllare. Il desiderio di Dio si manifesta nel deserto, che è il luogo del desiderio stesso, dove si sente la voce misteriosa e indiretta della teologia negativa, che parla di Dio dicendo cosa non è.La Teologia Negativa e il Deserto Comune
Il tentativo di creare una lingua universale oscilla tra un linguaggio troppo formale e freddo e un insieme confuso di lingue impossibili da tradurre. La teologia negativa si colloca proprio in questo spazio intermedio. La storia di Babele, con la sua costruzione e distruzione, è ancora troppo piena di significati e interpretazioni. Il vero limite, quello che non si vede, si sposta dal progetto di Babele all’atto stesso di decostruirlo, ed è qui che si muovono la teologia negativa e le idee simili. La teologia negativa è come un passaggio attraverso un deserto comune a tutte le lingue, aprendo la strada a un diritto e a una pace universali, che vadano oltre l’idea europea di Stato. Non si può dire che la politica o il diritto nascano direttamente dalla teologia negativa, ma si afferma che senza questa possibilità offerta dalla teologia negativa, la politica, il diritto e la morale perderebbero il loro significato, diventando parole vuote e incerte.Il “Senza” e il “Non Senza”: L’Eredità Difficile
Le parole “senza” e “non senza” diventano concetti fondamentali, anche se difficili da capire fino in fondo. Silesius ci insegna che “nessuna morte è senza vita” e “nulla vive senza morire”, invitandoci a riflettere profondamente sull’eredità, intesa come il gesto di dare e ricevere un nome. L’eredità, come il concetto di “senza”, è qualcosa di complicato da pensare e da vivere pienamente. Questa difficoltà del “senza” si estende anche alla politica, alla morale e al diritto, che sono allo stesso tempo minacciati e resi possibili dalla teologia apofatica, cioè dalla teologia negativa. La democrazia che verrà, erede di una promessa, percorre strade difficili e piene di ostacoli, dove prendere decisioni sembra impossibile, e la responsabilità nasce proprio da questa impossibilità.Il Segreto della Gelassenheit
La teologia apofatica si muove in equilibrio tra il desiderio di essere capita da tutti e la necessità di proteggere un segreto per pochi. Questo segreto, come la democrazia, non può essere ereditato da chiunque. Il segreto più profondo è quello della Gelassenheit, un modo particolare di lasciare-l’altro-qui, di accogliere l’altro. Dare un nome non è solo offrire qualcosa, ma può anche diventare una catena che lega l’altro. Il dono del nome offre qualcosa che non si possiede, l’essenza immateriale del dono stesso. Angelus Silesius, pur non essendo l’unico esempio di teologia negativa, è una figura molto importante in questo campo. La teologia negativa, nella sua essenza, si presenta come un modo di esprimersi essenziale ed economico, una riserva di linguaggio fatta di poche parole, adatta al deserto e all’esilio, che mantiene vivo il desiderio, lasciando andare senza mai abbandonare del tutto.Ma in concreto, come si traduce l’abbandono del “vicolo cieco logocentrico” europeo in termini politici e sociali?
Il capitolo descrive in modo suggestivo la necessità di superare una certa rigidità logica europea, ma rimane ambiguo su come questo “abbandono” si possa tradurre in azioni concrete. Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile esplorare più a fondo la filosofia politica e la sociologia, per capire come i concetti astratti di “abbandono” e “ospitalità” possano essere applicati alla realtà delle istituzioni e delle politiche migratorie contemporanee. Approfondimenti sul pensiero di autori come Arendt o Lévinas potrebbero offrire spunti utili per concretizzare il discorso.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]