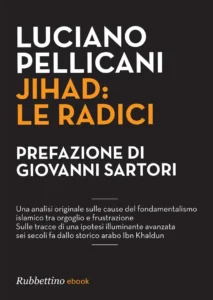1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Saggio sulla genesi del capitalismo. Alle origini della modernità” di Luciano Pellicani è un libro che ti prende subito, perché va dritto al punto su una domanda enorme: ma perché il capitalismo, questo sistema economico super dinamico basato sul mercato e sulla ricerca del profitto, è nato e si è sviluppato pienamente solo in Occidente? Pellicani non si accontenta delle solite risposte, tipo quelle di Marx sull’accumulazione originaria o di Weber sull’etica protestante, che analizza e critica a fondo, mostrando come il capitalismo e lo spirito acquisitivo esistessero già prima della Riforma e come il dispotismo statale in luoghi come la Cina o l’Impero Ottomano abbia soffocato ogni tentativo di sviluppo economico autonomo. Il vero segreto, secondo il libro, sta nella particolare storia politica dell’Europa, nel suo feudalesimo frammentato che ha permesso la nascita e l’autonomia delle città medievali, veri e propri motori del mercato e della società civile. È in queste città che si è creata la libertà necessaria per l’iniziativa economica, rompendo con le tradizioni e dando vita a quella modernità che oggi conosciamo, con tutte le sue luci e ombre, le sue contraddizioni tra libertà individuale e disordine sociale. Questo saggio ti fa capire quanto le origini della modernità siano legate a doppio filo con la politica e la nascita del mercato autoregolato.Riassunto Breve
Il capitalismo è un sistema economico unico basato su un mercato che si regola da solo, dove la ricerca di profitto è illimitata e tutto tende a diventare merce. Richiede imprenditori, capitale dinamico e lavoratori che vendono la loro forza-lavoro, creando una divisione sociale. La domanda centrale è perché questo sistema si è sviluppato pienamente solo in Occidente. Spiegazioni come quella di Marx, che lega la nascita del capitalismo allo sviluppo delle forze produttive e all’accumulazione originaria (separazione dei lavoratori dai mezzi di produzione, spesso con violenza di Stato), vengono criticate per incoerenza e perché la violenza non ha generato capitalismo altrove. Anche l’idea che il commercio a lunga distanza sia la causa principale non basta, perché il commercio esisteva in molte civiltà senza portare a una trasformazione capitalistica. La Riforma protestante, contrariamente ad alcune teorie, non favorisce lo spirito capitalistico; figure come Lutero e Calvino erano spesso ostili all’economia di mercato e cercavano di frenare l’individualismo acquisitivo. La fuga di mercanti e artigiani dai paesi cattolici repressivi verso aree protestanti più tolleranti contribuisce invece allo spostamento del centro economico. Nelle civiltà orientali, un forte dispotismo burocratico centralizzato, la “Megamacchina”, impedisce lo sviluppo del capitalismo controllando terra e iniziativa privata, soffocando le autonomie. In Europa occidentale, la caduta dell’Impero Romano porta a una frammentazione del potere nel feudalesimo, con un potere centrale debole e contropoteri come nobiltà e clero. Questa debolezza statale permette alle città medievali di emanciparsi, diventando centri autonomi di commercio e iniziativa economica. Le città, nate spesso da giuramenti (*conjuratio*) per difendere la libertà, creano un nuovo ordine giuridico basato sulla proprietà e la libertà contrattuale, fondamentale per l’emergere dell’*homo oeconomicus* e di strumenti finanziari avanzati. Il mercato introduce una logica di calcolo e razionalità che contrasta con la tradizione e l’etica religiosa, portando a una progressiva secolarizzazione. Con la formazione degli Stati nazionali, le città perdono autonomia politica, ma gli Stati che comprendono il valore della ricchezza economica per la potenza militare favoriscono il capitalismo, garantendo proprietà e libertà d’impresa. Il mercato diventa un agente di modernizzazione, rompendo l’isolamento delle società tradizionali e stimolando il pensiero critico. La modernizzazione non è solo industrializzazione, ma anche l’emergere di una società civile autonoma dallo Stato, che il mercato rende visibile e che diventa oggetto di studio per la sociologia. La Modernità, tuttavia, presenta contraddizioni: la secolarizzazione può minare i valori comuni, l’ineguaglianza genera frustrazione e la moltiplicazione dei gruppi di interesse rende difficile la gestione collettiva. Il futuro della Modernità e della libertà individuale dipende dal mantenimento di una società civile forte e di un’economia di mercato non soffocata dallo Stato.Riassunto Lungo
1. L’enigma dell’economia pura in Occidente
Questo sistema economico è unico perché si basa su un mercato che funziona da solo e che applica le regole dello scambio a ogni attività. È spinto da una ricerca continua di guadagno, il che lo rende sempre in movimento e in crescita. Funziona con lo scambio di beni e l’uso del denaro. I prezzi aiutano a fare calcoli precisi, e le aziende puntano a ottenere il massimo guadagno possibile. Gli elementi chiave sono chi avvia l’attività (l’imprenditore), i soldi e i beni usati per produrre (il capitale, visto come un processo che cambia), e le persone che lavorano e che vendono liberamente il loro tempo e le loro capacità. Questo porta a una separazione tra chi possiede i mezzi di produzione e chi no. Il capitale, attraverso il contratto di lavoro, ha potere sui lavoratori. Il capitalismo trasforma sempre più cose in merci, e tende a far diventare l’economia più importante di altri aspetti della vita sociale. Non è nato da un piano preciso, ma è cresciuto da solo partendo da situazioni che già esistevano.Perché Solo in Occidente?
Ci si chiede perché questo sistema si sia sviluppato completamente solo nei paesi occidentali. In altre civiltà, infatti, le attività economiche erano limitate da regole politiche, religiose o sociali molto forti. Karl Marx ha provato a rispondere a questa domanda con la sua teoria su come è nato il capitalismo. La sua idea si basa sullo sviluppo delle capacità produttive e su un processo che chiama ‘accumulazione originaria’. Le ‘forze produttive’ sono viste come qualcosa che si sviluppa da solo, ma questa è una premessa non dimostrata e la sua spiegazione sembra più una descrizione che una vera causa.Le Critiche alla Teoria di Marx
Per spiegare come sono nate le classi dei capitalisti e degli operai, Marx parla dell’accumulazione originaria. Questo processo richiede che i lavoratori siano separati dagli strumenti e dai terreni che servono per produrre. Però, Marx si accorge di un ‘circolo vizioso’: il capitalismo sembra aver bisogno proprio delle condizioni che dovrebbe creare. Per uscirne, dice che è intervenuta la violenza dello Stato, che ha avuto un ruolo decisivo. Questa spiegazione è stata criticata perché non è coerente: lo Stato, che non era ancora uno Stato dei capitalisti, diventa la causa del cambiamento economico. Inoltre, non è soddisfacente come spiegazione unica. La violenza e l’accumulo di ricchezze sono sempre esistiti in molte civiltà, ma non hanno portato al capitalismo. Anche le ‘enclosures’ in Inghilterra, cioè la recinzione delle terre comuni, sono considerate meno importanti di quanto pensasse Marx e non portarono a una concentrazione della terra in mano a pochi come si credeva. L’accumulazione originaria, vista solo come una semplice concentrazione di beni, non spiega perché la produzione è diventata molto più efficiente. Infine, lo sfruttamento delle colonie non è la causa principale del capitalismo, ma è più una conseguenza del fatto che l’Europa era già economicamente e tecnologicamente superiore. Quindi, la spiegazione basata solo su violenza e accumulo sembra incompleta.Altre Spiegazioni e la Sfida
Anche altri tentativi di spiegazione non risolvono del tutto il mistero. Alcuni, come Dobb, cercano le cause solo nei problemi interni del sistema feudale. Altri, come Sweezy, danno molta importanza al commercio. Il commercio su lunghe distanze esisteva anche in altre parti del mondo. La vera domanda è perché in Europa ha avuto la capacità unica di cambiare profondamente la società. La vera sfida rimane capire quali differenze uniche c’erano nella civiltà occidentale che hanno permesso all’economia di diventare autonoma e di svilupparsi seguendo le sue regole, portando a quella che è stata una rivoluzione capitalistica continua.Dopo aver criticato le spiegazioni esistenti, il capitolo non rischia di lasciare il lettore con un enigma ancora più fitto su quali siano queste “differenze uniche” occidentali?
Il capitolo, pur smontando con efficacia le debolezze delle teorie esistenti, in particolare quella di Marx, non offre una risposta concreta alla domanda fondamentale che pone: perché il capitalismo si è sviluppato pienamente solo in Occidente? La “sfida” finale rimane formulata in termini molto generali (“capire quali differenze uniche c’erano nella civiltà occidentale”). Non specificare o almeno accennare a quali potrebbero essere queste differenze concrete (istituzionali, culturali, legali, tecnologiche, ecc.) rende l’argomentazione incompleta e lascia il lettore con la sensazione che il mistero sia stato solo spostato, non risolto. Per iniziare a colmare questa lacuna, è utile esplorare discipline come la sociologia storica, la storia del diritto e la storia economica comparata. Autori come Max Weber, Karl Polanyi o Douglass North hanno affrontato questo tema da angolazioni diverse, cercando di identificare proprio quei fattori specifici che potrebbero aver favorito l’emergere di un’economia autonoma in Occidente.2. Le Radici Profane dello Spirito Capitalistico
Il passaggio dal vecchio sistema feudale al capitalismo ha portato un cambiamento fondamentale nel modo in cui le persone agiscono nell’economia. Si è passati da un approccio legato alla tradizione a uno più razionale, basato sul calcolo e su azioni economiche libere dai vecchi schemi. Non è la semplice voglia di guadagno a definire il capitalismo moderno, perché quella è sempre esistita. La domanda è: da dove nasce questo spirito nuovo?Le teorie di Sombart e Weber
Secondo Werner Sombart, l’origine di questo spirito capitalistico si trova in gruppi che vivevano ai margini della società, come ebrei ed eretici. Esclusi dalla vita pubblica tradizionale, furono spinti a cercare prestigio e riconoscimento attraverso l’economia. La loro condizione di “stranieri” li aiutò a rompere con le vecchie tradizioni e ad applicare un modo di pensare più razionale agli affari. Max Weber, invece, lega lo spirito capitalistico all’etica di alcune sette protestanti, in particolare il calvinismo. Sostiene che la Riforma religiosa ha trasformato la disciplina e la rinuncia tipiche dei monaci (ascesi monastica) in una disciplina vissuta nella vita di tutti i giorni (ascesi intramondana), promuovendo così una condotta di vita razionale e organizzata. La dottrina della predestinazione, l’idea che il destino di salvezza sia già deciso da Dio, avrebbe spinto i credenti a cercare segni della loro elezione divina nel successo nel lavoro e nell’accumulare ricchezza, vista come un favore divino. Questo avrebbe creato un modello ideale di imprenditore: razionale e disciplinato.Evidenze storiche e critiche
Tuttavia, un modo di pensare orientato al profitto e pratiche commerciali razionali esistevano già nel Basso Medioevo, secoli prima della Riforma Protestante. I mercanti italiani di città come Genova, Venezia e Firenze mostravano già una mentalità concentrata sul guadagno, sugli investimenti e su una gestione efficiente delle loro attività, spesso agendo in modo che non sempre era in linea con le idee religiose del tempo. Figure come Godric di Finchale o San Bernardino da Siena dimostrano che l’attività commerciale e finanziaria non solo esisteva, ma a volte veniva anche vista positivamente.La vera relazione tra protestantesimo e capitalismo
In realtà, le idee e le azioni di Calvino e dei puritani si sono spesso scontrate con quello che oggi chiamiamo spirito capitalistico. Calvino condannava chi faceva dell’usura una professione e vedeva la “vocazione” (il proprio lavoro) come l’accettazione della condizione in cui ci si trovava, non come una spinta a espandersi e guadagnare senza limiti. La città di Ginevra, guidata da Calvino, era una specie di stato religioso che non vedeva di buon occhio la crescita della ricchezza e l’importanza data al singolo nell’economia. Anche il movimento puritano in Inghilterra e nelle colonie americane si opponeva fortemente all’avidità di denaro, cercando di regolare l’economia secondo principi religiosi e condannando i profitti eccessivi. Esempi storici, come la Scozia calvinista che rimase economicamente indietro, o l’Olanda, dove il capitalismo fiorì in un ambiente con diverse religioni e più tolleranza (spesso nonostante l’opposizione dei calvinisti più rigidi), sembrano contraddire l’idea di Weber. Predicatori puritani come John Bunyan o Richard Baxter mettevano l’accento sul non dare importanza alle ricchezze terrene e sul cercare la salvezza attraverso la fede e l’allontanamento dalle cose materiali, non attraverso il successo economico. Consideravano l’amore per il denaro la causa di tutti i mali. Rifiutavano l’economia di mercato, con le sue regole di domanda e offerta, preferendo un’etica basata sulla carità e sul bene di tutta la comunità.Calvinismo e puritanesimo, quindi, non hanno creato lo spirito capitalistico. Piuttosto, hanno cercato di mettere un freno a un modo di pensare basato sull’accumulo individuale che era già in atto, nato dalle pratiche concrete degli uomini d’affari. Questo spirito, alla fine, è riuscito ad affermarsi nonostante la resistenza religiosa.Il capitolo smonta la tesi di Weber, ma l’alternativa proposta è davvero sufficiente a spiegare un cambiamento così radicale come l’origine dello spirito capitalistico?
Il capitolo offre una critica serrata alla visione che lega l’origine dello spirito capitalistico all’etica protestante, evidenziando come pratiche razionali e orientate al profitto esistessero già e come il protestantesimo, in alcune sue forme, abbia persino resistito a certi aspetti del capitalismo nascente. Tuttavia, l’alternativa proposta, che fa risalire questo spirito alle “pratiche concrete degli uomini d’affari”, pur plausibile, rischia di rimanere un’affermazione che necessita di maggiore approfondimento. Per comprendere appieno da dove nasca questa nuova mentalità economica, al di là della semplice constatazione della sua esistenza, è utile esplorare più a fondo la storia economica del tardo medioevo e della prima età moderna, analizzando le trasformazioni sociali, tecnologiche e istituzionali che hanno favorito l’emergere e la diffusione di tali pratiche. Approfondire gli studi di storia economica, sociologia storica e storia delle idee può fornire un quadro più completo. Letture di autori come Werner Sombart (per confrontare le diverse teorie sulle origini), Fernand Braudel (per il contesto storico delle economie pre-industriali) o Jacques Le Goff (per la mentalità medievale verso il denaro e il commercio) possono aiutare a collocare la discussione in una prospettiva più ampia e a cercare le radici profonde di quel “calcolo” e di quella “razionalità” che il capitolo identifica come centrali.3. La gabbia e la fuga del capitale
La Riforma protestante, nelle sue origini con figure come Lutero e Calvino, non favoriva il capitalismo. Al contrario, si presentava come una forza contraria allo spirito commerciale e al desiderio di guadagno. Cercava di riportare la religione a una forma più pura e di frenare l’influenza crescente dell’economia di mercato. Il mercato, infatti, tende a sciogliere i legami tra le persone basati sulla solidarietà. Li sostituisce con rapporti basati sull’interesse personale e sul calcolo, trasformando la società in un insieme di individui che pensano solo a sé stessi. Il movimento puritano in Inghilterra, in particolare, rappresenta una reazione contro il capitalismo da parte di gruppi sociali che stavano perdendo importanza. Questi gruppi erano messi in difficoltà dall’espansione del mercato e cercavano di imporre un ordine sociale molto rigido e basato sulla comunità, che era contro il profitto e l’idea di prestare denaro a interesse.Lo spostamento economico in Europa
Il centro economico d’Europa si è spostato dal sud al nord nel Seicento. Questo cambiamento non è avvenuto per via dell’etica protestante, ma a causa della reazione della Chiesa cattolica, chiamata Controriforma. Nei paesi rimasti cattolici, la Chiesa si è alleata con la Spagna e ha imposto un controllo molto severo attraverso l’Inquisizione. Questo ha soffocato la libertà di pensiero e l’iniziativa economica. In un clima di intolleranza, dove non c’erano garanzie per la proprietà privata e per chi voleva avviare nuove attività, molti mercanti, artigiani e persone colte sono fuggiti. Sono andati nei paesi protestanti. Qui, le diverse fedi religiose presenti portavano a una maggiore tolleranza e ad accogliere meglio gli stranieri. Quindi, essere tolleranti e accoglienti è diventato un fattore fondamentale per la crescita economica.Il Dispotismo e l’Assenza di Capitalismo in Oriente
Nelle grandi civiltà orientali, come la Cina, l’Impero Ottomano, la Russia degli zar o l’antico Egitto, il capitalismo non si è sviluppato. La ragione è la presenza di uno Stato molto potente e centralizzato, basato sulla burocrazia, che viene chiamato “Megamacchina”. Questo Stato aveva il controllo totale sulla terra e su quasi ogni aspetto della vita delle persone e dell’economia. Impediva che nascessero gruppi sociali indipendenti dallo Stato e non proteggeva la proprietà privata. La priorità assoluta era mantenere la stabilità e il controllo politico, anche a costo di non seguire una logica economica efficiente e di bloccare lo sviluppo. Le grandi costruzioni come le Piramidi o la Grande Muraglia servivano prima di tutto a tenere unita e sotto controllo la popolazione, non a scopi economici. Quindi, uno Stato dispotico e burocratico e il capitalismo non possono esistere insieme.Ma il mercato è davvero l’unica via per la libertà e la ragione, o nasconde anche insidie?
Il capitolo presenta il mercato quasi esclusivamente come un agente liberatorio e razionalizzante, fondamentale per la modernità. Tuttavia, questa prospettiva rischia di semplificare eccessivamente un rapporto complesso, ignorando le critiche mosse al mercato e al capitalismo, che evidenziano come possano generare disuguaglianze, alienazione, o una mercificazione di aspetti non economici della vita, potenzialmente limitando certi tipi di libertà o forme di razionalità non strumentale. Per approfondire questa complessità, è utile esplorare la storia economica da diverse angolazioni e confrontarsi con autori che hanno analizzato criticamente il rapporto tra economia, società e potere, studiando le dinamiche sociali del capitalismo, le sue crisi, o le alternative proposte ai modelli di mercato dominanti.8. La Scoperta della Società e le Sue Contraddizioni
La sociologia nasce in Inghilterra nel XVIII secolo. In quel periodo si inizia a guardare alla società come a qualcosa di autonomo, con regole proprie, da studiare con metodi simili a quelli delle scienze naturali. Questa nuova disciplina appare quando si scopre che la società civile è una sfera separata dallo Stato e dalla politica. Prima, infatti, il sociale e il politico erano visti come la stessa cosa, e il potere pubblico non aveva limiti.La Società Civile e la Modernità
La rivoluzione industriale e la crescita del capitalismo rendono chiara l’esistenza della società civile. È un sistema di relazioni che funziona in modo autonomo rispetto allo Stato, guidato soprattutto dalla logica economica. È così che nascono la sociologia e l’economia, che usano un approccio pratico per capire questa nuova realtà. La società non viene più vista solo attraverso la politica, ma anche considerando l’economia e la cultura.La Società come Realtà Culturale
La società è anche una realtà fatta di cultura. È un insieme di modi di pensare, sentire e agire che vengono trasmessi e diventano regole. La cultura, imparata fin da piccoli attraverso la socializzazione, influenza profondamente il modo in cui le persone si comportano. Ogni individuo è formato in modo marcato dalla società in cui vive. La tradizione culturale, pur ponendo dei limiti, è anche fondamentale per il progresso.Le Sfide della Modernità
I primi sociologi osservano la Modernità con ammirazione per i suoi cambiamenti rapidi, ma anche con preoccupazione. Vedono che il prevalere del mercato e dell’individualismo indebolisce i legami tra le persone e le comunità. Allo stesso tempo, la diminuzione dell’influenza della religione e delle tradizioni mette in crisi le vecchie regole. Questo crea una situazione di incertezza e disordine sociale.Le Contraddizioni della Modernità
La Modernità porta con sé delle contraddizioni profonde. Se la secolarizzazione non ha più limiti, può mettere a rischio l’accordo sui valori fondamentali che tengono unita la società e sono la base della democrazia. C’è il pericolo che si arrivi a un’assenza totale di valori o, al contrario, che lo Stato diventi più autoritario per imporre l’ordine. Le maggiori possibilità economiche offerte dal capitalismo creano aspettative sempre più alte, ma anche frustrazione perché queste opportunità non sono distribuite in modo uguale. Inoltre, l’aumento di gruppi con interessi diversi e la capacità di bloccare le decisioni rendono difficile risolvere i problemi comuni, portando a una situazione di difficile gestione.La Prospettiva Attuale
Oggi, la sociologia non ha risposte semplici a queste difficoltà. La fiducia che il progresso avvenga per forza è scomparsa. C’è la consapevolezza che la Modernità contiene in sé elementi che possono portare alla distruzione e che il suo futuro non è certo.Ma davvero la società è stata “scoperta” solo nel Settecento, come se prima non esistesse o non fosse pensata in modo distinto dallo Stato?
Il capitolo presenta la nascita della sociologia come una “scoperta” della società civile separata dallo Stato, suggerendo che prima sociale e politico fossero indistinguibili e il potere pubblico illimitato. Questa narrazione, pur cogliendo un punto di svolta importante, rischia di semplificare eccessivamente secoli di pensiero politico e sociale. Per comprendere meglio la transizione concettuale che porta alla sociologia, è fondamentale esplorare come filosofi e pensatori precedenti abbiano affrontato temi come la natura umana, le forme di convivenza, i limiti del potere e le dinamiche comunitarie. Approfondire la storia del pensiero politico e sociale, leggendo autori come Hobbes o Locke, può fornire il contesto necessario per capire che l’idea di una sfera sociale distinta, sebbene non formalizzata come “società civile” nel senso moderno, non è nata dal nulla nel XVIII secolo, ma affonda le radici in dibattiti molto più antichi sulla relazione tra individuo, comunità e autorità.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]