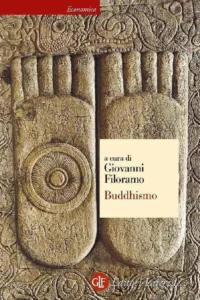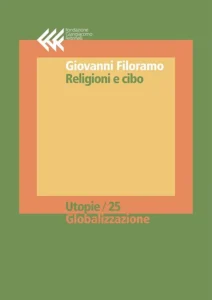Contenuti del libro
Informazioni
“Rituali e modelli etici del pentimento. Ebraismo, cristianesimo, islam, Giovanni Filoramo.” di Giovanni Filoramo, basato su questo riassunto, sembra un viaggio affascinante attraverso la storia e l’evoluzione dell’Islam. Il libro parte dalle origini, descrivendo l’Arabia preislamica e l’impatto rivoluzionario della figura di Muhammad a Mecca e Medina, dove nasce la prima comunità musulmana e si definiscono le basi della fede e della legge islamica, attingendo al Corano e alla Sunna. Esplora come queste fonti siano state interpretate nel tempo, dando vita a diverse scuole giuridiche islamiche e fissando i pilastri dell’Islam. Non si ferma qui, ma analizza le crisi interne e le spinte al rinnovamento, come il movimento wahhabita o le riforme nel sufismo, e soprattutto il confronto cruciale con la modernità islamica e il colonialismo, che ha portato a movimenti come la Nahda e la Salafiyya, e all’emergere dell’Islam politico con idee come il jihād. Un aspetto centrale è anche la storia delle divisioni interne, in particolare tra sunnismo e sciismo, e come queste divergenze abbiano portato alla nascita di varie sette islamiche e persino alla fede Baha’i, mostrando la ricchezza e la complessità di questa tradizione religiosa attraverso i secoli e in diverse aree geografiche.Riassunto Breve
La penisola arabica prima dell’Islam presenta ambienti vari, con società nomadi e sedentarie e culti legati a divinità locali e astri, venerate in luoghi come la Ka‘ba a Mecca, centro di pellegrinaggi e commercio. Figure come i *sādin* e i *kāhin* interpretano il volere divino. Pratiche sociali includono *wa’d al-banāt* e *maysīr*. Muhammad riceve la rivelazione coranica a Mecca, predicando monoteismo e criticando l’élite, subendo persecuzioni. L’*ègira* a Medina nel 622 crea la *umma*, una comunità di fede. Muhammad diventa capo politico e religioso, introducendo il *ǵihād* e modificando rituali come la *qibla* e il digiuno di *ramaḍān*. Conflitti militari come Badr e Uhud segnano questa fase, culminando nella conquista di Mecca nel 630 e l’affermazione dell’Islam. Dopo la morte del Profeta, Abu Bakr consolida il potere e completa la conquista. La legge e la fede si basano sul Corano e sulla Sunna, raccolti e autenticati. Quando queste fonti non bastano, si ricorre al consenso (*Ijma’*) e al ragionamento analogico (*Qiyas*). Questo sforzo interpretativo (*Ijtihad*) porta alla formazione di scuole giuridiche (*Madhahib*). I precetti fondamentali sono i cinque pilastri: *Shahada*, *Salat*, *Zakat*, *Sawm*, *Hajj*. Dal diciassettesimo secolo, il sapere religioso tradizionale affronta una crisi, portando a spinte di rinnovamento. Una corrente propone un ritorno rigoroso a Corano e Sunna, criticando *ijma’* e *ijtihad*, culminando nel wahhabismo. Un’altra risposta viene dal neo-sufismo, che cerca di riformare le confraternite per ripristinare purezza spirituale ed equilibrio con la legge islamica. Dalla fine del Settecento, il mondo musulmano si confronta con la modernità occidentale, segnata dall’arrivo di Napoleone in Egitto. Questo impatto culturale porta alla *Nahḍa*, un periodo di rinnovamento con pensatori come al-Afghānī, ‘Abduh e Riḍā (Salafiyya), che cercano di conciliare tradizione e progresso o di tornare alle fonti pure. La modernità arriva con il colonialismo, creando tensioni e un’immagine occidentale dell’Islam in declino. Emerge il nazionalismo, ma la separazione tra religione e politica resta ambigua. Dagli anni Settanta, l’Islam militante critica l’Occidente e i regimi esistenti usando concetti come *jahiliyya* e *ḥākimiyya*, promuovendo il *jihād*. Figure come al-Mawdūdī e Quṭb politicizzano l’Islam. Lo sciismo sviluppa idee simili con al-Ṣadr e Sharī‘atī, portando alla rivoluzione iraniana. Oggi, l’Islam contemporaneo è segnato dalla contestazione e dalla presenza in Europa, dove si confronta con la secolarizzazione. Le divisioni nell’Islam iniziano subito dopo la morte del Profeta per disaccordi sulla guida. Una parte sostiene l’elezione (Sunniti), l’altra la successione per diritto divino ai discendenti di ‘Alī (Sciiti). Questa divergenza politica diventa religiosa, con gli Sciiti che sviluppano una visione sacrale dell’Imam. Lo sciismo si divide in Imamiti (dodici Imam), Ismailiti (sette Imam, dottrine esoteriche) e Zayditi (Imamato elettivo). Dalle correnti sciite più estreme (*ghuluww*) nascono gruppi settari minori come Nusairi e Drusi, con cosmologie segrete e credenze nell’incarnazione divina. Anche movimenti influenzati dal sufismo, come Hurufi, Bektashi e Ahl-i Haqq, presentano dottrine esoteriche. Questi gruppi distinguono tra aspetto esteriore (*ẓāhir*) e interiore (*bāṭin*), privilegiando il secondo. Alcuni, come i Baha’i, si dichiarano nuove religioni. La Fede Bahā’ī ha radici nello sciismo e nel sufismo, ma evolve verso principi universali come l’unità umana, la pace e l’uguaglianza. I testi iniziali sono legati al contesto islamico, quelli successivi mostrano contatto con il pensiero occidentale. L’attenzione si sposta su aspetti sociali e umani. Le pratiche rituali sono semplici: preghiere quotidiane, riunioni ogni diciannove giorni, digiuno annuale. L’organizzazione è distintiva, con assemblee elettive locali e nazionali che eleggono la Casa Universale di Giustizia ad Haifa. La religione è orientata a obiettivi pratici per un nuovo ordine mondiale, con un’influenza persiana originaria che diminuisce.Riassunto Lungo
1. L’Arabia prima e dopo la Rivelazione
La penisola arabica presentava una grande varietà di ambienti. Nelle regioni del sud esistevano sistemi di irrigazione avanzati, mentre le zone centrali e settentrionali erano prevalentemente aride. Qui vivevano popolazioni sia nomadi che sedentarie. Le culture che esistevano prima dell’arrivo dell’Islam mostravano credenze diverse, spesso legate all’osservazione delle stelle e al culto di divinità locali. Queste divinità venivano venerate in luoghi sacri, tra cui spiccava la Ka‘ba nella città di Mecca. Figure religiose importanti erano i sādin, che avevano il compito di custodire i santuari, e i kāhin, indovini che cercavano di interpretare la volontà divina attraverso diverse pratiche.Mecca: Centro Sacro e Commerciale
Mecca non era solo un centro religioso cruciale per i pellegrinaggi (‘umra e ḥaǵǵ), che prevedevano riti come la circumambulazione della Ka‘ba e sacrifici di animali. Era anche un nodo fondamentale per il commercio che avveniva tramite carovane. La posizione dominante di Mecca si basava su una rete di alleanze strategiche (īlāf) e sulla sua forza militare. In questa società erano diffuse alcune pratiche sociali caratteristiche, come il wa’d al-banāt, che consisteva nell’infanticidio femminile, e il maysīr, un tipo di sorteggio che coinvolgeva la carne di cammello.L’inizio della Rivelazione a Mecca
Muhammad riceve la prima rivelazione del Corano proprio a Mecca. Inizia a diffondere un messaggio che promuove un monoteismo rigoroso, l’idea di credere in un unico Dio senza associargli altre divinità. Allo stesso tempo, critica duramente l’egoismo dei ricchi e la pratica dell’usura (ribā), che considerava ingiusta. Questo messaggio innovativo e critico incontra una forte resistenza da parte dell’élite meccana, che si sente minacciata. La conseguenza è la persecuzione dei primi seguaci di Muhammad, che spesso appartenevano agli strati sociali più deboli della popolazione.L’Emigrazione a Medina e la Nascita della Comunità
Un momento decisivo è l’emigrazione, o ègira, verso la città di Medina nel 622. Questo evento segna una svolta fondamentale. A Medina si forma la umma, una comunità di credenti unita dalla fede religiosa, superando i tradizionali legami basati sul sangue o sulla tribù. Muhammad assume il ruolo di guida sia politica che religiosa di questa nuova comunità. La necessità di provvedere al sostentamento porta i musulmani a organizzare razzie contro le carovane che partivano da Mecca. Viene introdotto il concetto di ǵihād, inteso come guerra legale, inizialmente con scopi difensivi, ma in seguito utilizzato anche in modo offensivo. Vengono apportati anche cambiamenti importanti nei riti. La direzione della preghiera (qibla) viene spostata verso la Ka‘ba a Mecca, abbandonando la precedente direzione verso Gerusalemme. Viene inoltre istituito il digiuno durante il mese di ramaḍān. Questi cambiamenti rituali contribuiscono a differenziare in modo più netto l’Islam dall’ebraismo.I Conflitti e la Conquista di Mecca
La fase di Medina è caratterizzata da importanti scontri militari. Nella battaglia di Badr, i musulmani ottengono una vittoria significativa. In quella di Uhud, invece, subiscono una sconfitta. C’è poi l’assedio di Medina, noto come battaglia del Fossato, che si conclude con la ritirata delle forze meccane e con rappresaglie contro le tribù ebraiche presenti a Medina. Accordi strategici, come quello firmato a Ḥudaybiyya, preparano il terreno per la conquista di Mecca. La conquista avviene nel 630 ed è un evento cruciale. Porta alla distruzione di tutti gli idoli che si trovavano all’interno della Ka‘ba. Questo successo militare e religioso afferma definitivamente il dominio dell’Islam sull’intera regione.La presentazione del ǵihād nel capitolo non rischia di ridurre un concetto complesso e dibattuto a una semplice evoluzione da difensivo a offensivo?
Il capitolo, pur menzionando il ǵihād, lo descrive principalmente come ‘guerra legale’ evolutasi da difensiva a offensiva. Questa presentazione, sebbene comune, rischia di semplificare un concetto che nella storia e nella teologia islamica ha assunto significati molteplici, inclusa la lotta spirituale interiore, e la cui applicazione militare è stata oggetto di ampio dibattito e interpretazioni diverse nel corso dei secoli. Per comprendere appieno la complessità del ǵihād e il suo ruolo nella storia dell’Islam, è fondamentale approfondire gli studi di storia islamica e di diritto islamico. Autori come Wael Hallaq o Patricia Crone offrono prospettive critiche e approfondite che vanno oltre la narrazione lineare.2. Le Radici della Legge e della Fede Islamica
Dopo la morte del Profeta Muhammad nel 632, la comunità musulmana affrontò la necessità di definire la propria struttura e le proprie norme per guidare la vita dei credenti. Abu Bakr, il primo califfo, consolidò il potere a Medina, reprimendo le rivolte interne e affermando con forza la natura universale dell’Islam, che andava oltre i semplici legami tribali. La conquista della Penisola Arabica si completò rapidamente sotto la sua guida, e i santuari pagani vennero sostituiti da moschee, simboli della nuova fede. Questa espansione iniziale fu interpretata e vista dai primi musulmani come una conseguenza diretta della forza spirituale dell’Islam e della giustezza dei suoi valori.
Le Fonti della Legge e della Fede
La guida della comunità e la definizione delle sue regole si basarono fin da subito su fonti precise e riconosciute da tutti. Il Corano, considerato la parola diretta di Dio rivelata al Profeta, fu la prima e più importante fonte. Venne raccolto e standardizzato per preservarne l’integrità, anche se diverse letture e interpretazioni furono accettate nel tempo. L’interpretazione del testo sacro si sviluppò attraverso commentari basati sulla tradizione e sull’opinione dei dotti. La Sunna, ovvero l’esempio, le azioni e gli insegnamenti del Profeta Muhammad, rappresentò la seconda fonte normativa fondamentale. Le sue pratiche e detti furono raccolti in narrazioni chiamate Hadith, la cui autenticità fu verificata con grande cura analizzando le catene di trasmissione dei testimoni. Le prime generazioni di musulmani, in particolare i Compagni del Profeta, ebbero un’autorità speciale nella trasmissione e nell’interpretazione di questi insegnamenti.
Interpretazione e Sviluppo del Diritto
Quando né il Corano né la Sunna offrivano risposte dirette a nuove questioni che emergevano nella vita quotidiana della comunità, si ricorse ad altri strumenti interpretativi. Il consenso della comunità dei dotti (Ijma’) divenne una fonte normativa importante, permettendo flessibilità e adattando la legge islamica alle situazioni emergenti in contesti diversi. Il ragionamento analogico (Qiyas) fu un altro metodo utilizzato per applicare principi stabiliti a casi nuovi non esplicitamente trattati nelle fonti primarie, cercando similitudini e differenze. Questo intenso sforzo interpretativo e di ragionamento (Ijtihad), svolto dai sapienti, portò alla formazione di diverse scuole giuridiche (Madhahib) nel corso dei secoli. Queste scuole sistematizzarono la legge islamica e coesistettero pacificamente, offrendo ai fedeli diverse opzioni interpretative e pratiche riconosciute per affrontare le complessità della vita.
I Pilastri Fondamentali dell’Islam
I precetti fondamentali che scandiscono la vita religiosa di ogni credente furono definiti come i “pilastri” dell’Islam, punti fermi che ogni musulmano è chiamato a osservare. Il primo è la professione di fede (Shahada), che dichiara l’unicità di Dio e riconosce Muhammad come Suo messaggero. Segue la preghiera rituale (Salat), eseguita in momenti specifici della giornata e con modalità precise, rivolti verso la Mecca. L’elemosina obbligatoria (Zakat) stabilisce regole precise per la raccolta e la distribuzione di una parte della ricchezza a favore dei bisognosi, purificando i beni e sostenendo la comunità. Il digiuno nel mese di Ramadan (Sawm) impone restrizioni alimentari e comportamentali dall’alba al tramonto, promuovendo la disciplina spirituale, l’empatia verso i meno fortunati e la vicinanza a Dio. Infine, il pellegrinaggio alla Mecca (Hajj) è un dovere per chi ne ha le possibilità fisiche ed economiche, con riti che rievocano momenti cruciali della storia sacra e rafforzano il senso di comunità globale dei credenti.
Ma quanta “grande cura” è stata effettivamente sufficiente per garantire l’autenticità di una tradizione che si è formata nel tempo?
Il capitolo accenna alla verifica dell’autenticità degli Hadith con “grande cura”, ma non esplora le complessità e le controversie legate a questo processo. La scienza della critica degli Hadith è un campo vastissimo e dibattuto, sia all’interno della tradizione islamica stessa (dove esistono diverse metodologie e valutazioni) sia nella ricerca storica e filologica moderna. Per comprendere meglio la questione, è fondamentale approfondire lo studio della storia delle prime generazioni musulmane, le metodologie di trasmissione orale e scritta, e le diverse scuole di pensiero sulla valutazione delle fonti. Approfondire autori che si sono occupati di critica testuale e storica delle fonti islamiche può offrire prospettive cruciali.3. Le Diverse Vie del Rinnovamento
Il sapere religioso tradizionale nell’Islam, tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo, attraversò un momento difficile. Le interpretazioni consolidate e le scuole di pensiero affermate mostravano segni di rigidità. C’era meno apertura al dibattito e al confronto con idee nuove. Questo portò a una certa divisione e debolezza interna. In risposta a questo stato di cose, si fecero strada diverse proposte per rinnovare la fede e la sua pratica.Un Ritorno alle Origini
Una delle risposte fu un forte desiderio di tornare alle fonti essenziali dell’Islam: il Corano e gli insegnamenti del Profeta (la Sunna). Questa corrente mise in discussione le interpretazioni e il consenso (ijma’) che si erano formati nei secoli successivi. Si ispirò a pensatori precedenti come Ibn Taymiyya e portò alla nascita del movimento wahhabita. Il wahhabismo promosse un’idea di monoteismo molto pura e criticò aspramente le pratiche religiose popolari e alcune espressioni del sufismo, viste come forme di idolatria. L’obiettivo era ristabilire la purezza originale della fede.Il Rinnovamento Spirituale nel Sufismo
Un’altra via di rinnovamento emerse all’interno del sufismo, la dimensione mistica dell’Islam. Molti maestri sufi si impegnarono per riformare le proprie confraternite. Queste, in alcuni casi, avevano perso la loro purezza spirituale, accumulando potere o mostrando segni di declino. Questo movimento, a volte chiamato “neo-sufismo”, cercò di ritrovare l’equilibrio tra la ricerca spirituale interiore e il pieno rispetto della legge islamica. Figure importanti in questo sforzo furono al-Darqawi, al-Tijani e Shah Wali Allah, ognuno con metodi diversi, come il ritorno diretto agli insegnamenti del Profeta o la sintesi di vari saperi islamici. Queste diverse correnti di riforma segnarono un periodo di cambiamento profondo, preparando il terreno per l’evoluzione dell’Islam nei secoli successivi, fino all’era moderna e contemporanea.Ma questi ‘gruppi esoterici’ sono davvero solo ‘sette nascoste’ nate da correnti ‘radicali’ sciite?
Il capitolo presenta questi movimenti come una derivazione diretta di correnti sciite “radicali”, ma la loro genesi è spesso il frutto di un complesso sincretismo di idee teologiche, filosofiche e mistiche, non solo islamiche. La definizione di “esoterico” e il confine tra dottrina interna e pratica esterna meritano un’analisi più approfondita. Per cogliere la reale complessità di questi gruppi, è necessario esplorare la storia del pensiero islamico, le diverse scuole sciite (in particolare l’Ismailismo), il Sufismo e le influenze gnostiche e filosofiche. Approfondire autori come Henry Corbin o Marshall Hodgson può fornire gli strumenti concettuali necessari.6. La Fede Bahā’ī: Trasformazione e Organizzazione
La fede Bahā’ī concentra la sua attenzione sugli aspetti sociali e umani della vita. I principi fondamentali che guidano i suoi seguaci includono l’unità di tutta l’umanità, la ricerca della pace universale e la promozione dell’uguaglianza tra le persone. Combattere ogni forma di pregiudizio è considerato un elemento centrale e indispensabile. Il modo in cui i fedeli praticano la loro religione si basa profondamente sul rispetto e sulla messa in pratica di questi principi essenziali. Questo orientamento verso l’unità e l’uguaglianza riflette un impegno concreto per costruire una società globale più armoniosa e giusta.Evoluzione degli Scritti
Gli scritti sacri della fede Bahā’ī mostrano un’evoluzione nel corso del tempo. Le prime opere del fondatore sono strettamente connesse alle idee e ai simboli tipici dello sciismo e del sufismo. Questo legame fa sì che alcuni testi antichi siano pienamente comprensibili solo a chi possiede una conoscenza specifica di quelle tradizioni. Tuttavia, gli scritti successivi, in particolare quelli di figure come ‘Abd al-Bahā’ e Shoghī Efendī, riflettono un contatto maggiore con il pensiero occidentale. Questa influenza successiva rende certe opere più accessibili e leggibili anche senza riferimenti diretti a concetti islamici. Tale evoluzione rende difficile presentare l’intera dottrina in un modo completamente uniforme e lineare.Pratiche Religiose
Le pratiche rituali della comunità Bahā’ī sono caratterizzate dalla loro semplicità. I fedeli sono invitati a recitare preghiere individuali tre volte al giorno. È importante notare che queste preghiere possono essere dette in qualsiasi lingua, sottolineando l’universalità del messaggio. Ogni diciannove giorni si tengono riunioni comunitarie che combinano momenti di lettura di testi sacri con discussioni sugli aspetti amministrativi e organizzativi. Inoltre, viene osservato un periodo di digiuno annuale, che si svolge dal 2 al 20 marzo. Durante questo digiuno, si evita di mangiare e bere dall’alba al tramonto, in modo simile a quanto accade in altre tradizioni.Struttura della Comunità
Un elemento distintivo della fede Bahā’ī è la sua struttura organizzativa ben definita. Inizialmente, la guida della comunità prevedeva la figura di un Tutore ereditario, la cui nomina doveva essere approvata da un apposito comitato. Dopo la scomparsa dell’ultimo Tutore, la responsabilità della guida è passata a un’assemblea eletta. Questo organismo centrale è chiamato Casa Universale di Giustizia e ha la sua sede principale nella città di Haifa. L’elezione di questo corpo avviene attraverso un processo che coinvolge i fedeli a livello locale e nazionale. I credenti eleggono assemblee locali e nazionali, le quali a loro volta contribuiscono all’elezione dei membri dell’organismo centrale di governo.Obiettivi e Origini
La religione è fortemente orientata verso il raggiungimento di obiettivi concreti e pratici. C’è l’intento chiaro di proporre e lavorare attivamente per un modello che possa portare a un nuovo ordine mondiale. Sebbene l’influenza delle origini persiane e delle radici sciite sia stata fondamentale per la nascita del movimento e per l’entusiasmo iniziale verso la figura del fondatore, tale influenza specifica si è affievolita nel tempo. Il richiamo alle radici sciite è meno presente oggi rispetto all’enfasi posta sugli obiettivi pratici e sull’organizzazione della comunità. Tuttavia, comprendere queste origini rimane essenziale per spiegare come il movimento ha avuto inizio e perché ha suscitato una devozione così forte.Come si concilia l’universalismo Bahā’ī con le sue specifiche e “fondamentali” origini sciite, che il capitolo ammette si siano “affievolite”?
Il capitolo, pur riconoscendo l’importanza “fondamentale” delle origini sciite per la nascita del movimento e l’entusiasmo iniziale, afferma poi che tale influenza si sia “affievolita nel tempo”. Questa apparente contraddizione lascia un vuoto esplicativo: come si è consumato questo “affievolimento”? E cosa implica per la coerenza interna di una fede che si proclama universale pur nascendo da un contesto settario specifico? Per colmare questa lacuna, è indispensabile studiare la storia del movimento Bābī e Bahā’ī nel suo contesto originale persiano, analizzando i testi fondativi alla luce delle tradizioni sciite e sufite da cui emergono. Approfondire autori che hanno esaminato criticamente l’evoluzione dottrinale e organizzativa, come Denis MacEoin, può fornire gli strumenti per comprendere meglio questa complessa transizione e la presentazione attuale della fede.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]