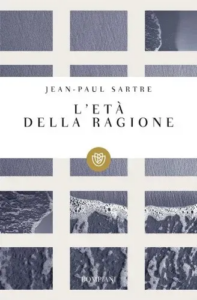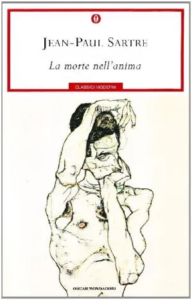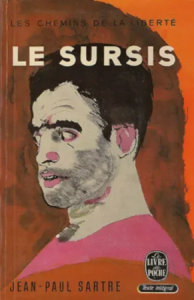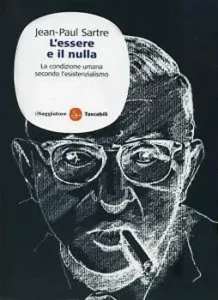1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Ribellarsi è giusto! Conversazioni con Philippe Gavi e Pierre Victor” di Jean-Paul Sartre è un libro che ti catapulta nel cuore del dibattito politico francese post-Maggio ’68, mettendo in discussione tutto quello che si pensava sulla rivoluzione. Attraverso un dialogo serrato, Sartre, Gavi e Victor analizzano la crisi del Partito Comunista Francese (PCF), criticato per la sua rigidità e la distanza dalla base operaia, e la rottura definitiva con il modello sovietico dopo eventi come l’intervento a Praga. Il focus si sposta sulla ricerca di una “nuova sinistra”, un movimento che nasca dalla “rivolta popolare” e dalla “democrazia diretta”, unendo le lotte di operai, contadini e altre categorie oppresse. Esperienze concrete come quella della “fabbrica Lip” diventano esempi di come il pensiero rivoluzionario nasca dall’azione e di come sia possibile costruire un “potere parziale” dal basso, mettendo in discussione la gerarchia e l’idea stessa di lavoro. È una riflessione appassionata sulla libertà, sulla sincerità politica e sul ruolo degli intellettuali, che devono integrarsi nelle lotte reali per costruire una società diversa, al di là dei vecchi schemi del marxismo tradizionale e dei partiti burocratici.Riassunto Breve
La critica si concentra sui partiti comunisti tradizionali, come il PCF, visti come strutture rigide e isolate dalla base operaia, che generano diffidenza e percepiscono ogni pensiero autonomo come una minaccia. Questi partiti tendono a rimandare la rivoluzione a un futuro lontano, diventando fine a se stessi e adottando valori borghesi per alleanze politiche, fallendo nell’unire le diverse lotte popolari. La rottura con questo modello avviene gradualmente, influenzata da eventi internazionali come l’intervento sovietico a Budapest e Praga, e dalla posizione del PCF sulla guerra d’Algeria. Il Maggio ’68 evidenzia l’esistenza di movimenti esterni al partito e porta a ripensare il ruolo dell’intellettuale, che deve integrarsi con le masse e agire concretamente. Si sviluppa un’alleanza con movimenti che promuovono la democrazia diretta e rifiutano la politica tradizionale e il suffragio universale come strumenti borghesi. L’azione rivoluzionaria diventa “sovversione istituzionale”, che combina elementi legali con una critica radicale per destabilizzare il sistema e creare legittimità popolare. L’obiettivo è fondere le diverse forze popolari – operai, contadini, intellettuali, donne, gruppi regionali – in un “crogiolo”, superando il marxismo deterministico e riconoscendo il valore delle singole lotte. L’intellettuale ideale si avvicina al lavoro manuale, diventando un “intellettuale-manuale”. La rivolta nasce dall’oppressione e dalla libertà, e il pensiero rivoluzionario emerge dalla pratica diretta delle masse, non imposto dall’esterno. Ogni atto di ribellione, anche individuale, è valido perché genera nuovo pensiero e sfida le norme. La verità si trova nel “pensiero di gruppo” che nasce dall’unione contro l’isolamento imposto dal sistema. Il popolo rivoluzionario include chiunque si ribelli all’oppressione. La militanza si basa sul desiderio di vivere meglio e sulla discussione aperta, non sul sacrificio. La strategia di cambiamento implica la creazione di “spazi sovversivi” e “potere parallelo” nella vita quotidiana e nel lavoro, come l’autogestione in fabbrica, che contestano gerarchie e divisione del lavoro. Lotte come quelle per l’uguaglianza salariale o ritmi di lavoro naturali mettono in discussione le strutture sociali. L’esperienza della fabbrica Lip dimostra la possibilità di un potere operaio concreto e simbolico, diffondendo l’idea che si può lavorare senza padroni. Una trasformazione fondamentale è il passaggio da un salario legato al lavoro a uno legato ai bisogni, sfidando il legame tra guadagno, qualifica e gerarchia. La repressione statale è una reazione a questi movimenti che promuovono l’uguaglianza. Le vecchie teorie rivoluzionarie basate sullo sciopero generale e la presa del potere statale centrale sono messe in discussione da esperienze come Lip, che mostra il valore del potere parziale e dell'”indipendenza di spirito” dei lavoratori, e il Cile, che evidenzia la necessità di conquistare parte delle classi medie. Emerge una nuova politica basata sulla sincerità e la discussione collettiva, che nasce dalle lotte concrete. La rivoluzione è un processo continuo. Il nuovo rivoluzionario non è un professionista, ma emerge dalle rivolte reali, unendo ruoli intellettuali e politici. La strategia mira a costruire una “maggioranza reale” unendo le “vittime del potere”. Il panorama politico attuale è un triangolo: il regime, la sinistra tradizionale (PCF/PS) e una nuova forza rivoluzionaria, anticapitalistica e antiburocratica, che si pone al di fuori dei partiti e sindacati tradizionali. Questa nuova sinistra deve mantenere la sua distinzione e trovare modi per agire concretamente senza cadere nelle vecchie abitudini politiche.Riassunto Lungo
1. La Paranoia dell’Istituzione Comunista
La struttura del Partito e la “Paranoia”
Il Partito Comunista Francese si presenta come un’organizzazione con regole molto rigide e una forte gerarchia. Questa struttura rende difficile uno scambio vero e diretto tra i vertici del partito e i lavoratori comuni. I membri del partito si trovano spesso isolati e tendono a non fidarsi di chi non fa parte della loro organizzazione, considerando gli alleati esterni come figure temporanee e non completamente affidabili. Questa chiusura crea un modo di pensare particolare, quasi una “malattia”, che si può definire paranoia. Ogni idea o iniziativa che nasce in modo spontaneo tra i lavoratori viene vista come un attacco o un complotto contro il partito, perché si pensa che le idee dei lavoratori debbano coincidere perfettamente con quelle del PCF.La Rivoluzione come Mito e le Scelte Strategiche
Il partito è nato in un momento in cui il movimento rivoluzionario era in una fase di stallo. Per questo, ha assunto il compito di rimandare la rivoluzione, presentandola come un evento lontano nel tempo, un “Sole dell’Avvenire”. Questo racconto serve ai membri per accettare più facilmente la situazione attuale, cioè la democrazia borghese, e la difficoltà del partito nel prendere il potere subito. La rivoluzione finisce per essere ridotta a semplici parole e gesti simbolici, e l’organizzazione del partito diventa importante fine a se stessa, diventando la misura di ciò che è giusto e di come devono andare le cose. Tutto ciò che si oppone a questa organizzazione viene considerato sbagliato e contro la rivoluzione.Fallimento nell’Unire le Lotte e l’Importanza della Libertà
Il PCF non riesce a mettere insieme la voglia di lottare degli operai con le proteste di altri gruppi sociali, come gli intellettuali o i contadini. Questo succede perché il partito non basa la sua azione sull’idea che la rivolta contro le ingiustizie debba essere continua. Al contrario, tende a controllare e a volte a fermare le proteste, e adotta idee tipiche della borghesia, come il diritto alla proprietà e il nazionalismo, per cercare accordi con partiti più moderati. Questo modo di agire, pensato per ottenere voti, va contro l’idea di una rivoluzione che si costruisce ogni giorno e spegne lo spirito di ribellione collettiva. In questo contesto, l’idea di libertà, specialmente la libertà di pensiero e di azione dei singoli membri, diventa un punto fondamentale in contrasto con il modo autoritario in cui il partito si comporta.Definire la cultura interna di un partito politico come una “malattia” o “paranoia” è un’analisi rigorosa o una semplificazione polemica che ignora le complessità storiche e strategiche?
Il capitolo usa termini molto forti per descrivere la chiusura e la sfiducia del Partito Comunista Francese, etichettandole come una “malattia” o “paranoia”. Questo approccio, sebbene efficace nel sottolineare una critica, rischia di ridurre fenomeni complessi a una diagnosi psicologica o patologica, trascurando le possibili radici storiche, le pressioni esterne (come la Guerra Fredda o il rapporto con l’URSS) e le dinamiche interne di un’organizzazione politica di massa che operava in un contesto democratico. Per comprendere meglio queste dinamiche, sarebbe utile approfondire gli studi di storia politica e sociologia delle organizzazioni, esaminando il contesto specifico del comunismo francese nel periodo considerato e le diverse interpretazioni storiografiche sulla sua evoluzione e le sue scelte strategiche. Approfondire autori che hanno analizzato la storia del PCF o i partiti comunisti occidentali può fornire un quadro più articolato.2. La rottura politica e l’impegno con la democrazia diretta
Le Rotture Politiche
Il distacco politico dall’Unione Sovietica inizia a farsi sentire dopo l’intervento a Budapest nel 1956. Questo allontanamento si rafforza con il caso degli scrittori Daniel e Sinjavskij, un momento in cui gli intellettuali sovietici scelgono di appoggiare il governo invece di difendere i loro colleghi. L’intervento militare a Praga nel 1968 segna poi la separazione completa e definitiva. Allo stesso tempo, il rapporto con il Partito Comunista Francese (PCF) si incrina già in precedenza, durante la guerra d’Algeria. Qui, la posizione del partito viene giudicata non abbastanza decisa e radicale.Il Maggio ’68 e la Nuova Strategia Politica
Il Maggio ’68 cambia profondamente il quadro politico. Questo periodo dimostra l’esistenza e la forza di movimenti di sinistra che operano al di fuori del Partito Comunista Francese. Mette inoltre in discussione il ruolo tradizionale dell’intellettuale, spesso visto come distante dalla realtà e legato a un’immagine di “divo”. Comprendere a fondo questo movimento richiede tempo e porta a ripensare la funzione dell’intellettuale stesso. Non deve più limitarsi a discorsi generali e universali, ma deve invece integrarsi attivamente nei gruppi e proporre azioni concrete e pratiche. L’alleanza che si forma con i movimenti maoisti si basa proprio sulla condivisione di un’idea di democrazia diretta. In questa visione, le decisioni importanti vengono prese in modo collettivo e si agisce per sostenere cause che sono percepite come giuste dalla morale della gente comune. Si prende così le distanze da un approccio politico basato sul machiavellismo e si critica l’inefficacia del suffragio universale. Quest’ultimo viene visto come uno strumento tipico della borghesia, capace di sostituire la legalità stabilita dallo stato alla legittimità che nasce dai movimenti popolari.L’Azione Sovversiva e l’Impegno dell’Intellettuale
Si inizia a distinguere tra un’azione che è solo legalista e una che è puramente illegalista, proponendo invece un tipo di azione definita “sovversiva istituzionale”. Questa forma di azione mescola elementi che rispettano la legge con una critica profonda e radicale del sistema esistente. L’obiettivo è destabilizzare il sistema sia dall’interno che dall’esterno. Si cerca così di allargare il contrasto che esiste tra la legittimità che proviene dal popolo e la legalità stabilita dallo stato. Si vuole spingere le persone a creare una propria legittimità, basata sui loro bisogni e sulla loro morale. L’impegno in questa direzione si manifesta anche attraverso la guida di giornali come “La Cause du Peuple”. Questo rappresenta un modo concreto per l’intellettuale di mettersi al servizio del movimento popolare. Significa anche accettare i limiti che possono derivare, ad esempio, dall’età, ma continuare a contribuire a un lavoro che guarda lontano. È un impegno per costruire nel tempo una futura società che sia socialista e per far nascere una nuova cultura che appartenga al popolo.Se il suffragio universale è solo uno strumento borghese che sostituisce la legalità alla legittimità, come si pensa di costruire una ‘legittimità popolare’ che sia concreta e non arbitraria?
Il capitolo critica aspramente il suffragio universale, definendolo uno strumento borghese che sostituisce la legalità alla legittimità. Tuttavia, non viene chiarito in modo sufficiente come la “legittimità popolare” che si propone come alternativa possa concretamente funzionare su larga scala, garantendo decisioni eque e stabili che non siano preda di fazioni o derive. Per colmare questa lacuna, sarebbe fondamentale approfondire gli studi sulla teoria politica e sulla sociologia dei movimenti, esaminando sia le critiche storiche ai sistemi rappresentativi sia le complesse sfide pratiche delle diverse forme di democrazia diretta o partecipativa. Autori come Robert Dahl, Norberto Bobbio o anche chi ha analizzato criticamente le esperienze storiche di autogoverno popolare potrebbero offrire prospettive necessarie.3. La fusione delle lotte popolari
Una nuova strategia rivoluzionaria è necessaria, andando oltre le idee del marxismo tradizionale. Si critica il Partito Comunista Francese perché sembra più interessato alle alleanze politiche che a mobilitare attivamente le persone, mancando così una vera teoria su come coinvolgere la popolazione. Questo approccio non riesce a cogliere le diverse forme di protesta e la capacità creativa delle masse, mostrando i limiti di una visione troppo rigida e deterministica. Il pensiero di Mao Tse-tung, invece, offre una prospettiva diversa, suggerendo l’importanza di unire forze diverse come operai e contadini per superare queste difficoltà.Il concetto di “crogiolo” e l’unione delle forze
Un’idea centrale è quella del “crogiolo”, che significa unire diverse forze popolari con le loro specifiche richieste. Questo include operai, contadini, intellettuali, studenti, donne e gruppi regionali. L’obiettivo è creare un fronte popolare più ampio unendo questi movimenti, nati ognuno da un particolare tipo di oppressione. Tuttavia, sorge la domanda se questa unione possa mettere a rischio o annullare i valori e le identità che rendono unico ogni singolo gruppo. L’idea è costruire una repubblica democratica federale dove il controllo sia direttamente nelle mani del popolo.Il ruolo degli intellettuali e i valori delle lotte specifiche
Il ruolo degli intellettuali viene visto in modo nuovo. Si pensa che debbano avvicinarsi di più alle persone comuni e al lavoro manuale, diventando una sorta di “intellettuale-manuale”. Questo significa superare la divisione tradizionale tra chi pensa e chi fa. Lotte specifiche, come quelle portate avanti dalle donne o dai movimenti regionali, creano valori unici e importanti. Anche se questi valori possono a volte sembrare conservatori, sono considerati contributi preziosi per il movimento generale. La sfida è riuscire a unire questi valori specifici in un movimento unico senza che perdano la loro particolarità o creino conflitti interni.Il capitolo propone di superare le vecchie divisioni di classe unendo diverse categorie “colpite dal potere”. Ma come si gestiscono i conflitti interni e si evita la formazione di nuove élite o burocrazie in una coalizione così eterogenea?
L’idea di una “maggioranza reale” che trascende le divisioni tradizionali è suggestiva, ma il capitolo non chiarisce i meccanismi pratici per armonizzare interessi potenzialmente divergenti (come quelli di operai e piccoli commercianti) e per garantire che questa nuova aggregazione non riproduca forme di potere o burocrazia che intende superare. Per approfondire queste sfide, è utile studiare la sociologia politica e la storia dei movimenti sociali, concentrandosi sulle dinamiche di coalizione e sulla teoria delle élite. Autori come Pareto, Mosca o Michels hanno analizzato la tendenza alla formazione di oligarchie anche nei contesti rivoluzionari.8. La Rivoluzione Ideologica e il Triangolo Politico
La nuova consapevolezza rivoluzionaria e lo scenario politico
Un nuovo tipo di individuo rivoluzionario sta emergendo, qualcuno che capisce il significato profondo delle proprie azioni e vede i collegamenti tra lotte che sembrano separate, come accaduto nel caso della Lip. Questa figura si distingue dai militanti più tradizionali, che tendono a seguire principi già stabiliti. La situazione attuale è considerata rivoluzionaria perché il modo in cui si affronta il lavoro sta cambiando radicalmente, con azioni come occupazioni di fabbriche e interventi diretti che mettono in discussione l’autorità borghese. Il panorama politico attuale si può vedere come un triangolo: da un lato c’è il regime al potere, dall’altro l’insieme dei partiti della sinistra tradizionale, come il Partito Comunista e il Partito Socialista, e infine una terza forza, rappresentata dalla rivoluzione ideologica o quella che viene chiamata nuova sinistra. Questa terza forza si oppone sia al capitalismo che alla burocrazia e si pone in contrasto con i sistemi dei partiti e dei sindacati tradizionali, come la CGT.Libertà, potere e la vera società socialista
La libertà viene intesa come un movimento di liberazione e di ribellione, non come l’esercizio del potere di un gruppo ristretto su tutti gli altri. Avere potere sugli altri significa non essere liberi. L’alienazione, cioè il sentirsi estranei o privati di qualcosa di essenziale, non riguarda solo i lavoratori, ma tocca tutte le classi sociali, inclusa la borghesia, anche se in forme diverse. Una società veramente socialista è quella in cui ogni persona è libera e il potere è condiviso tra tutti, senza imposizioni. Regimi che limitano la libertà, come quello sovietico, non possono quindi essere considerati socialisti perché sacrificano proprio questo aspetto fondamentale.Posizione e sfide della nuova sinistra
La nuova sinistra mantiene una posizione ben distinta rispetto all’unità della sinistra tradizionale. Il socialismo come quello realizzato in Russia è visto come un sistema basato sullo sfruttamento. C’è un acceso dibattito interno su come affrontare le elezioni: alcuni pensano che votare sia una trappola che finisce per rafforzare il vecchio sistema politico, mentre altri credono sia necessario partecipare per influenzare i rapporti di forza e sfruttare le contraddizioni che esistono all’interno della sinistra tradizionale. La forza della rivoluzione ideologica sta proprio nel suo essere fuori dai giochi politici consueti, ma questo solleva la questione di come questa forza possa avanzare e tradursi in azioni concrete senza ricadere nei vecchi schemi della politica tradizionale. È fondamentale ripensare le forme di organizzazione, andando oltre i modelli classici come il partito d’avanguardia.Ma questa “rivoluzione ideologica” e questo “nuovo individuo” di cui parla il capitolo, cosa propongono concretamente oltre a un generico rifiuto del vecchio sistema?
Il capitolo identifica correttamente una forza emergente e la sua distinzione rispetto alla sinistra tradizionale, ma la descrizione della sua sostanza ideologica e delle sue proposte positive rimane piuttosto vaga. Per comprendere meglio cosa possa significare una “rivoluzione ideologica” che non si limiti alla critica e che possa effettivamente costituire una “terza forza” con un programma proprio, è utile esplorare la teoria politica e la sociologia dei movimenti sociali. Approfondire autori che hanno analizzato le trasformazioni del soggetto politico e le nuove forme di azione e organizzazione al di fuori dei modelli partitici classici può aiutare a dare concretezza a questa figura del “nuovo individuo rivoluzionario” e a capire come la sua consapevolezza possa tradursi in un progetto politico definito.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]