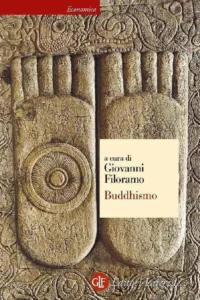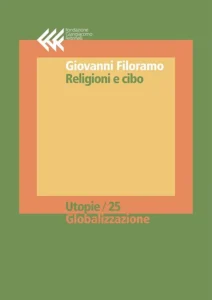Contenuti del libro
Informazioni
“Religione e religioni” di Giovanni Filoramo ti porta dentro il caos affascinante della trasformazione religiosa nel mondo di oggi. Non è più la religione di una volta, quella legata solo alla chiesa sotto casa; con la globalizzazione e i media digitali, tutto si mescola in un pluralismo religioso pazzesco. Vediamo la secolarizzazione che svuota le chiese in certi posti, ma anche nuove forme di religiosità che spuntano ovunque, dall’individualismo che cerca un “Dio personale” alle spiritualità New Age. Il libro esplora come le religioni si adattano (o resistono, a volte con il fondamentalismo) a questa modernità, come aiutano le persone a costruire la propria identità religiosa in un mondo che cambia, e come il concetto stesso di sacro si evolve. Non si ferma qui: affronta temi super attuali come il rapporto tra religione e leggi dello Stato, l’etica religiosa di fronte alla scienza e l’idea di dignità umana. È un viaggio per capire non solo le grandi fedi, ma anche tutte quelle sfumature e novità che rendono il panorama religioso contemporaneo così vivo e complesso.Riassunto Breve
Il mondo della religione sta cambiando molto, segnato dalla fine di un’epoca e l’inizio di una nuova, influenzata da come le persone si spostano nel mondo e dai mezzi digitali. Le religioni, che comunicano da sempre, usano ora internet come un grande spazio dove incontrarsi. Questo porta a tante religioni diverse che vivono insieme, soprattutto in Europa, anche per via delle migrazioni. Si vede che meno persone seguono le pratiche religiose vecchie, mentre nascono nuove forme e molti dicono di non appartenere a nessuna religione. Le religioni perdono un po’ il legame con i paesi e le culture di una volta, e le loro voci si mescolano nel mondo. Questo spinge le istituzioni religiose ad adattarsi o a resistere, a volte diventando più rigide (fondamentalismo), ma anche dando più importanza a chi sono e a cosa è giusto fare. Le persone cercano un “Dio personale” e crescono le spiritualità diverse, come la “religione del sé”, che mostrano quanto siamo diventati individualisti. La religione è sempre più un fatto globale, visibile nelle religioni portate via dalle migrazioni e in quelle che si trovano in tanti paesi, come il cristianesimo che cresce molto nel sud del mondo con comunità che sentono forte le emozioni. La globalizzazione e il fatto che ci sono tante fedi diverse portano a mescolanze che cambiano la mappa religiosa del mondo. Capire cos’è la religione è difficile perché cambia sempre e dipende da chi guarda. Le definizioni che le religioni danno di sé non bastano per chi le studia, che ha bisogno di un modo esterno per capirle. Guardare alla storia aiuta a vedere la religione non come qualcosa di fisso, ma come cambia nel tempo. La parola “religione” stessa ha una storia, è un concetto moderno nato in Occidente, legato al pensare in modo critico. Alcuni dicono che “religione” è un’idea occidentale usata per comandare e che sarebbe meglio usare “cultura”, ma “religione” resta utile per analizzare, sapendo che ha limiti storici. La parola viene dal latino *religio*, che significava pratiche verso gli dèi. Col cristianesimo diventa la “vera” fede, poi qualcosa di interiore, e in tempi moderni un fatto istituzionale o un’idea universale e astratta. Definire la religione significa considerare il linguaggio e rispettare l’esperienza religiosa, pur sapendo che è influenzata da fuori. Si possono usare definizioni che descrivono cosa fa la religione (funzionali), ma queste a volte non colgono cosa rende la religione unica, che va oltre il semplice servire a qualcosa. La religione si vede in tutto il mondo perché gli esseri umani usano linguaggio e simboli per dare un senso alle cose, rendendo sacri oggetti e idee. Il sacro è una parte fondamentale dell’uomo, pieno di mistero, potere e un po’ spaventoso, sia puro che impuro. È vitale per le religioni e in passato dava potere ai capi. Le religioni che vedono il sacro nel cosmo si legano a re sacri, mentre quelle che lo vedono nella volontà di un Dio unico portano a governi religiosi. Il sacro cambia nella storia e può diventare il santo, una persona che fa da ponte tra Dio e gli uomini. Altre cose che si trovano in tante religioni sono le storie sacre che spiegano chi è un gruppo e i riti che si ripetono per rinnovarsi, come le feste. La modernità, con la sua enfasi sulla ragione, sull’individuo e sulla scienza, mette in crisi le vecchie tradizioni religiose. Le sfide sono la critica razionale dei testi sacri, la richiesta di libertà religiosa e il fatto che la scienza spiega il mondo in modo diverso. Le religioni rispondono in vari modi. Alcune rifiutano la modernità e i suoi valori, diventando fondamentaliste. Altre aiutano il cambiamento moderno. Altre ancora cercano un accordo, mescolando tradizione e novità. Esempi si vedono nel giudaismo, nel cattolicesimo e nell’islam, con movimenti che cercano di unire fede e scienza o esigenze sociali. La situazione delle religioni nel mondo è complicata da misurare, perché i modi di contare cambiano e le persone non sempre restano legate a una fede. Le religioni si possono dividere per dove sono nate o per quanti seguaci hanno, con cristianesimo, islam, induismo e buddhismo che sono i più grandi, più un miliardo di persone senza religione. Le grandi fedi hanno divisioni interne e si spostano nel mondo. Il cristianesimo cresce in paesi come Brasile o Cina, mentre in Europa meno persone vanno in chiesa. Il protestantesimo è diviso in tanti gruppi, e aumentano i cristiani senza chiesa. Anche ebraismo, islam e buddhismo si sono spostati per eventi storici e migrazioni. Le migrazioni portano fedi diverse a vivere insieme, e la religione aiuta gli immigrati a mantenere la loro identità. L’identità è cruciale per capire i cambiamenti religiosi. Nelle società vecchie, l’identità religiosa era data dalla nascita e dalla comunità. Oggi, le persone scelgono di più, e l’identità religiosa diventa una cosa personale, anche se la comunità resta importante. Le religioni aiutano a formare l’identità con credenze, gruppi, riti e modi di dare senso alle cose. Questa funzione identitaria si vede nei nazionalismi religiosi, dove la fede è usata per rafforzare l’identità di un paese, a volte causando scontri. Il fondamentalismo, nato tra i cristiani ma presente in altre fedi, cerca di difendere un’identità di fede pura contro la modernità, spesso con effetti politici e un richiamo a un passato incontaminato. Accanto a questo, ci sono spiritualità nuove, come la New Age, che mostrano l’individualismo. Queste spiritualità puntano sulla crescita interiore, sul sentirsi realizzati e su una visione del mondo dove tutto è collegato e divino, spesso senza un dio preciso o chiese. Internet è una nuova dimensione che influenza la religione. Permette alle chiese di comunicare (Religion online) e crea spazi per esperienze religiose che esistono soprattutto online (Online Religion), dove l’identità può cambiare e i legami comunitari si ridefiniscono. La religione è una realtà complessa e presente nella società di oggi, anche dove sembra meno importante. Il suo ruolo pubblico rinnovato richiede nuovi modi per capirla, anche usando l’economia e le scienze che studiano la mente. Un punto importante è il rapporto tra religione e politica, specialmente per le fedi con leggi sacre basate sulla volontà divina, come la sharia nell’Islam. Questo crea tensione con le leggi dello Stato laico e pone ai credenti il problema di essere fedeli a due cose diverse. Le religioni monoteiste condannano il suicidio perché la vita è un dono di Dio, anche se alcune fedi orientali lo accettano per chi è molto spirituale. Il martirio rende difficile distinguere tra sacrificio e suicidio. La laicità dello Stato si confronta con le richieste delle comunità religiose in vari ambiti (lavoro, scuola, salute). Si discute se la laicità debba essere una separazione netta o permettere alle religioni di partecipare al dibattito pubblico, senza che le loro regole diventino leggi dello Stato. Le religioni offrono modi diversi di vedere il dolore e la sofferenza, spesso mettendoli in un piano divino. Aiutano la morale umana dando regole, esempi e un modo per giudicare, anche se la morale religiosa dipende spesso dalla dottrina sacra. I progressi della scienza, soprattutto nella bioetica (etica della vita), mettono in discussione le idee tradizionali su vita e morte. Il confronto tra bioetica religiosa e laica mostra la ricerca di una base etica comune. L’idea di dignità umana emerge come un valore che non si può toccare, riconosciuto anche dalla legge. La dignità viene dalla tradizione antica e da quella ebraico-cristiana (l’uomo fatto a immagine di Dio), ma le tradizioni religiose devono fare i conti con la sfida di unire l’idea che tutti hanno dignità con esclusioni passate o regole comunitarie strette. Serve un dialogo tra visioni religiose e umanistiche per costruire una solidarietà basata sul fatto che siamo tutti esseri umani.Riassunto Lungo
1. Nuovi Volti della Fede e il Senso di Religione
Una grande trasformazione sta cambiando il mondo religioso, segnando la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova. Questa nuova fase è molto influenzata dalla globalizzazione e dai mezzi di comunicazione digitali. Le religioni, che da sempre usano la comunicazione, si stanno adattando alla rivoluzione digitale, usando internet come uno spazio dove confrontarsi a livello mondiale.Questa trasformazione porta a una maggiore varietà di religioni, specialmente in Europa. Qui, le persone che arrivano da altri paesi creano società con culture e fedi diverse che vivono insieme. Allo stesso tempo, sempre meno persone seguono le pratiche religiose tradizionali e nascono nuove forme di spiritualità. Una parte crescente della popolazione dice di non appartenere a nessuna religione. Le religioni tendono a perdere il loro legame con i paesi e le culture locali, e le loro voci si mescolano nello spazio globale. Questo spinge le grandi organizzazioni religiose a cambiare o a resistere, a volte rafforzando idee più rigide, ma anche dando più valore al ruolo della religione per l’identità e i valori morali.La ricerca di un “Dio personale”
Il fatto che ognuno cerchi la propria strada religiosa porta a cercare un “Dio personale”. Crescono così forme di spiritualità diverse, come la “religione del sé”, che riflettono la varietà della società moderna. Questo modo di vivere la fede in modo più individuale influenza anche le religioni più organizzate. La religione diventa sempre più un fenomeno mondiale. Questo si vede nelle religioni portate in giro per il mondo dalle persone che migrano. Le religioni che esistono in molti paesi, come quelle monoteiste, mostrano di sapersi adattare a livello globale. Il cristianesimo, ad esempio, cresce molto nel “sud” del mondo con forme che danno importanza alle comunità basate sulle emozioni. La globalizzazione e la grande varietà di fedi portano a mescolanze che ridisegnano la mappa religiosa del mondo.La difficoltà di definire la religione
Definire cosa sia la religione è un compito difficile e si possono dare molte risposte diverse. La difficoltà nasce dal fatto che la religione e l’esperienza umana cambiano continuamente, ma anche dai modi diversi in cui gli studiosi la guardano. Le definizioni che le religioni danno di sé stesse non bastano per chi le studia, che ha bisogno di uno strumento per capire le cose dall’esterno.La storia del concetto di “religione”
Guardare alla storia è fondamentale per capire la religione non come qualcosa che è sempre uguale, ma attraverso come si è manifestata nel tempo. Anche la parola “religione” è uno strumento per capire, e ha una sua storia precisa nella cultura occidentale. Questa idea di “religione” come la usiamo oggi è moderna ed è legata al pensiero che usa la ragione per analizzare le cose.Critiche e modi per definire la religione
Alcuni pensatori più recenti mettono in dubbio l’idea di “religione”, dicendo che è stata costruita in Occidente e forse usata per dominare. Suggeriscono di usare piuttosto la parola “cultura”. Tuttavia, “religione” resta una parola utile per studiare questo fenomeno, a patto di essere consapevoli dei suoi limiti legati alla storia e alle idee del tempo. La parola viene dal latino religio, che indicava pratiche e modi di comportarsi verso gli dèi. Con il cristianesimo, ha preso il senso di “vera” religione e, con alcuni pensatori come Agostino e Ficino, un significato più interiore. In tempi moderni, soprattutto dal Seicento, ha prevalso il senso di organizzazione e istituzione. Tra Settecento e Ottocento, con filosofi come Kant, Hegel e Feuerbach, ha acquisito un significato più universale e astratto.Quando si cerca di definire la religione, bisogna considerare il linguaggio e rispettare che l’esperienza religiosa ha una sua autonomia, pur riconoscendo che è influenzata da fattori esterni. Le definizioni che si usano per lavoro possono essere basate su accordi o essere più semplici e concrete, considerando il legame tra le idee religiose, le pratiche e il gruppo sociale. Le definizioni che descrivono la religione in base a quello che fa per le persone (definizioni funzionali) rischiano di essere troppo ampie e di non cogliere ciò che rende la religione unica, che spesso va oltre il semplice avere una funzione pratica.Se il concetto di “religione” è una costruzione occidentale potenzialmente usata per dominare, non è forse un atto di dominazione continuare a usarlo per analizzare fedi non occidentali?
Il capitolo accenna alla critica del concetto di “religione” come costruzione occidentale, ma non approfondisce le implicazioni di tale critica. Se il termine è intrinsecamente legato a una storia e a un potere specifici, usarlo universalmente rischia di imporre categorie estranee o di perpetuare gerarchie. Per esplorare a fondo questa problematica, è cruciale confrontarsi con le prospettive critiche postcoloniali e con gli studi che decostruiscono le categorie analitiche occidentali. Autori come Talal Asad o Timothy Fitzgerald offrono strumenti concettuali fondamentali per mettere in discussione l’universalità del concetto di religione e per considerare approcci alternativi, magari più legati alla nozione di “cultura” o “formazioni discorsive”, come suggerito brevemente nel capitolo stesso.2. Il Sacro, la Modernità e le Risposte Religiose
Il Sacro e il suo Ruolo
La religione si presenta come un aspetto fondamentale della cultura umana, basata sulla capacità di usare il linguaggio e i simboli per dare un senso all’esperienza. Questo porta a considerare sacri alcuni oggetti o idee, creando così mondi religiosi diversi tra loro. Il sacro è una caratteristica profonda dell’essere umano, avvolto nel mistero, potente e con una doppia natura che unisce il puro e l’impuro. È una fonte essenziale per le religioni e ha rappresentato una base importante per il potere politico nelle società antiche.Le religioni che vedono il sacro manifestarsi nel cosmo, come quelle cosmocentriche, si legano spesso a forme di monarchia considerata sacra. Al contrario, le religioni che si basano su un messaggio profetico identificano il sacro con la volontà morale di un Dio unico, portando a modelli di governo più legati all’autorità religiosa, le teocrazie. Il concetto di sacro cambia nel corso della storia e può trasformarsi nell’idea di santo, una figura vista come un ponte tra il divino e l’umanità, che incarna valori etici elevati. Altri elementi universali delle religioni sono le storie sacre, che definiscono l’identità di un gruppo, e i riti che si ripetono periodicamente, come le feste, che servono a rinnovare il legame con il sacro.
Le Sfide della Modernità e le Risposte Religiose
L’epoca moderna, con il suo forte accento sulla ragione, sull’importanza dell’individuo e sui progressi della scienza, ha messo in discussione in modo profondo le tradizioni religiose. Queste sfide includono l’analisi critica dei testi sacri basata sulla ragione, la richiesta di libertà di scegliere la propria fede e il superamento delle vecchie visioni del mondo grazie alle scoperte scientifiche.Di fronte a questi cambiamenti, le religioni hanno reagito in modi diversi. Alcune hanno rifiutato completamente la modernità e i suoi valori, orientandosi verso posizioni molto rigide e legate alla tradizione, definite fondamentalismo. Altre, invece, hanno abbracciato il cambiamento, diventando addirittura motori di trasformazione nella società moderna. Una terza strada ha cercato un punto d’incontro, creando nuove forme culturali che uniscono elementi della tradizione con le novità moderne. Queste sintesi si vedono, ad esempio, nel giudaismo con le sue diverse correnti, nel cattolicesimo con il dibattito tra chi voleva aprirsi al nuovo e chi si opponeva, e nell’islam con vari movimenti che provano a far convivere la fede con la scienza e le esigenze della società contemporanea.
Ma davvero le risposte religiose alla modernità si lasciano ingabbiare in tre sole categorie così nette?
Il capitolo propone una tripartizione delle reazioni religiose alla modernità che, pur utile per una prima comprensione, rischia di semplificare eccessivamente un panorama molto più complesso e sfaccettato. Le dinamiche di adattamento, resistenza e innovazione all’interno delle tradizioni religiose sono influenzate da innumerevoli fattori storici, culturali e sociali specifici. Per cogliere appieno questa complessità, sarebbe utile approfondire gli studi sulla secolarizzazione e sulle trasformazioni religiose nel mondo contemporaneo, magari esplorando le opere di autori come Peter L. Berger o José Casanova.3. Identità in Trasformazione e la Fede nel Mondo Moderno
Misurare con precisione la situazione delle religioni nel mondo è difficile. Questo accade per via dei diversi modi in cui vengono raccolti i dati e perché le persone cambiano spesso la loro affiliazione religiosa. Si possono classificare le religioni in base a dove sono nate, come il Vicino Oriente, l’India, la zona Sino-Giapponese o l’Africa e l’Oceania. Oppure si possono guardare quante persone le seguono. In questo caso, il cristianesimo, l’islam, l’induismo e il buddhismo sono i gruppi più grandi, seguiti da circa un miliardo di persone che non si riconoscono in nessuna religione.Il panorama religioso globale in movimento
Le grandi religioni non sono un blocco unico, ma hanno molte divisioni interne. Anche la loro presenza nel mondo cambia nel tempo. Il cristianesimo, per esempio, sta crescendo molto in paesi come Brasile, Messico, Filippine, Nigeria e Cina. In Europa, invece, meno persone vanno in chiesa a causa della secolarizzazione. Il protestantesimo, in particolare, è diviso in tantissime chiese diverse, e sempre più cristiani scelgono di non affiliarsi a nessuna chiesa specifica. Anche l’ebraismo, l’islam e il buddhismo hanno visto le loro comunità spostarsi in diverse parti del mondo, spesso a causa di eventi storici o migrazioni. Quando le persone si spostano, portano con sé la loro fede, e questo fa sì che religioni diverse si trovino a convivere in posti nuovi. Per gli immigrati, la religione diventa spesso un modo importante per mantenere vive le proprie radici culturali.La religione come parte dell’identità
Capire il concetto di identità è fondamentale per comprendere i cambiamenti che avvengono nelle religioni. Nelle società di una volta, l’identità religiosa era qualcosa che si ereditava dalla famiglia e dalla comunità in cui si nasceva. Nelle società moderne, invece, le persone hanno più libertà di scegliere a quale fede aderire, o di non aderire a nessuna. L’identità religiosa diventa così qualcosa che l’individuo costruisce nel tempo, anche se i gruppi religiosi continuano a essere punti di riferimento importanti. Le religioni aiutano a costruire l’identità attraverso le loro credenze, le relazioni tra i fedeli, i riti che praticano e i significati che danno alla vita.Come l’identità religiosa prende forma nella società
Questa forte connessione tra religione e identità si vede in diversi fenomeni che riguardano intere comunità o nazioni. Un esempio sono i nazionalismi religiosi, dove la religione viene usata per definire e rafforzare l’identità di una nazione, a volte portando a conflitti. Anche il fondamentalismo, che è nato nel mondo cristiano ma si trova in molte religioni, è un tentativo di difendere un’identità di fede considerata pura contro le influenze della modernità. Chi aderisce al fondamentalismo spesso cerca di tornare a quelli che considera i principi originali e non contaminati della propria fede, e questo ha spesso conseguenze anche nella politica.Spiritualità individuali e il desiderio di autorealizzazione
Accanto a questi movimenti che coinvolgono gruppi numerosi, esistono anche percorsi spirituali più individuali. Le spiritualità alternative, come la New Age, sono un esempio di come l’individuo possa cercare la propria strada religiosa al di fuori delle chiese tradizionali. Queste spiritualità mettono al centro la crescita interiore e l’autorealizzazione. Spesso propongono una visione del mondo che vede tutto collegato e che a volte non prevede un dio personale o le strutture tipiche delle religioni organizzate.La fede nell’era digitale
Oggi, anche la Rete, cioè Internet, ha un grande impatto sul modo in cui si vive la religione. Da un lato, permette alle chiese e alle organizzazioni religiose di comunicare e diffondere i loro messaggi (questo viene chiamato “Religion online”). Dall’altro lato, crea spazi completamente nuovi dove le persone possono avere esperienze religiose che esistono principalmente nel mondo virtuale (questo è chiamato “Online Religion”). In questi spazi digitali, l’identità religiosa può essere più flessibile, e i legami tra le persone che condividono la stessa fede possono formarsi e mantenersi in modi nuovi.[/membership]Ma se l’identità religiosa è sempre più una “scelta” individuale, perché assistiamo a un’esplosione di nazionalismi religiosi e fondamentalismi che sembrano negare proprio questa libertà?
Il capitolo presenta un quadro interessante delle trasformazioni in atto, ma la coesistenza di percorsi spirituali individuali e movimenti collettivi rigidi come i fondamentalismi solleva una questione cruciale sulla reale portata della “scelta” identitaria nel mondo contemporaneo. Il capitolo non approfondisce sufficientemente le tensioni e le contraddizioni tra queste tendenze apparentemente opposte. Per esplorare questa complessità, è fondamentale addentrarsi negli studi sulla sociologia delle religioni, la scienza politica e la psicologia sociale, considerando il ruolo persistente delle strutture sociali, politiche ed economiche nella formazione dell’identità. Autori come José Casanova o Scott Thomas offrono spunti preziosi per comprendere il riemergere della religione nella sfera pubblica e le sue implicazioni identitarie.4. La religione nella società plurale: leggi, etica e dignità
La religione è una presenza complessa e importante nella società di oggi, anche dove sembra meno centrale. Il suo ruolo pubblico è cambiato e per capirlo servono nuovi modi di analizzare, anche usando l’economia e le scienze che studiano la mente umana. Questa presenza si scontra con le leggi dello Stato, soprattutto per le religioni monoteiste che hanno norme sacre basate sulla volontà divina. Questo crea una difficoltà per i credenti, che si trovano a dover gestire una specie di “doppia lealtà”. Ad esempio, le religioni monoteiste condannano chi si toglie la vita perché la considerano un dono di Dio, anche se alcune idee orientali lo accettano per chi ha raggiunto un alto livello spirituale. Anche l’idea di martirio rende difficile distinguere tra un sacrificio per fede e il togliersi la vita.Il Ruolo della Laicità Statale
Di fronte a queste situazioni, lo Stato laico si confronta con le richieste delle comunità religiose in molti aspetti della vita pubblica, come il lavoro, la scuola e la sanità. Si discute se la laicità debba significare una separazione netta tra Stato e religione, oppure un approccio più aperto che garantisca a tutti la libertà religiosa e permetta alle religioni di partecipare al dibattito pubblico, senza però che le loro regole diventino leggi per tutti.Etica, Sofferenza e Dignità Umana
Le religioni offrono modi diversi di vedere il dolore e la sofferenza, a volte come parte di un disegno divino. Aiutano anche a definire cosa è giusto e sbagliato, dando regole, modelli e un modo per valutare le azioni, anche se la morale religiosa è spesso legata alle idee sacre. I progressi della scienza, soprattutto nella bioetica, mettono in discussione idee tradizionali sulla vita e sulla morte. Il confronto tra bioetica religiosa e laica mostra che si cerca un’etica valida per tutti. L’idea di dignità umana è un valore fondamentale e riconosciuto anche dalle leggi. Questa idea viene sia dal mondo antico che dalla tradizione ebraico-cristiana (l’uomo fatto a immagine di Dio). Le religioni devono però affrontare la sfida di far convivere l’idea di dignità universale, valida per ogni persona, con regole che a volte nella storia hanno escluso qualcuno o sono state restrittive per certi gruppi. Per costruire un senso di comunità basato sul fatto che siamo tutti esseri umani, è importante un dialogo tra le diverse visioni religiose e quelle basate sull’umanesimo.Si afferma che servano ‘nuovi modi di analizzare’ la religione, citando economia e scienze cognitive. Ma in concreto, come aiutano queste discipline a capire il ruolo pubblico della religione, e perché i metodi tradizionali non sarebbero più sufficienti?
Il capitolo introduce l’idea che l’analisi della religione richieda nuovi strumenti da campi come l’economia e le scienze cognitive, ma non spiega in che modo specifico queste discipline possano illuminare il ruolo pubblico della religione né perché gli approcci più consolidati (sociologici, storici, filosofici) non siano più adeguati. Per comprendere meglio questa prospettiva, sarebbe utile esplorare il campo dell’economia della religione, che analizza la religione in termini di mercati, offerta e domanda (si veda ad esempio il lavoro di R. Stark), o la scienza cognitiva della religione, che studia le basi mentali delle credenze e pratiche religiose (si veda ad esempio il lavoro di P. Boyer). Approfondire questi ambiti permetterebbe di valutare la reale portata e l’utilità di questi “nuovi modi di analizzare” rispetto ai metodi più tradizionali.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]