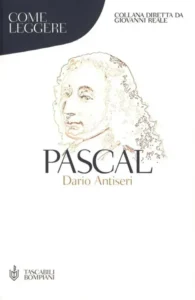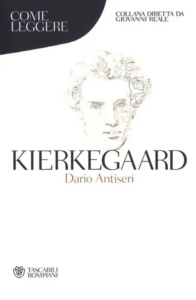1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Relativismo, nichilismo, individualismo. Fisiologia o patologia dell’Europa” di Dario Antiseri ti porta in un viaggio nel cuore dell’identità europea, esplorando se le sue caratteristiche fondamentali siano punti di forza o di debolezza. Il libro argomenta che il pluralismo, la tolleranza e la ragione critica, radicati nella cultura greca e nel messaggio cristiano che ha messo al centro la coscienza individuale, sono la vera forza dell’Europa. Viene analizzato come un certo tipo di relativismo, inteso come riconoscimento del pluralismo dei valori, e un nichilismo “sostenibile”, che accetta i limiti della ragione umana nel trovare sensi assoluti, siano in realtà presupposti per la tolleranza e riaprano lo spazio per il sacro e la fede. Un tema centrale è il contrasto tra individualismo, che vede la persona umana come l’unica realtà effettiva e difende la sua libertà e responsabilità, e il collettivismo, che tende a negare l’individuo e ha spesso supportato regimi oppressivi. Il libro sottolinea l’importanza di difendere la persona contro i miti collettivi, promuovendo la sussidiarietà e le associazioni volontarie. Viene anche esplorato il rapporto tra scienza e valori, mostrando come la scienza descriva i fatti ma non possa dirci come dobbiamo vivere, lasciando spazio alla scelta etica basata sulla coscienza e alla fede come opzione che va oltre la ragione. È un invito a riconoscere i limiti umani per accogliere il trascendente e a vedere nell’individualismo non egoismo, ma la difesa della dignità della persona.Riassunto Breve
L’identità europea si basa sul pluralismo di idee, fedi e morali, non su una tradizione unica. Questa diversità è una forza, radicata nella ragione critica greca e nel messaggio cristiano che introduce la coscienza individuale e desacralizza il potere politico, creando uno spazio per corpi intermedi e limitando lo Stato. L’idea di persona libera e responsabile con coscienza inviolabile è centrale. Il pluralismo etico e religioso è un dato di fatto; i sistemi etici sono diversi e non derivano logicamente dai fatti, ma si basano su scelte di coscienza. Affermare verità assolute in etica porta all’intolleranza; il relativismo, inteso come riconoscimento del pluralismo dei valori, è necessario per la democrazia e la tolleranza. Un nichilismo sostenibile è la consapevolezza che l’uomo non può costruire un senso assoluto per la vita o la storia; questo nichilismo è fonte di tolleranza e riapre lo spazio per il sacro e la domanda religiosa. Le filosofie che hanno cercato di divinizzare l’uomo hanno fallito, e il Novecento ha mostrato i limiti della ragione umana. La scienza non risponde alle domande fondamentali sul senso o sui valori; la filosofia pone la domanda ma non la risolve, rinviando a una risposta religiosa. La fede non si basa su prove razionali, ma è una decisione, un’opzione di libertà e speranza, non certezza razionale, il che favorisce la tolleranza tra le fedi. Esiste un contrasto tra visioni individualiste e collettiviste della società. L’individualismo considera l’individuo l’unica realtà effettiva, mentre il collettivismo attribuisce realtà sostanziale a entità come società o stato, negando o cancellando l’individuo. Le concezioni collettivistiche supportano spesso il potere politico oppressivo e totalitario, basato sulla presunzione di possedere verità assolute da imporre. Nelle teorie individualistiche, la persona umana è l’unica realtà effettiva; le collettività sono viste come mitologia deresponsabilizzante e fonte di oppressione. La collettività non è un soggetto autonomo; l’analisi sociale deve partire dalle azioni individuali (individualismo metodologico). Esistono solo individui che pensano, ragionano e agiscono. L’individualismo non è egoismo o atomismo; gli individui sono sociali fin dall’inizio, in relazione con altri individui. La libertà si fonda sulla difesa dell’autonomia e responsabilità della persona, protetta dal principio di sussidiarietà, che impedisce a un’entità superiore di sostituire l’iniziativa di individui o comunità minori. Una società libera promuove associazioni volontarie; la conoscenza utile è dispersa tra gli individui, non centralizzata nel governo. La scienza descrive i fatti (“è”) ma non può derivare i valori (“dovrebbe essere”); i valori si basano su scelte di coscienza individuali, implicando un pluralismo inevitabile. La possibilità della fede richiede l’eliminazione della pretesa umana di possedere verità assolute tramite la ragione; la consapevolezza dei limiti della ragione umana apre uno spazio per la fede. Un “pensiero debole” che riconosce l’incapacità umana di costruire sensi o valori assoluti è compatibile con la fede e critica l’abuso della ragione che nega la trascendenza.Riassunto Lungo
1. La Forza del Pluralismo e le Radici Europee
L’Europa è unica perché non ha una sola filosofia, una sola fede o una sola morale. Questa varietà non la rende debole, ma forte. La sua storia è un continuo incontro e confronto tra idee diverse, non un percorso unico e rigido. L’Europa si distingue per la sua capacità di usare la ragione critica, accettare il pluralismo e praticare la tolleranza. Proprio grazie alla ragione critica e alla tolleranza, la civiltà europea riesce a correggersi nel tempo.Le Radici della Cultura Europea
I valori che definiscono l’Europa hanno radici profonde nella storia. La cultura greca ha portato l’idea della ragione critica, la capacità di analizzare e mettere in discussione. Il messaggio cristiano ha aggiunto il valore fondamentale della coscienza individuale e l’idea che ogni persona è creata a immagine di Dio. Questo ha creato una tensione positiva con il potere politico, perché ha tolto al potere un carattere sacro e lo ha sottoposto al giudizio della coscienza di ciascuno. L’invito “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” ha posto un limite allo Stato e ha permesso la nascita di gruppi e associazioni libere. L’idea di una persona libera e responsabile, con una coscienza che nessuno può violare, è un pilastro dell’identità europea.La Natura dell’Etica e il Pluralismo dei Valori
Nella realtà, esistono molti modi diversi di vedere le cose in campo etico e religioso. I sistemi di valori sono vari e non si basano su un unico fondamento razionale che valga per tutti in modo definitivo. Le regole etiche più importanti non derivano in modo automatico dai fatti, ma sono proposte che si possono accettare o rifiutare in base alla propria coscienza. Questa impossibilità di derivare le norme etiche dalla logica è la base della libertà di coscienza. L’etica non è una scienza esatta; la scelta su cosa è giusto o sbagliato è inevitabile e dipende dalla coscienza di ognuno, non da dimostrazioni scientifiche. Fare una scelta etica responsabile significa anche considerare le conseguenze delle proprie azioni.Assolutismo Etico e Tolleranza
Affermare che esistano verità etiche assolute e immutabili per tutti porta facilmente all’intolleranza e a forme di governo autoritarie o totalitarie. Riconoscere il pluralismo dei valori, accettando che esistano diverse visioni del mondo (quello che a volte viene chiamato relativismo), è invece fondamentale per la democrazia e per la convivenza pacifica. Dal punto di vista di chi crede, solo Dio può essere considerato assoluto. Tutto ciò che riguarda gli esseri umani e la loro storia è per sua natura limitato e relativo al proprio tempo e contesto. Chi pretende di rendere assolute cose che sono umane, rischia di trasformare la propria fede in una forma di idolatria.Ma se ogni valore è relativo e scelto dalla coscienza individuale, su quale base “oggettiva” si afferma che il pluralismo e la tolleranza siano i pilastri irrinunciabili dell’Europa e della democrazia?
Il capitolo presenta una visione in cui i valori etici sono scelte individuali, non derivabili dalla ragione o dai fatti, e vede in questo relativismo la base della libertà e della tolleranza. Tuttavia, eleva contemporaneamente il pluralismo e la tolleranza a fondamenti essenziali della civiltà europea e della democrazia. Questo solleva un interrogativo: se ogni sistema di valori è relativo, su quale base si fonda l’affermazione della superiorità o necessità di questi specifici valori (pluralismo, tolleranza) rispetto ad altri? Approfondire il dibattito filosofico sulla natura dei valori, la possibilità di fondamenti etici non assoluti ma intersoggettivi, e le sfide del relativismo etico può aiutare a esplorare questa tensione. Utili per questo sono gli studi in metaetica e filosofia politica, e le opere di autori come Nietzsche, che ha esplorato la genealogia e la crisi dei valori, o filosofi che hanno cercato di dare un fondamento razionale o intersoggettivo ai principi politici in società plurali.2. Il Senso Umano tra Limiti della Ragione e Spazio del Sacro
Esiste un modo di vedere il nichilismo che è positivo e umano. Questo punto di vista considera il nichilismo come la semplice consapevolezza che l’uomo non può creare da solo un senso assoluto e definitivo per la vita o per la storia. Se inteso in questo modo, il nichilismo diventa una fonte di tolleranza. Le pretese umane di possedere verità e valori assoluti hanno infatti causato intolleranza e grandi sofferenze nel corso della storia. Dietro i regimi totalitari, ad esempio, ci sono sempre state persone convinte di avere la verità assoluta e valori superiori a tutti gli altri. Questa visione del nichilismo, riconoscendo i limiti delle costruzioni umane, riapre uno spazio per il sacro e per le domande sulla religione.I Limiti della Ragione Umana
Non è la scienza a negare la fede o a entrare in conflitto con essa. Sono state piuttosto alcune correnti filosofiche del Novecento a cercare di mettere l’uomo al posto di Dio e a voler eliminare il concetto di sacro. Pensiamo a movimenti come il materialismo, il positivismo, l’idealismo, il marxismo, la psicoanalisi o l’esistenzialismo ateo. Queste filosofie credevano che l’uomo potesse essere “dio per l’uomo”, ma il Novecento ha mostrato i loro fallimenti. Alla fine del secolo, è diventato chiaro che la ragione umana ha dei limiti importanti.Scienza, Filosofia e la Domanda di Senso
La scienza, con i suoi metodi, non può dare risposte alle domande più profonde e importanti per l’uomo. Non ci dice cosa dobbiamo fare nella vita, né cosa possiamo sperare. La filosofia, dal canto suo, ha il merito di porre la domanda sul senso dell’esistenza, ma non trova una risposta completa usando solo la ragione. Questa domanda fondamentale sembra rimandare a una risposta che va oltre la filosofia, verso la religione. L’uomo, in fondo, si trova in una posizione di “mendicante di senso”, sempre alla ricerca di un significato che non riesce a darsi da solo.La Fede: Una Scelta e una Speranza
Questa consapevolezza dei limiti umani nel costruire un senso assoluto, che deriva dal nichilismo positivo, riapre la possibilità della fede. La fede non si basa su prove razionali o dimostrazioni scientifiche che ne confermino la verità in modo universale. Non è il risultato di ragionamenti logici, ma è una decisione personale, una libera scelta. Cercare di fondare la fede su basi puramente razionali finirebbe per snaturarla. Ad esempio, la fede cristiana si basa sulla convinzione che Gesù Cristo sia Dio, una posizione che va contro ciò che la ragione da sola potrebbe suggerire. La fede implica speranza (“io spero che il mio Dio sia il vero Dio”), non una certezza razionale assoluta (“io so con la ragione che il mio Dio è il vero Dio”).Fede come Scelta e Tolleranza
Questo modo di intendere la fede come una scelta libera e una speranza offre il motivo più forte per essere tolleranti verso le altre fedi. Chi pretende di basare la fede solo su fondamenta razionali, come alcuni movimenti hanno tentato di fare, non ottiene risultati duraturi. La fede non ha bisogno di essere fondata sulla scienza o sulla filosofia. La religione continua a esistere nel mondo proprio perché c’è sempre quella grande e persistente domanda di senso a cui né la scienza né la filosofia riescono a dare risposte complete e definitive.Se la ragione e la filosofia mostrano i loro limiti nel fornire un senso assoluto, perché il capitolo sembra suggerire che l’unica alternativa plausibile sia la religione?
Il capitolo, pur riconoscendo i limiti della ragione e della filosofia nel dare risposte definitive al senso della vita, compie un salto logico significativo nel presentare la religione come l’unica o principale via per colmare questa lacuna. Non vengono esplorate a sufficienza altre possibili fonti di senso o risposte alla “domanda di senso” che non siano strettamente religiose, come ad esempio quelle proposte da correnti filosofiche non teiste, dall’arte, dalle relazioni umane o dall’impegno sociale. Per approfondire questa tematica e considerare prospettive alternative, potrebbe essere utile esplorare autori come Albert Camus o Jean-Paul Sartre per le visioni esistenzialiste sul senso in un mondo senza assoluti, o Viktor Frankl per l’approccio alla ricerca di significato attraverso l’esperienza e i valori.3. L’individuo contro l’ombra del collettivo
Esiste un contrasto profondo nel modo in cui si vede la società: da un lato c’è la visione individualista, dall’altro quella collettivista, chiamata anche olistica. L’individualismo parte dall’idea che l’unica realtà vera sia l’individuo. Nomi come “società”, “stato” o “partito” sono considerati solo modi per indicare gruppi di persone, le loro azioni e come interagiscono tra loro. Secondo questa visione, tutto ciò che accade nella società deriva dalle azioni, volute o meno, dei singoli individui.La visione collettivista
La visione opposta è il collettivismo. Qui si crede che i concetti collettivi abbiano una realtà propria, che esistano davvero. Entità come la società, la nazione o una classe sociale non dipendono dagli individui, ma anzi li influenzano e li modellano, stabilendo regole e valori. Per chi abbraccia il collettivismo, l’individuo non potrebbe esistere senza queste realtà più grandi; è visto quasi come una parte di un “Grande Essere” sociale, senza una sua esistenza indipendente.Libertà e responsabilità individuale
Questa differenza tra le due visioni non è solo una questione teorica, ma ha conseguenze molto concrete sulla libertà e sulla responsabilità di ognuno di noi. Soltanto nella prospettiva individualista c’è spazio per considerare la persona umana come autonoma, capace di scegliere liberamente e responsabile delle proprie azioni. Le idee collettivistiche, invece, tendono a sminuire o addirittura a negare completamente l’importanza e l’esistenza dell’individuo come entità separata.Pensatori collettivisti
Nella storia del pensiero, diversi studiosi hanno sostenuto visioni collettivistiche. Auguste Comte, ad esempio, vedeva l’Umanità come l’unica realtà importante, riducendo il singolo a una semplice idea astratta. Hegel pensava che gli individui fossero solo strumenti usati dalla storia del mondo per progredire, guidata da una logica superiore e inevitabile. Karl Marx credeva che fosse la posizione sociale a determinare il modo di pensare di una persona e che la storia seguisse leggi economiche fisse, vedendo gli individui quasi come figure senza volontà propria. Anche pensatori più recenti, come gli strutturalisti Louis Althusser, Michel Foucault e Claude Lévi-Strauss, hanno considerato gli individui come semplici risultati di strutture più grandi e impersonali, siano esse biologiche o economiche, arrivando a suggerire che l’idea stessa di “uomo” sia un’invenzione recente e temporanea.Collettivismo e potere politico
Queste visioni che mettono il collettivo al di sopra dell’individuo sono state spesso usate per giustificare forme estreme di potere politico, in particolare i regimi totalitari. Questi governi autoritari si appoggiano su un modo di agire che potremmo chiamare una “triplice giustificazione”: nascondono la verità dei fatti (intellettuale), ignorano i propri errori (pratica) e decidono cosa è giusto o sbagliato a proprio piacimento (morale). Questo permette loro di compiere azioni terribili e di negare i diritti fondamentali delle persone, attribuendo un potere illimitato a un gruppo dominante o a un’ideologia.Il pericolo della verità assoluta
Alla base di queste tragedie storiche, come i Lager nazisti e i Gulag stalinisti, c’è la convinzione arrogante di possedere una verità assoluta che deve essere imposta a tutti i costi. Questa “presunzione fatale” di sapere cosa è meglio per il collettivo, al punto da annullare l’individuo, è la radice delle sofferenze causate dai sistemi che negano il valore e la dignità della singola persona.Se i valori sono solo una questione di scelta individuale non derivabile dai fatti, come possiamo fondare una morale condivisa o persino un’idea di società “giusta”?
Il capitolo insiste giustamente sulla distinzione tra ciò che “è” (ambito della scienza) e ciò che “dovrebbe essere” (ambito dei valori), sottolineando che questi ultimi derivano dalla scelta individuale e non dai fatti. Tuttavia, questa netta separazione, pur filosoficamente fondata (si pensi a David Hume), lascia irrisolta la questione cruciale di come, in assenza di un fondamento oggettivo o razionale universalmente riconosciuto derivante dalla realtà, sia possibile costruire un tessuto etico condiviso o giustificare l’idea stessa di una società che sia non solo libera, ma anche equa o “giusta”. Per approfondire questa complessa relazione tra fatti, valori e la possibilità di norme condivise, è utile esplorare la meta-etica e la filosofia politica, confrontandosi con autori che hanno cercato di colmare o comprendere meglio questo divario, come Immanuel Kant, o quelli che hanno analizzato le basi della giustizia sociale, come John Rawls.7. Riconoscere i Limiti per Accogliere il Trascendente
Per avere fede, è necessario superare alcuni ostacoli. Il principale ostacolo è la pretesa umana di conoscere verità assolute e certe solo con la ragione. Questa ricerca di certezze terrene finisce per negare l’esistenza di un Assoluto che va oltre la nostra comprensione. Riconoscere che la ragione umana ha dei limiti apre invece la porta alla possibilità della fede.La ragione apre lo spazio alla fede
Immanuel Kant ha spiegato che a volte è necessario mettere da parte il sapere basato sulla ragione per fare spazio alla fede. Questa riflessione sui limiti della ragione è utile per contrastare idee che negano la spiritualità, come il materialismo e l’ateismo. Capire cosa non possiamo conoscere con la sola intelligenza ci rende più aperti a ciò che la ragione non può dimostrare. Questo non significa rinunciare a pensare, ma riconoscere che il pensiero ha un confine oltre il quale si estende la fede.Pensatori che hanno messo in luce i limiti umani
Molti pensatori, definiti “scettici cristiani”, hanno evidenziato la fragilità dell’intelletto umano. Montaigne vedeva la presunzione di sapere tutto come un grande errore e considerava la fede una conoscenza che viene da Dio, non dalla nostra ragione. Charron sosteneva che nulla è davvero certo e che l’unica vera certezza è la nostra ignoranza, vedendo questa consapevolezza come un modo per onorare la spiritualità. Pascal diceva che il punto più alto a cui può arrivare la ragione è riconoscere che ci sono cose che la superano; per lui, la fede è un dono di Dio che si sente nel cuore, non che si capisce con la mente.Voci dal passato recente sui confini della conoscenza
Anche in tempi più vicini a noi, diversi filosofi hanno riflettuto su questi temi. Nell’Ottocento, Søren Kierkegaard considerava la fede qualcosa che non si può capire del tutto e pensava che ammettere di non sapere tutto su Dio fosse una forma di saggezza. Nel secolo scorso, Ludwig Wittgenstein notava che la scienza non può risolvere i problemi fondamentali della vita; per lui, credere in Dio significa vedere che la vita ha un significato che va oltre i semplici fatti del mondo. Martin Heidegger credeva che solo una forza divina potesse salvarci e che il pensiero umano può solo prepararsi ad accogliere questa possibilità, riconoscendo i propri limiti. Friedrich A. von Hayek, pur occupandosi di economia e società, considerava fondamentale capire i limiti della ragione umana, una posizione che riteneva in linea con l’idea cristiana che l’uomo è fallibile.Un modo di pensare compatibile con la fede
Esiste un approccio chiamato “pensiero debole” che si accorda bene con la fede. Questo modo di pensare riconosce che gli esseri umani non possono costruire significati assoluti o dimostrare valori universali con la sola forza della ragione. Il pensiero debole non rifiuta la ragione, ma critica il suo uso eccessivo, specialmente quando la ragione nega l’esistenza di qualcosa che va oltre il mondo materiale o pretende di essere indispensabile per capire le verità spirituali rivelate.Un antico dibattito sulla forza della ragione
Un esempio storico di questo dibattito si trova nella discussione tra Pierre-Daniel Huet e Lodovico Antonio Muratori. Huet, in un suo scritto, sosteneva che l’uomo non può conoscere la verità con assoluta certezza usando solo la ragione e che questa consapevolezza della debolezza umana rende l’animo pronto ad accogliere la fede. Muratori, al contrario, difendeva la capacità dell’intelletto umano. La visione che vede la ragione come uno strumento che può aiutare ad aprirsi alla fede, piuttosto che uno strumento per dimostrarla o fondarla, appare molto importante in questa discussione.Davvero il riconoscimento dei limiti della ragione apre necessariamente la porta alla fede, o lascia piuttosto spalancato l’abisso dell’incertezza?
Il capitolo argomenta che ammettere i confini della ragione umana spiana la strada all’accoglienza del trascendente e della fede. Tuttavia, non è chiaro perché questa sia l’unica o la più probabile conseguenza. Il riconoscimento dell’incapacità della ragione di afferrare l’Assoluto potrebbe altrettanto facilmente condurre a posizioni scettiche, agnostiche o persino nichiliste, che non implicano l’adesione a una fede religiosa. Per esplorare questa lacuna, sarebbe utile confrontare le diverse risposte filosofiche alla crisi della ragione, studiando le correnti di pensiero che, pur partendo dai limiti della conoscenza, approdano a conclusioni diverse da quelle teistiche. Si potrebbero approfondire autori come David Hume per lo scetticismo, o esplorare le varie forme di esistenzialismo e post-strutturalismo che mettono in discussione le grandi narrazioni e le certezze assolute senza necessariamente ripiegare sulla fede tradizionale.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]