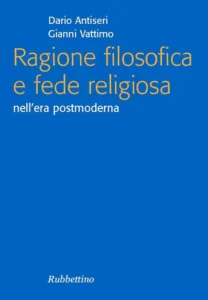1. Oltre l’essenza: etica e bioetica nell’epoca dell’evento e della carità
È necessario costruire un’etica e una bioetica che non si appoggino sulla metafisica. La metafisica viene messa da parte perché identifica la realtà con strutture fisse e immutabili, che si possono definire una volta per tutte e da cui deriverebbero regole eterne e autorità assolute. Invece, ispirandosi a pensatori come Heidegger, si considera la realtà come un “evento”, qualcosa che si manifesta in modi diversi nel corso del tempo e nelle varie culture, non come un’essenza stabile. La “morte di Dio”, come la intendeva Nietzsche, segna la fine delle autorità assolute e delle regole che non cambiano, portando a una situazione attuale dove esistono molti valori diversi, un vero e proprio “politeismo dei valori”.Un’etica basata sull’accordo e sul rispetto
Una visione che supera la metafisica non si fonda su una presunta “natura umana” fissa e immutabile, un concetto che può portare a discussioni complicate e potenzialmente pericolose. Propone invece un’etica che nasce dall’accordo e dal consenso tra persone diverse. La scelta etica non deriva da una verità assoluta, ma dalla “carità”, intesa come la capacità di guardare l’altro senza provare vergogna, rispettando pienamente la sua libertà. Questo rispetto per l’altro non nasce da una descrizione oggettiva di come è l’essere umano per natura, ma da valori che ci sono stati tramandati dalla tradizione.Il ruolo del “pensiero debole”
Questa posizione si collega al “pensiero debole”, che rifiuta l’idea di una ragione che può conoscere tutto e gli “assoluti terreni” (come il positivismo, il materialismo, lo stato etico) che non lasciano spazio alla fede. Il pensiero debole mette in risalto i limiti dell’essere umano, il fatto che il linguaggio e l’esistenza cambiano con la storia, e che la realtà è sempre il risultato di come la interpretiamo.La bioetica tra limiti e consenso
Quando si parla di bioetica, l’approccio post-metafisico non fornisce regole assolute, ma stabilisce dei limiti su ciò che non si deve fare e si basa sul rispetto della libertà dell’altro, intesa come rispetto per la sua “anima”. Nei casi difficili, come quando una persona non è in grado di capire e decidere, si fa riferimento ai “tutori naturali”, cioè le persone che di fatto sono vicine all’individuo e a cui lui stesso si sarebbe rivolto. L’idea di dover proteggere una presunta essenza naturale dell’uomo non regge; l’etica si basa sul consenso informato e sul rispetto reciproco della libertà, anche in temi delicati come l’eutanasia o il testamento biologico. La bioetica deve considerare non solo ciò che è tecnicamente realizzabile (koennen) o eticamente permesso da norme fisse (dürfen), ma anche ciò che è accettabile in base all’accordo comune (ammissibilità consensuale) nel contesto umano, permettendo così di guardare il prossimo senza vergogna.Come si può costruire un’etica solida e protettiva, specialmente in bioetica, basandosi solo sul consenso e sul rispetto della libertà, una volta abbandonata l’idea di una natura umana fissa o di verità assolute?
Il capitolo propone di superare la metafisica e fondare l’etica sull’accordo e sul rispetto reciproco, in un’epoca caratterizzata dal “politeismo dei valori”. Tuttavia, non chiarisce sufficientemente come il consenso possa da solo garantire la tutela dei soggetti più fragili, come i non in grado di decidere, o come si selezionino i “valori tramandati dalla tradizione” in assenza di un criterio oggettivo. Questo approccio rischia di non fornire un fondamento robusto per i diritti fondamentali o per la dignità umana al di là del mutevole accordo sociale. Per esplorare alternative o integrazioni a questa prospettiva, sarebbe utile approfondire le teorie etiche che cercano fondamenti non metafisici per i diritti umani e la giustizia, come quelle proposte da autori nel campo della filosofia politica contemporanea o dell’etica normativa.2. La debolezza della ragione: una vecchia idea ancora attuale
L’idea che la debolezza della ragione non sia un ostacolo alla fede, ma possa addirittura aprirle la strada, ha radici profonde. Il pensiero che rinuncia a certezze assolute nel mondo terreno può, paradossalmente, creare uno spazio per accogliere la fede. Questa visione, che vede nella ragione uno strumento con limiti intrinseci, si scontra con chi invece la considera una forza capace di raggiungere verità definitive. Un confronto storico che illustra bene questo contrasto è quello avvenuto nel Settecento tra Pierre-Daniel Huet e Lodovico Antonio Muratori.Il confronto tra Huet e Muratori
Pierre-Daniel Huet, nel suo scritto sulla debolezza dello spirito umano, sosteneva con forza che l’uomo non può raggiungere verità certe usando solo la ragione. Secondo Huet, non esiste una regola universale e sicura per distinguere il vero dal falso, poiché sia i sensi che l’intelletto umano sono fallibili. Le opinioni che formiamo sono al massimo probabili e dovrebbero sempre essere considerate con un certo grado di dubbio. Cercare di afferrare una verità chiara e immutabile con la sola forza della ragione è, per Huet, uno sforzo inutile. La consapevolezza di questa intrinseca debolezza della ragione ha per lui un duplice scopo: da un lato, aiuta a evitare l’errore e l’arroganza intellettuale; dall’altro, e questo è fondamentale, prepara l’animo a ricevere il dono della fede. Huet propone quindi una ragione che non pretende di fondare la fede, ma che si apre ad essa riconoscendo i propri limiti.Lodovico Antonio Muratori si schierava su posizioni opposte, difendendo con forza la capacità della ragione umana di raggiungere la verità. Nel 1745, pubblicò un testo in risposta a Huet, criticando aspramente coloro che, come i ‘pirronisti’, mettevano in dubbio l’esistenza di un criterio di verità o sminuivano il ruolo dei sensi e dell’intelletto. Per Muratori, era un errore sostenere che il dubbio potesse in qualche modo preparare l’animo umano ad accogliere la fede. Credeva fermamente nella solidità dell’intelletto e dei sensi come vie affidabili verso la conoscenza. La sua visione poneva la ragione come base solida, non come uno strumento limitato che lascia spazio all’incertezza.
Dall’idea antica alla filosofia di oggi
Guardando al panorama filosofico attuale, l’idea proposta da Huet risuona ancora oggi con sorprendente validità. Ci si interroga profondamente sulla possibilità di sostenere le pretese di trovare fondamenti certi e incrollabili che hanno caratterizzato gran parte della filosofia tradizionale. Il dibattito contemporaneo sembra convergere sulla constatazione che non esiste una singola fondazione ultima e definitiva per la conoscenza o per i valori. Questa “crisi dei fondamenti” investe l’idea stessa di verità, intesa come qualcosa di assoluto e raggiungibile in modo certo. Il pensiero, di conseguenza, non può più rivendicare una “forza” derivante da un accesso privilegiato a un presunto fondamento ultimo dell’essere. L’immagine stessa della razionalità subisce una trasformazione: deve accettare di essere uno strumento meno potente di quanto si credesse, privo di un unico e stabile punto di riferimento esterno.Il pensiero debole si definisce come la consapevolezza profonda che non esistono fondamenti ultimi e certi su cui basare in modo definitivo la conoscenza o i valori. Filosofi come Nietzsche hanno contribuito a questa visione, mostrando come le grandi strutture portanti della metafisica tradizionale fossero spesso forme di rassicurazione costruite in epoche passate. Concetti metafisici considerati pilastri, come l’idea di una totalità del mondo o di un soggetto umano perfettamente centrato, si rivelano oggi strumenti di controllo del reale non più indispensabili. Anche in ambito teologico, figure come Karl Rahner e Joseph Ratzinger hanno criticato il tentativo, tipico della filosofia e teologia neoscolastica, di fondare la fede su una ragione considerata completamente autonoma, giudicando tale tentativo come non riuscito.
Se la ragione è debole e non può raggiungere certezze, come si giustifica il salto logico che la porta a “preparare l’animo a ricevere il dono della fede”?
Il capitolo afferma che la consapevolezza dei limiti della ragione prepara alla fede, ma non chiarisce il meccanismo o la necessità di questo passaggio. Non è evidente come il riconoscimento della fallibilità razionale conduca specificamente all’accoglienza di una fede religiosa, piuttosto che a un agnosticismo o a un diverso tipo di scetticismo. Per approfondire questo punto critico, sarebbe utile esplorare la filosofia della religione, in particolare autori che hanno trattato il rapporto tra ragione, dubbio e atto di fede, come Pascal o Kierkegaard. È inoltre fondamentale considerare il contesto teologico in cui l’idea di “dono della fede” si inserisce.3. L’Essere come Evento Linguistico
La fine di una visione stabile della realtà, spesso chiamata “morte di Dio”, significa che non possiamo più affermare verità assolute. Questo accade perché non possiamo conoscere la realtà direttamente, al di fuori di come la pensiamo e la esprimiamo con le parole. L’idea di raggiungere una verità certa e definitiva sulla realtà svanisce. Vivere significa essere in relazione con il mondo, e questo rapporto esiste grazie al linguaggio, che lo modella. Le nostre categorie di pensiero non sono strutture fisse per sempre, ma modi di organizzare il linguaggio che cambiano nel tempo. Sono l’unico modo in cui possiamo capire e accedere alle cose.Il Ruolo del Linguaggio e la Storia
La filosofia che studia l’interpretazione, chiamata ermeneutica, ci mostra che i linguaggi cambiano profondamente nella storia. Non nascono da una base unica e immutabile, ma sono legati tra loro da somiglianze, come una grande famiglia, e si trasmettono di generazione in generazione. Ciò che resta costante in questo passaggio è proprio il fatto che le cose vengono tramandate, che c’è una continua connessione tra le epoche, non un elemento che resta sempre uguale a sé stesso. Le cose diventano comprensibili e reali per noi solo all’interno di modi di parlare e pensare che appartengono a un certo periodo storico.Pensare è Interpretare
Questa visione ci porta a capire il pensiero in un modo diverso: pensare significa interpretare. Non si tratta più di acquisire una conoscenza scientifica certa e immutabile, come si intendeva una volta. Di conseguenza, l’idea stessa di “essere” diventa meno rigida, e il concetto di verità non è più così chiaro e immediato. La verità non è qualcosa che si vede all’improvviso, ma il risultato di un processo di verifica che avviene seguendo regole e procedure già stabilite all’interno di un certo linguaggio o contesto.L’Essere come Evento
Vivere, quindi, significa trovarsi all’interno di questi modi di pensare e parlare che caratterizzano un’epoca. Pensare non vuol dire “andare a prendere” le cose direttamente, ma piuttosto ripercorrere e capire come si è formata quella specifica apertura storica e linguistica che ci permette di accedere alle cose. Questo ripercorrere è come un continuo ricordare, un rimando costante. Questo modo di vedere le cose propone un’idea di “essere” meno forte, che ci ricorda che l’essere è fondamentalmente un tramandare. L’essere si manifesta solo come un evento, come l’accadere di questi modi di pensare e parlare storici, dentro i quali le cose diventano accessibili per noi. L’essere è proprio questo accadere e il suo essere trasmesso nel tempo.Se la dottrina cristiana è una “verità che proviene direttamente da Dio”, come si concilia l’accettazione selettiva con l’idea stessa di rivelazione?
Il capitolo presenta un approccio alla fede che, pur riavvicinandosi alla tradizione cattolica, mantiene un filtro critico, etichettando come “superstizioni” gli elementi non compatibili con una “mentalità moderna”. Questo solleva un punto cruciale: se la rivelazione è intesa come una verità data da Dio, la sua accettazione parziale basata su criteri umani non rischia di svuotare il concetto stesso di rivelazione, trasformandola in una costruzione o selezione personale piuttosto che in un accoglimento di ciò che è dato? Per esplorare a fondo questa tensione, è utile confrontarsi con autori che hanno riflettuto sulla natura della rivelazione e sul rapporto tra fede e ragione, come Kierkegaard, Thomas Aquinas, e lo stesso Vattimo per comprendere i suoi criteri di selezione. Approfondire la teologia fondamentale e l’ermeneutica può offrire strumenti per analizzare i diversi modi di intendere e interpretare i testi sacri e la dottrina.7. La Fede Incontra il Tempo Presente
Kierkegaard criticava chi adattava il cristianesimo alla filosofia del suo tempo, come faceva Hegel. Vedeva questo come un tentativo di compiacere l’epoca presente invece di rimanere fedeli alla verità eterna. Per lui, il cristianesimo è una verità che salva le persone, non è semplicemente una questione culturale da modellare secondo le mode del momento. Questa distinzione fondamentale tra fede come salvezza e fede come fenomeno culturale è cruciale. Sottolinea che la verità della fede non dipende dalle mode o dalle filosofie del momento, ma ha un valore che trascende il tempo.L’adattamento della fede nella modernità
Anche oggi c’è chi cerca di adattare il cristianesimo alla cultura attuale, come fa Vattimo. Egli propone di ripensare i contenuti della fede in termini moderni per renderli più accettabili nel mondo contemporaneo. Parla di un “Dio amichevole” e sceglie di riavvicinarsi alla Chiesa, pur volendo mantenere i propri standard intellettuali e morali. Questo approccio fa sorgere una domanda importante: il cristianesimo è davvero così semplice e accomodante da non richiedere alcun sacrificio personale? La visione di Vattimo include anche una critica verso la Chiesa ufficiale e il Papa, sostenendo che il Vangelo debba essere interpretato principalmente attraverso la lente della carità, liberandolo da quelle che lui considera semplici superstizioni.Il concetto di peccato e le sue interpretazioni
Un altro punto cruciale di discussione riguarda il concetto di peccato. Vattimo tende a vederlo in un senso quasi esclamativo, come un semplice rimpianto per un’occasione mancata o la consapevolezza della finitezza delle cose. Arriva a sostenere che Gesù stesso riveli la nullità del peccato. Al contrario, una visione diversa considera il peccato una realtà molto concreta e seria nella storia dell’humanità, qualcosa che persiste e richiede un’espiazione. Pensatori come René Girard osservano che presentare il cristianesimo in un modo così “facile”, quasi edonistico, rischia di ignorare la vera difficoltà e l’impegno richiesti dai comandamenti e dalla vita di fede. Si pone inoltre la questione se sia possibile vivere pienamente il cristianesimo senza la Chiesa, che storicamente trasmette gli insegnamenti e offre la possibilità della confessione dei peccati.I fondamenti dei valori e il rapporto tra fede e ragione
Quando si parla della fondazione dei valori, c’è un accordo diffuso sul fatto che non esista una base razionale certa per essi, un concetto noto come la legge di Hume. I valori sembrano piuttosto derivare da scelte profonde di coscienza, dalla libertà e dalla responsabilità individuale, e soprattutto dalla storia, in particolare quella europea. Ci si può chiedere se la civiltà europea, con i suoi tratti distintivi come la sacralità della vita umana e la dignità della persona, sarebbe potuta nascere e svilupparsi senza il messaggio fondamentale del cristianesimo, come suggerito da pensatori come Thomas S. Eliot. Questo porta a un’ulteriore riflessione: per chi crede, il bene e il male vengono principalmente dal Vangelo o dalla ragione? E se dalla ragione, di quale ragione si parla? Esiste il timore che per molti credenti oggi la fede possa diventare quasi secondaria rispetto a fondamenti razionali esterni. Pascal, a suo tempo, sosteneva con forza che senza la fede, l’uomo non può veramente conoscere il bene autentico o la giustizia, poiché la sola ragione umana, lasciata a sé stessa, non è sufficiente per raggiungere questa conoscenza profonda.Affermare la “nullità del peccato” non svuota di significato concetti centrali del cristianesimo, come l’espiazione e la redenzione, su cui il capitolo stesso sembra fondare la “verità che salva”?
Questa interpretazione del peccato, presentata nel capitolo, solleva un’obiezione logica interna: se il peccato è ridotto a un mero “rimpianto” o “consapevolezza della finitezza”, come può il cristianesimo essere la “verità che salva”, che richiede “sacrificio personale” e offre “espiazione”, come altre parti del capitolo suggeriscono? Per comprendere meglio questa tensione e le diverse interpretazioni del peccato nel pensiero cristiano e non solo, sarebbe utile approfondire la teologia sistematica, la filosofia della religione e la storia delle idee. Autori come Agostino, Lutero, Barth o anche pensatori contemporanei che si confrontano con il problema del male e della colpa possono offrire prospettive cruciali.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]