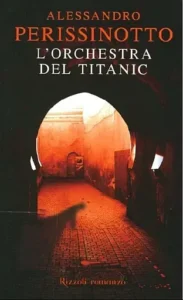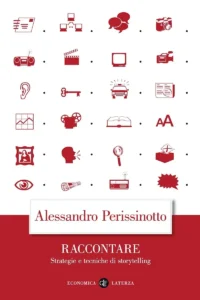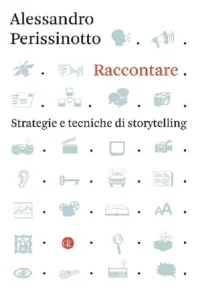1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Raccontare. Strategie e tecniche di storytelling” di Alessandro Perissinotto ti porta in un viaggio incredibile nel mondo della narrazione, partendo dalla sua definizione base e dalla sua evoluzione, mostrando come una storia non sia solo un racconto, ma un modo potentissimo di organizzare il pensiero e costruire la realtà che ci circonda. Il libro esplora le tecniche narrative che rendono una storia efficace, dalla struttura del racconto con fabula e intreccio, fino ai ruoli dei personaggi e all’uso degli “effetti di realtà” che ci fanno credere a quello che leggiamo o ascoltiamo, anche nella non-fiction. Non si ferma alla teoria, ma ti fa vedere dove e come lo storytelling viene usato oggi: nelle organizzazioni per creare identità e fiducia, nell’urban storytelling per dare nuova vita alle città, nel teatro di narrazione che usa la parola per raccontare storie vere e farci riflettere, e persino nella medicina narrativa per capire e curare meglio le persone. Scoprirai anche come raccontare il sé, attraverso l’autobiografia o i racconti di vita, sia fondamentale per la memoria individuale e collettiva, e come le storie vere, dalla cronaca nera alla ricerca sociale, abbiano una forza unica. È un libro che ti fa capire quanto la narrazione sia ovunque, uno strumento essenziale per comprendere noi stessi e il mondo, capace di coinvolgere emotivamente e plasmare la nostra percezione, anche se, come nel caso della para-fiction, c’è sempre il rischio della disinformazione.Riassunto Breve
Storytelling è l’atto di narrare, un concetto ampio che include diverse forme narrative e si è evoluto nel tempo, diventando un termine generale che copre molti fenomeni legati alla narrazione, anche se a volte si confonde con l’inganno. Una storia vera ha bisogno di personaggi che agiscono per superare ostacoli e raggiungere obiettivi; altrimenti, è solo un resoconto. Esistono diversi tipi, come fiction, non-fiction e para-fiction, quest’ultima rischiosa per la disinformazione. La forza della narrazione sta nel coinvolgere le emozioni, rendere concrete le idee astratte, aiutare a ricordare e usare un linguaggio universale. Si è espressa con parole, immagini, musica, e l’era digitale ha reso più facile creare e diffondere storie, aumentando però anche il rischio di para-fiction. La narrazione efficace si basa su tecniche precise studiate dalla narratologia. Ci sono regole comuni a tutte le storie. Le unità base sono i motivi. Le storie si organizzano con la fabula, l’ordine cronologico degli eventi, e l’intreccio, l’ordine in cui vengono presentati, che può cambiare la fabula per rendere la storia più interessante. Ogni storia è spinta dal desiderio e ha ruoli come Soggetto e Opponente. La figurativizzazione aiuta a mostrare invece di raccontare. Il “contratto di veridizione” e gli “effetti di realtà” rendono una storia credibile. La narrazione non è superficiale, ma fondamentale per il pensiero umano e l’organizzazione sociale. Strutture mentali come frame e script organizzano la conoscenza. Le storie sono nella memoria, sia personale che collettiva, e plasmano l’identità. Condividere storie aiuta l’empatia. Le organizzazioni usano la narrazione per definire la loro identità, umanizzarsi, creare fiducia e condividere conoscenze. L’urban storytelling aiuta a riqualificare territori e valorizzare la cultura, trasformando i luoghi in testi da raccontare. Anche la fiction distopica serve a far riflettere sul futuro. Le storie vere, come la cronaca nera, hanno una lunga storia nella letteratura e in TV, usando tecniche narrative per coinvolgere il pubblico, anche se a volte spettacolarizzano troppo. Il teatro di narrazione in Italia usa la parola e il corpo per raccontare la realtà, stimolare la riflessione e creare un legame con chi ascolta. Le narrazioni non-fiction includono il racconto del Sé. L’autobiografia è un bisogno umano di raccontarsi, trasforma i ricordi in una storia strutturata, ha valore di testimonianza ed è terapeutica. La medicina narrativa mette al centro la storia della malattia raccontata dal paziente per capire meglio e curare in modo personalizzato. I racconti di vita sono usati nella ricerca sociale per capire i fenomeni sociali attraverso le storie personali.Riassunto Lungo
1. L’Arte Narrativa: Definizione, Evoluzione e Impatto
Lo storytelling è l’atto di raccontare storie. Questa attività comprende diverse forme narrative, da quelle più semplici a quelle più complesse. La parola “storytelling” è cambiata nel tempo, diventando un termine generico per molti fenomeni legati al narrare. A volte, però, il termine è usato in modo eccessivo e impreciso, creando confusione con l’inganno.Che cosa rende una storia una narrazione
Una storia può essere definita una narrazione quando presenta personaggi che agiscono con uno scopo preciso: superare degli ostacoli per raggiungere un obiettivo. Se mancano questi elementi, non si tratta di narrazione, ma semplicemente di un resoconto di fatti.Le diverse forme di storytelling
Esistono diverse categorie di storytelling, che possono essere classificate in tre tipi principali:- Fiction: storie completamente inventate.
- Non-fiction: storie basate su fatti reali e verificabili.
- Para-fiction: storie che mescolano elementi reali e inventati, spesso con l’intento di ingannare o manipolare. Questa forma di storytelling è pericolosa perché può diffondere disinformazione.
La forza emotiva dello storytelling
Lo storytelling è efficace perché coinvolge le emozioni delle persone, diversamente dall’informazione basata sui dati che si concentra sulla ragione. Le storie rendono comprensibili concetti difficili e astratti, aiutano a ricordare le informazioni e usano un linguaggio universale, capito da tutti.Storytelling e nuovi media
Nel corso del tempo, lo storytelling si è espresso in molti modi diversi: con le parole, con le immagini e con la musica. Con l’arrivo del digitale, le possibilità di narrazione sono aumentate ancora di più. Oggi, grazie alla tecnologia accessibile a molte persone, è più facile creare e diffondere storie. Questa grande diffusione di storie ha anche un lato negativo, perché può aumentare la circolazione di storie inventate e false. Allo stesso tempo, però, offre a tante persone la possibilità di esprimersi e condividere le proprie esperienze, rendendo lo storytelling uno strumento molto potente e presente nella società di oggi.Definire la para-fiction unicamente come strumento di inganno non è riduttivo?
Il capitolo presenta una definizione di para-fiction che la identifica principalmente con la volontà di ingannare, tralasciando altre possibili interpretazioni e applicazioni di questa forma narrativa. Per ampliare la comprensione di questo concetto, sarebbe utile esplorare le diverse sfumature della narrazione ibrida, e autori come Umberto Eco, che ha esplorato i confini tra realtà e finzione, potrebbero offrire spunti interessanti.2. La Narrazione: Dalla Struttura del Racconto alla Costruzione della Realtà
L’importanza della narratologia
Raccontare storie in modo efficace richiede delle tecniche precise, sia che si tratti di storie inventate oppure di fatti reali. La narratologia studia proprio queste tecniche. L’obiettivo è capire come funzionano i racconti, senza concentrarsi sul contenuto specifico della storia. Secondo lo strutturalismo, tutte le narrazioni seguono delle regole comuni. Questo significa che le tecniche narrative possono essere usate e riadattate in diverse situazioni. I “motivi” sono come dei mattoncini di base delle storie. Unendo questi piccoli elementi narrativi, si creano storie più grandi e complesse, che spesso ritroviamo in racconti diversi.Fabula e intreccio: l’ordine degli eventi
Le storie prendono forma attraverso due concetti chiave: la “fabula” e l'”intreccio”. La fabula è laSuccessione degli eventi in ordine cronologico, come accadono realmente nel tempo. L’intreccio, invece, è l’ordine in cui questi eventi vengono presentati nel racconto. Chi racconta la storia spesso cambia l’ordine cronologico degli eventi (cioè modifica la fabula) per rendere la narrazione più interessante, più facile da capire o per ottenere un effetto sorpresa. Questo cambiamento dell’ordine degli eventi rende la narrazione più efficace e coinvolgente per chi legge o ascolta.I ruoli e gli elementi fondamentali della narrazione
Ogni storia nasce da un desiderio e si sviluppa attraverso dei ruoli narrativi ben precisi. Tra questi ruoli troviamo: il Soggetto (chi compie l’azione), l’Opponente (chi ostacola il Soggetto) e l’Oggetto del desiderio (ciò che il Soggetto vuole ottenere). Questi ruoli interagiscono tra loro all’interno di “programmi narrativi”, che hanno diverse fasi: l’inizio, lo sviluppo e la fine della storia. Per rendere più concrete le idee astratte, si usa la “figurativizzazione”, che preferisce “mostrare” le cose attraverso immagini e scene, invece di limitarsi a “raccontare”. Infine, per rendere credibile una storia, è fondamentale il “contratto di veridizione”. Questo contratto si basa sull’uso di “effetti di realtà”, ovvero dettagli e particolari che fanno sembrare la storia vera, sia quando si racconta qualcosa di inventato, sia quando si raccontano fatti realmente accaduti.La narrazione come strumento di pensiero e sociale
Raccontare storie non è solo un passatempo, ma è un modo fondamentale di pensare e di organizzare la società. I “frame” e gli “script” sono come delle strutture narrative nella nostra mente, che ci aiutano a organizzare le informazioni che conosciamo. Queste strutture mentali ci rendono più facile capire le cose e prendere decisioni. Le storie sono conservate nella nostra memoria, sia in quella “episodica” (i ricordi personali) sia in quella “semantica” (le conoscenze generali). In questo modo, le narrazioni influenzano la nostra memoria individuale e la storia che raccontiamo di noi stessi (memoria autobiografica). Quando condividiamo storie con gli altri, grazie ai “neuroni specchio” si crea empatia e si influenzano i comportamenti reciproci. La “memoria collettiva”, cioè l’insieme dei ricordi condivisi da un gruppo di persone, si costruisce proprio attraverso le narrazioni comuni. Questa memoria collettiva plasma la realtà sociale e l’identità del gruppo. Le “memorie flashbulb”, ovvero i ricordi molto vividi legati a eventi importanti, dimostrano come la memoria personale e quella collettiva siano collegate tra loro. Questi ricordi evidenziano quanto le narrazioni abbiano un impatto profondo sulla nostra vita personale e sulla società in cui viviamo.Ma se ogni narrazione segue regole comuni, come spiega il capitolo l’originalità e la creatività individuale nelle storie?
Il capitolo descrive le tecniche narrative come strumenti universali, quasi meccanici. Tuttavia, questa visione rischia di trascurare l’aspetto più imprevedibile e personale della narrazione: la creatività individuale. Per comprendere meglio come l’originalità emerge all’interno di strutture narrative, sarebbe utile esplorare le teorie di autori come Italo Calvino, che ha indagato le potenzialità combinatorie e generative della letteratura, oppure approfondire gli studi sulla retorica e sulla stilistica, che si concentrano sulle scelte espressive uniche di ogni narratore.3. Narrare per Organizzare e Valorizzare
L’importanza della narrazione per le organizzazioni
Le organizzazioni, di qualsiasi tipo, sentono il bisogno di raccontare la propria storia. Questo serve a definire chi sono, sia per chi lavora dentro l’organizzazione, sia per chi la guarda da fuori. Un tempo, i negozi usavano insegne semplici per raccontare la loro attività. Oggi, le grandi aziende hanno bisogno di raccontare storie più complesse per far capire la loro realtà, che è fatta di molte parti diverse. Raccontare storie è quindi fondamentale per dare un volto umano all’organizzazione. Così, si possono vedere le persone che lavorano dietro le quinte, si crea più empatia e si rafforza il gruppo.I vantaggi interni ed esterni dello storytelling
Raccontare storie all’esterno, anche quelle parti meno visibili di un’azienda, come gli uffici amministrativi, aiuta a costruire fiducia e dimostra che l’azienda si assume le proprie responsabilità. All’interno, le storie sono più efficaci dei semplici organigrammi. Le storie aiutano i diversi settori a conoscersi meglio tra loro e a condividereKnow-how pratico, quello che si impara facendo, come dimostra la storia del cloruro d’ammonio in fabbrica. Le storie si ricordano facilmente e toccano le nostre motivazioni più profonde, sia quelle logiche che quelle emotive. Sono le storie che ci guidano all’azione, ci fanno capire quali sono gli ostacoli e chi ci può aiutare.Lo storytelling urbano per riqualificare i territori
Raccontare storie legate alle città è un modo efficace per migliorare i territori e valorizzare la cultura locale. Città come Detroit e Matera hanno usato le narrazioni per cambiare un’immagine negativa e costruirsi una nuova identità. In questo modo, hanno coinvolto sia gli abitanti che i turisti nel creare una storia comune del luogo. Il paesaggio stesso diventa un libro aperto, pieno di storie e ricordi da scoprire e raccontare.La narrazione per immaginare il futuro
Anche le storie di fantascienza che immaginano futuri negativi hanno un ruolo importante. Queste storie ci fanno riflettere e ci spingono a fare scelte giuste nel presente, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente. La narrazione è quindi uno strumento fondamentale per organizzare le idee, dare valore alle cose e costruire il futuro delle comunità e dei territori.Ma se i programmi “true crime” spettacolarizzano il dolore, si può davvero parlare di “spazio alle vittime”, o non si tratta piuttosto di un’ulteriore mercificazione della tragedia?
Il capitolo sembra suggerire che i programmi “true crime” offrano un contributo positivo dando voce alle vittime. Tuttavia, è fondamentale interrogarsi sulla natura intrinseca di questi programmi, che trasformano eventi tragici in intrattenimento. Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile approfondire le dinamiche della spettacolarizzazione mediatica e le implicazioni etiche della rappresentazione del dolore altrui. Autori come Guy Debord, con la sua analisi sulla società dello spettacolo, o studiosi di etica dei media, possono offrire strumenti concettuali utili per decostruire criticamente il fenomeno dei “true crime” e valutare se la pretesa di dare “spazio alle vittime” non sia in realtà una strategia narrativa per aumentare l’audience, piuttosto che un reale intento di giustizia o riparazione.5. Narrare il Sé, Curare, Comprendere
Le narrazioni non-fiction presentano dei limiti naturali, perché raccontano solo una parte della realtà. Anche se abbiamo già definito i confini delle storie non-fiction, ci sono degli aspetti vicini che meritano attenzione. Questi aspetti riguardano il racconto di sé stessi e si esprimono in diversi modi narrativi.L’autobiografia: raccontare la propria vita
Tutti sentono il bisogno di raccontare la propria storia e di essere raccontati. L’autobiografia è più di un semplice insieme di ricordi messi in ordine. Infatti, trasforma i ricordi personali in un racconto strutturato, seguendo regole precise di linguaggio e di stile. Questo significa che gli eventi vengono riorganizzati in modo logico, a volte anche modificati per rendere la storia più coerente. Scrivere la propria autobiografia non è solo per personaggi famosi. Oggi, molte persone comuni sentono il bisogno di lasciare una testimonianza di sé attraverso la scrittura autobiografica. Questo è diventato più facile grazie alle nuove tecnologie e alle piccole case editrici. Questi racconti autobiografici sono importanti non solo per la loro bellezza, ma anche come documenti storici e testimonianze. Offrono uno sguardo sulla società dal punto di vista delle persone comuni. Raccontare la propria storia aiuta anche a stare meglio, perché permette di ripensare al passato e di affrontare le proprie esperienze con più distacco.La medicina narrativa: curare attraverso le storie
La medicina narrativa è un modo nuovo di affrontare la cura delle persone. Riconosce che è fondamentale capire come il paziente vive la malattia. A differenza della medicina tradizionale, che spesso non considera il punto di vista del paziente, la medicina narrativa mette al centro la storia della malattia raccontata dal paziente stesso, insieme al medico e al contesto sociale. Le storie di malattia diventano strumenti utili per capire meglio l’esperienza del paziente e per adattare la cura alle sue esigenze specifiche. Inoltre, raccontare la propria storia può avere un effetto positivo sulla terapia, soprattutto per malattie che rendono difficile la comunicazione. Condividere storie di malattia crea uno spazio comune dove i pazienti si sentono capiti e possono dare un nuovo significato alla propria esperienza.I racconti di vita: capire la società attraverso le storie personali
I racconti di vita sono strumenti utili per la ricerca sociale. Invece di usare solo dati statistici, i metodi narrativi qualitativi valorizzano le storie personali per capire meglio i fenomeni sociali. L’intervista narrativa, seguendo regole precise, permette di raccogliere racconti di vita utili per la ricerca sulla società e sulla cultura. Questi racconti, una volta raccolti e organizzati, offrono una visione ricca e complessa della realtà sociale. Mostrano i legami e le differenze tra persone e gruppi sociali. Progetti come “Storie migranti” e “Valigia blu” dimostrano come le storie personali possono far luce su temi sociali importanti come l’immigrazione e l’accoglienza.Ma se ogni narrazione è parziale e soggettiva, come possiamo fidarci ciecamente di autobiografie, storie di malattia e racconti di vita per comprendere veramente noi stessi, curare e capire la società, senza cadere in pericolose semplificazioni?
Il capitolo presenta le narrazioni del sé come strumenti potenti per la comprensione e la cura, ma manca di affrontare criticamente i limiti intrinseci di ogni narrazione. Se ogni racconto è inevitabilmente filtrato dalla soggettività e dalla parzialità del narratore, come possiamo essere certi che autobiografie, storie di malattia e racconti di vita offrano una visione autentica e non distorta della realtà? Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile esplorare le teorie sulla narrazione e la soggettività di autori come Paul Ricoeur, che pur riconoscendo il valore ermeneutico del racconto, ne sottolinea anche le ambiguità e le possibili distorsioni. Approfondire la filosofia della conoscenza e l’epistemologia delle scienze sociali potrebbe fornire strumenti concettuali per valutare criticamente la validità e i limiti delle narrazioni come strumenti di conoscenza e cura.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]