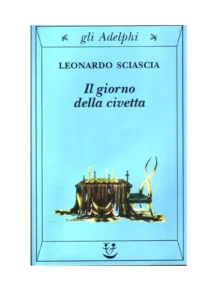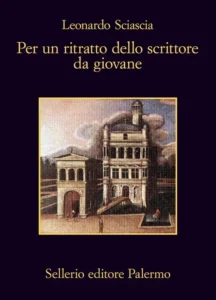Contenuti del libro
Informazioni
“Questo non è un racconto. Scritti per il cinema e sul cinema” di Leonardo Sciascia è un viaggio affascinante che parte dalla cruda realtà della Sicilia, esplorando temi come la mafia, la violenza, il peso del silenzio e la vendetta, con storie ambientate a Palermo o nei piccoli paesi, dove la legge d’onore si scontra con la giustizia. Ma il libro non si ferma qui: Sciascia usa il cinema come lente per analizzare la società e la cultura, guardando al divismo di Hollywood, ai miti americani, e criticando gli adattamenti cinematografici di opere letterarie come “Il Gattopardo” o “Il bell’Antonio” che spesso tradiscono lo spirito originale. Affronta la censura, la costruzione dei miti (anche su figure controverse come il bandito Giuliano), la teoria del comico e riflette sul rapporto tra arte, memoria e realtà, arrivando a una critica pungente delle istituzioni italiane, viste come fragili e basate sulla menzogna. È un testo che mescola analisi cinematografica e riflessione civile, mostrandoci come il cinema e la scrittura possano svelare le verità nascoste dietro le apparenze.Riassunto Breve
La violenza in Sicilia si manifesta con omicidi legati a interessi economici e sospetti di tradimento. Le vittime cadono in vari luoghi. Testimonianze in tribunale mostrano come la paura e il desiderio di proteggere i familiari portino al silenzio, anche quando i responsabili sono noti. Le pressioni sociali e le minacce impediscono di denunciare, spingendo a volte le vittime o i loro parenti a cercare giustizia o vendetta in modi diversi, come una madre che decide di parlare dopo la morte del figlio, o una ragazza testimone di un omicidio che viene allontanata e poi decide di raccontare tutto. Questo silenzio forzato e la difficoltà di ottenere giustizia legale sono temi centrali. Il cinema affronta la realtà e crea miti. L’erotismo nel cinema è soggetto a censura, mostrando un contrasto culturale. Il regista è considerato l’autore principale di un film, dando coerenza all’opera. L’adattamento cinematografico di opere letterarie è difficile; spesso i film non riescono a catturare l’essenza dei libri, alterando personaggi o contesti, come accade con *Il Gattopardo* o *Il bell’Antonio*. I miti americani nel cinema cambiano, passando da figure come Gary Cooper, simbolo della frontiera, a Marilyn Monroe, che rappresenta le fragilità della metropoli. Il divismo, nato con figure come Rodolfo Valentino, mostra il potere delle masse di creare miti e l’impatto economico e sociale dello star system. Figure come Erich von Stroheim diventano simboli nostalgici di mondi perduti. Anche figure storiche come il bandito Giuliano vengono mitizzate nel cinema, spesso in modo romantico e lontano dalla realtà storica, che lo vede manovrato da poteri occulti. La verità storica può essere falsificata dal mito. L’arte interagisce con la realtà e la memoria. Il cinema muto presenta figure comiche diverse, come Charlot, la cui comicità è vista come nobile e fraterna. Eventi reali possono apparire simili a finzioni. La memoria, anche quella fotografica, è instabile e può essere deformata, come esplorato in un film su Pirandello. Esiste una comicità che non si basa sul meccanismo, ma sulla vitalità e sul riconoscimento all’interno di un contesto locale, difficile da tradurre. L’ironia è usata per affrontare temi seri come politica, mafia e Chiesa, come atto liberatorio per comprendere ciò che si teme. Quando le opere vengono adattate in film, l’ironia può essere persa. Le istituzioni italiane sono viste come disorganizzate e basate sulla menzogna, rendendo difficile per i cittadini trovare la verità. Film che criticano le istituzioni, come *Cadaveri eccellenti* e *Todo modo*, incontrano problemi legali o di distribuzione. Si pone la questione della libertà dell’arte di interpretare fatti politici senza censura, un diritto garantito dalla Costituzione. L’impegno con il cinema, sia in progetti realizzati che incompiuti, mostra un rapporto complesso con questo mezzo, che da passione diventa strumento di visione critica.Riassunto Lungo
1. Il peso del silenzio e della vendetta
La violenza colpisce Palermo con una serie di omicidi, legati a contrasti economici, rivalità e sospetti di tradimento. Le vittime vengono uccise in diversi luoghi della città, dai giardini ai cantieri, dai mercati alle strade più trafficate. Una donna, in un’aula di tribunale, racconta la tragica fine del marito, Antonio. La sua morte era stata preceduta da inquietanti segnali, come la strada bloccata da pietre davanti alla loro casa. Sebbene Antonio fosse un uomo pacifico, era sorto il sospetto che avesse potuto rivelare informazioni dopo un arresto subito in precedenza.La scelta tra silenzio e vendetta
La donna e il figlio sapevano chi erano i responsabili dell’omicidio, persone che non si erano fatte scrupoli a presentarsi persino al funerale. Tuttavia, non denunciarono per proteggere il ragazzo e rispettare la volontà di Antonio, che aveva sempre rifiutato l’idea della vendetta. La madre cercò aiuto per il figlio rivolgendosi a un uomo potente, Don Ciccio, che le promise protezione, ma che in tribunale negò ogni cosa. Nonostante ogni precauzione, il figlio cadde vittima di un agguato, attirato fuori casa con la scusa di una questione legata a un esproprio di terreno. A quel punto, la madre decise di rompere il silenzio e di parlare in tribunale. Affermò che gli assassini avevano infranto la legge d’onore, spinta dal desiderio di vendetta per la perdita del figlio.Testimoni riluttanti in un paese siciliano
In un piccolo paese della Sicilia, due giovani studenti si trovarono a essere testimoni involontari di un omicidio avvenuto in campagna. Il terrore li paralizzò, portandoli a mantenere il silenzio su quanto avevano visto. La ragazza avrebbe voluto denunciare l’accaduto, ma il ragazzo la convinse a non farlo, temendo le ritorsioni e soprattutto la rivelazione della loro relazione, tenuta segreta. Nonostante l’arresto di alcune persone sospettate, la ragazza riconobbe l’assassino per strada, confermando i suoi timori. La famiglia della ragazza venne a conoscenza della situazione e subì forti pressioni e minacce per garantire il loro silenzio.Il peso delle minacce e la ricerca della verità
Di fronte a questa pericolosa situazione, i familiari decisero di mandare la ragazza a studiare lontano, facendole promettere di dimenticare tutto e non parlare mai più dell’omicidio. Tuttavia, la ragazza, invece di seguire le istruzioni, si recò a Genova e decise di raccontare l’intera vicenda ai carabinieri. Al processo che ne seguì, si preparò un piano per screditare la sua testimonianza. L’accordo prevedeva di farla passare per una persona instabile e di convincere il ragazzo a negare di aver riconosciuto l’imputato, soffocando ancora una volta la verità.Un gangster ritirato e un conto in sospeso
Una storia narra di un ex gangster americano degli anni Venti, che si era ritirato a vivere in campagna, forse a causa di una malattia o fingendola. La sua quiete viene interrotta quando viene contattato dai suoi vecchi soci, che nel frattempo sono diventati molto potenti. Il suo allontanamento dal mondo criminale era legato a un evento del passato: l’omicidio di un amico durante una rapina. Il bottino di quella rapina era stato rubato da un avvocato corrotto, che ora ricopre la carica di senatore. L’ex gangster riceve l’incarico di commettere un nuovo omicidio.La resa dei conti
Presto capisce di essere solo una pedina in un gioco molto più grande, forse connesso a eventi recenti, come l’assassinio di figure pubbliche. Decide allora di agire di propria iniziativa. Raggiunge il senatore e lo uccide, ma viene a sua volta colpito a morte. La versione ufficiale che viene diffusa presenta gli eventi come l’opera di due individui squilibrati, nascondendo la vera natura dei fatti e le profonde radici della violenza e della corruzione.Ma il silenzio descritto nel capitolo è solo frutto della paura individuale, o è imposto da un sistema che rende la giustizia inaccessibile o inefficace?
Il capitolo presenta diverse situazioni in cui il silenzio sembra una scelta obbligata di fronte alla violenza e al potere criminale. Tuttavia, la narrazione si concentra molto sulle motivazioni personali (paura, protezione dei familiari, rispetto di volontà altrui) senza forse approfondire a sufficienza il contesto più ampio che rende queste scelte quasi inevitabili. Per comprendere meglio il “peso del silenzio”, sarebbe utile esplorare le dinamiche sociali e politiche che creano un ambiente in cui denunciare è pericoloso e le istituzioni non offrono garanzie sufficienti. Approfondire studi di sociologia del crimine organizzato, la storia della mafia e le analisi sul rapporto tra cittadini e potere in contesti ad alta densità criminale può fornire una prospettiva più completa. Autori come Sciascia, Falcone, Gambetta o Blok offrono spunti fondamentali su questi temi, mostrando come il silenzio non sia solo una reazione individuale, ma un elemento strutturale di certi sistemi di potere informale.2. Sguardi sul Cinema e i suoi Miti
Erotismo e Censura
L’erotismo nel cinema e nella cultura visiva incontra spesso la censura. Specialmente in Italia, c’è la tendenza a nascondere il nudo invece di considerarlo una cosa normale. In America, si vede un contrasto tra una mentalità molto rigida e un modo più libero di vedere il corpo. Questo porta a risultati esagerati, come l’ossessione per seni molto grandi. La scelta di attrici con forme diverse dalle statue classiche suggerisce un ritorno a un’idea legata all’infanzia e all’allattamento.
Il Ruolo del Regista
Nel processo di creazione di un film, la figura centrale è il regista. È la sua visione che dà coerenza all’idea di partenza. Soggetto e sceneggiatura sono considerati strumenti al suo servizio. L’efficacia artistica di un film dipende quindi dalla capacità del regista. Un esempio chiaro di questo è La dolce vita di Fellini.
Adattare i Libri per il Cinema
Trasformare un libro in un film è spesso difficile. Un regista bravo dovrebbe affrontare un’opera letteraria già completa con rispetto e fedeltà al testo originale, come ha fatto Laurence Olivier con le opere di Shakespeare. Le versioni cinematografiche di romanzi importanti sono spesso di scarsa qualità. Un esempio negativo è l’adattamento de Il bell’Antonio di Brancati. Nel film, l’idea centrale del romanzo, legata al periodo fascista e all’impotenza del protagonista come conseguenza di quel tempo, viene cambiata. Le scene erotiche vengono spostate al periodo dopo il fascismo, e la ragione dell’impotenza del personaggio principale viene modificata.
I Miti Americani nel Cinema
I simboli dell’America nel cinema cambiano nel tempo. Si passa da figure come Gary Cooper, che rappresentava un’America legata alla campagna, onesta e legata all’idea della frontiera, a figure come Marilyn Monroe, che simboleggia l’America delle grandi città e le sue debolezze interiori. Gary Cooper incarna l’idea che la frontiera sia stata fondamentale per lo sviluppo americano e l’eroe che riporta ordine e libertà. Marilyn Monroe, nel film The Misfits (Gli inadatti), mostra la fragilità di una persona che si sente “inadatta”, una condizione legata al sentirsi soli e diversi. Rappresenta anche la difficoltà di accettare che la bellezza fisica finisce, specialmente senza avere figli. Questo cambiamento nei simboli mostra un cambiamento nella cultura e la perdita di un’idea di America che non riesce a capire se stessa.
Ma è davvero così semplice definire l’efficacia artistica di un film o giudicare un adattamento letterario?
Il capitolo presenta una visione piuttosto rigida e, per certi versi, superata del processo cinematografico, attribuendo al regista un ruolo quasi esclusivo nella riuscita artistica e considerando la fedeltà al testo originale come il criterio principale per valutare un adattamento. Questa prospettiva ignora la natura profondamente collaborativa del cinema e le molteplici possibilità creative che si aprono quando un testo letterario viene trasposto in un medium diverso. Per avere un quadro più completo, è essenziale confrontarsi con le diverse teorie sull’autorialità nel cinema, che mettono in discussione la figura del regista come unico “autore”, e con gli studi sull’adattamento, che esplorano come i testi vengano trasformati e arricchiti nel passaggio da un medium all’altro. Approfondire il pensiero di critici come André Bazin, che valorizzava la realtà e il contributo di tutti gli elementi filmici, o di studiosi di adattamento come Robert Stam, può offrire strumenti critici più raffinati per analizzare queste complesse relazioni.3. Fedeltà e Infedeltà nell’Arte
L’adattamento cinematografico del libro “Il Gattopardo” da parte di Visconti modifica profondamente la natura del protagonista, Don Fabrizio. Nel romanzo, il personaggio possiede una qualità classica e austera, mentre nella versione filmica appare segnato da una profonda decadenza. Questa trasformazione è visibile in diverse scene, come un sogno attribuito al principe che non trova riscontro nella struttura originale del libro e che ne altera l’essenza. La fedeltà alla trama e agli eventi narrati nel libro non corrisponde, quindi, a una vera fedeltà al personaggio centrale, la cui identità risulta modificata nella sua essenza più profonda.Rappresentare la Sicilia: Realtà e Stereotipi
Anche alcune opere più recenti che descrivono la Sicilia offrono una visione che non sempre è aggiornata rispetto alla realtà sociale contemporanea dell’isola. Ad esempio, un libro e un film recenti mostrano la regione ancora intrappolata in pregiudizi legati all’onore e alla verginità in una maniera esasperata, quasi caricaturale. La realtà siciliana è in continua evoluzione; i matrimoni per amore sono sempre più diffusi e sostituiscono progressivamente quelli combinati, e i rapporti tra uomo e donna stanno cambiando significativamente. Le rappresentazioni artistiche, a volte, non riescono a cogliere questa evoluzione e ricorrono a stereotipi superati o a scene che non trovano riscontro nella vita reale, come presunti linciaggi pubblici per questioni d’onore. Le pressioni sociali esistono ancora, naturalmente, ma si manifestano in forme molto più sottili e complesse rispetto a quelle descritte.Il Ruolo dell’Attore
Un aspetto fondamentale della rappresentazione artistica, sia essa teatrale o cinematografica, è la capacità di un attore di incarnare pienamente un personaggio. Alcuni interpreti riescono a fondersi completamente con il ruolo che interpretano, al punto che le loro precedenti performance non interferiscono nella percezione del nuovo personaggio. Altri, invece, rimangono fortemente legati a un determinato “tipo” di personaggio, limitando così la loro versatilità e la capacità di trasformazione richiesta da ruoli diversi. La scelta dell’interprete giusto è cruciale perché influenza in modo determinante la percezione che il pubblico avrà del personaggio portato sullo schermo o sul palco.Ma “scherzare” su mafia e politica serve davvero a liberare o rischia solo di banalizzare?
Il capitolo afferma con sicurezza che l’uso dell’ironia su temi “seri” come la mafia o la politica porti a liberazione e maggiore consapevolezza. Tuttavia, l’efficacia dell’ironia è un terreno scivoloso, fortemente dipendente dal contesto e dalla sensibilità dell’uditorio. Non viene sufficientemente esplorato il rischio che l’ironia, se mal calibrata o fraintesa, possa non solo fallire nel suo intento critico, ma addirittura banalizzare la gravità dell’argomento o rafforzare stereotipi. Per approfondire le complesse dinamiche dell’umorismo e dell’ironia nel confronto con temi sociali e politici delicati, sarebbe utile esplorare la sociologia dell’umorismo, gli studi culturali e la retorica. Autori come Pierre Bourdieu, Mikhail Bakhtin o Linda Hutcheon offrono strumenti concettuali per analizzare come l’umorismo funzioni all’interno di specifiche strutture sociali e culturali e quali siano i potenziali effetti, voluti e non voluti, del suo impiego.7. Specchi infranti: il cinema e le istituzioni
Film come “Cadaveri eccellenti” e “Todo modo” mostrano i problemi legati alle istituzioni italiane. Il primo viene denunciato per aver offeso le istituzioni, mentre il secondo ha difficoltà a essere distribuito, un fatto che sembra voler ostacolare la democrazia cristiana. Una vera istituzione è un’organizzazione stabile e regolata della vita sociale. In Italia, invece, la realtà è di disorganizzazione, con regole che non funzionano e strutture deboli. Dire la verità su queste istituzioni vuote e non funzionanti sembra essere considerato un’offesa. Le istituzioni italiane, fin dal caso Giuliano, sembrano costruite sulla menzogna, rendendo difficile per i cittadini scoprire la verità.La libertà dell’arte di raccontare la realtà
Ci si chiede se l’arte, inclusi cinema e letteratura, abbia il diritto di interpretare fatti politici e immaginare scenari basati su tali interpretazioni. Si pone il problema se scrittori e registi debbano limitarsi o accettare censure quando le loro visioni non coincidono con ciò che vuole il potere, anche se le loro interpretazioni sono accurate. Questa libertà è fondamentale per una società sana dove diverse prospettive possono essere espresse e discusse apertamente. La Costituzione italiana, all’articolo 33, protegge la libertà dell’arte e della scienza. Mettere in discussione questa libertà o limitarla dopo che un’opera è stata creata rappresenta un pericolo per la democrazia stessa.L’esperienza diretta con il mondo del cinema
L’impegno con il cinema si manifesta in vari progetti concreti. Alcuni sono stati realizzati, come documentari o collaborazioni a sceneggiature, per esempio nel caso del film su Bronte. Altri, invece, sono rimasti solo proposte e non sono stati completati, come quelle discusse con registi importanti quali Leone, Antonioni e Lizzani. Questa attività mostra un rapporto non sempre semplice con il mezzo cinematografico. Quella che era una passione nata in gioventù si è trasformata nel tempo in una visione critica, soprattutto riguardo a come le proprie opere venivano adattate per lo schermo.La tesi che le istituzioni italiane siano costruite sulla menzogna fin dal caso Giuliano è un’analisi fondata o una generalizzazione eccessiva?
Il capitolo presenta l’idea che le istituzioni italiane, fin da un momento storico preciso come il caso Giuliano, siano intrinsecamente legate alla menzogna. Questa è un’affermazione molto forte che, nel riassunto fornito, manca di un’adeguata contestualizzazione storica e di esempi specifici che vadano oltre le difficoltà incontrate da alcuni film. Per valutare la validità di tale tesi e comprendere la complessità del rapporto tra verità, potere e istituzioni in Italia, sarebbe utile approfondire la storia politica della Repubblica italiana, analizzando i momenti chiave e le dinamiche che hanno caratterizzato il funzionamento dello Stato. Approfondimenti sulla storia del dopoguerra e sulle analisi critiche delle strutture di potere possono fornire gli strumenti per giudicare se l’affermazione del capitolo sia un’analisi accurata o una semplificazione polemica.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]