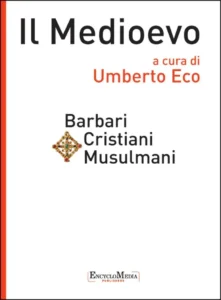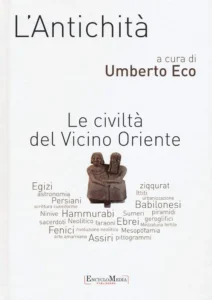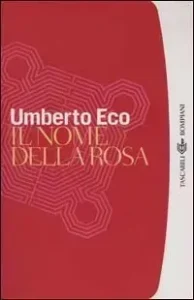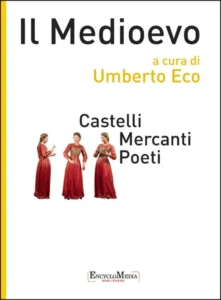Contenuti del libro
Informazioni
“Quale verità Mentire, fingere, nascondere” di Umberto Eco è un libro che ti apre gli occhi su come funziona la “verità” nel mondo di oggi. Non è una storia con personaggi, ma un’analisi super interessante su come le cose ci vengono presentate e su quanto sia difficile distinguere il vero dal falso. Eco esplora un sacco di ambiti diversi, dal giornalismo, dove scopri che l’obiettività è più un’idea che un fatto, ai processi legali, dove le parole e il loro valore emotivo contano quasi più delle prove. Ti fa capire come le immagini e la narrazione vengano usate per influenzare la nostra percezione, e come anche fatti veri possano essere usati per distrarre o suggerire cose che non sono vere. Si parla anche di falsificazione, di teorie del complotto che vedono segreti ovunque, e delle sfide di Internet, dove trovare informazioni affidabili è un casino. È un libro che ti spinge a pensare in modo critico su tutto quello che leggi e vedi, mostrandoti i meccanismi dietro le menzogne, le finzioni e le cose che ci vengono nascoste, per capire meglio la realtà che ci circonda.Riassunto Breve
Quello che vediamo come realtà è spesso costruito e non è mai un semplice fatto oggettivo. Nel giornalismo, per esempio, la notizia non è mai data senza che ci sia un’interpretazione dietro; la scelta di cosa riportare, come titolarlo, dove metterlo sulla pagina, sono tutti modi per aggiungere un punto di vista. L’idea di obiettività è più che altro una scusa per nascondere questa interpretazione. Un giornalista dovrebbe mostrare la sua verità, ma anche far capire che ne esistono altre, e una buona notizia distingue i fatti dai giudizi personali. Anche nei processi legali, le parole usate possono avere un forte valore emotivo che fa sembrare colpevole qualcuno anche se non ha commesso un reato, basandosi su pregiudizi. Pure le parate militari sono uno spettacolo che costruisce un’idea di potenza che non è la forza militare vera, una specie di bugia accettata da tutti. In tanti campi, la comunicazione crea una “verità” che non è quella dei fatti, spesso per motivi ideologici o per far rispettare le regole sociali. Il modo in cui le notizie vengono presentate cambia come percepiamo la realtà; anche fatti veri possono essere usati per distrarre da cose più importanti, e per difendersi si può pensare a chi conviene che una certa notizia giri in quel momento. Spesso, cose normali diventano importanti solo per come vengono raccontate, associando dettagli neutri a idee negative, sfruttando i pregiudizi. Questo succede anche in politica, dove un leader può inventare una storia su di sé per contrastare quella che dicono i giornali. C’è anche la tendenza a vedere eventi brutti, come crimini o malattie, come misteri senza spiegazioni chiare, come se fosse colpa di un “Male” generico. Questo modo di pensare evita di cercare le vere cause, che spesso sono sociali o fisiche, e rende difficile trovare soluzioni, favorendo la superstizione o la ricerca di qualcuno a cui dare la colpa. Capire come le cose sono collegate richiede impegno, ma serve per capire davvero la realtà e non farsi ingannare da chi usa il sensazionalismo. Le immagini, come le foto, sembrano mostrare la realtà così com’è, e per questo sono molto convincenti, usate per confermare notizie o suggerire interpretazioni, anche solo con una didascalia sbagliata. Ma le immagini rappresentano un tipo di cosa, non una cosa precisa, e sono le parole che dicono a cosa si riferiscono esattamente, dimostrando che il linguaggio spesso guida l’interpretazione anche delle immagini. Alcuni pensano che falsificare informazioni o immagini sia un modo per combattere i grandi poteri, che non sono in un unico posto ma sono una rete diffusa. L’idea è di disturbare questa rete con piccole azioni, come falsificare documenti o fare errori nei pagamenti, per far crollare tutto. Ci sono stati tentativi di questo tipo, ma i grandi sistemi sono molto resistenti, riescono ad assorbire i danni o a cambiare per gestirli. In più, se tutti falsificassero tutto, non ci sarebbe più la fiducia minima necessaria per stare insieme, e questo non distruggerebbe il potere, ma farebbe emergere nuovi capi, quelli più bravi a falsificare. A volte, la ricerca di una verità assoluta porta a comunicazioni giuste nei dettagli ma inutili o fuorvianti perché mancano informazioni importanti o sono troppo letterali. Internet rende ancora più difficile capire quali informazioni sono affidabili; siti come Wikipedia possono essere modificati male, e ci sono tanti siti inaffidabili. Molti non sanno distinguere le fonti. Questo crea problemi a scuola, dove gli studenti copiano senza verificare. Un modo per aiutarli è fargli cercare e spiegare perché certe fonti online non sono affidabili, per sviluppare il pensiero critico. Allo stesso tempo, c’è una forte tendenza a credere nelle teorie del complotto, che vedono un potere nascosto che controlla quasi tutto. Questa idea nasce dalla voglia di avere spiegazioni semplici per fatti complicati o preoccupanti e a volte serve per non prendersi responsabilità. Credere in un complotto è un po’ come credere nei miracoli, attribuendo eventi inspiegabili a forze segrete. Però, i complotti e i segreti veri tendono a venire fuori, soprattutto se sono importanti, perché le persone parlano o lo fanno per soldi. È difficile che un complotto molto grande, che coinvolge tante persone, rimanga segreto a lungo. La forza di chi dice di avere un segreto sta nel far credere che esista. Esistono complotti reali, ma sono limitati, come colpi di stato o accordi segreti tra aziende. La sindrome del complotto è diversa, vede un unico potere nascosto dietro quasi tutto. Capire se un oggetto o un documento è vero è difficile; i metodi scientifici e filologici sono spesso più bravi a dimostrare che qualcosa è falso, per esempio se usa materiali o concetti che non esistevano all’epoca. Ma se non si trovano prove di falsità, non è detto che sia vero; alcuni falsi sono fatti benissimo. Nella vita di tutti i giorni, ci fidiamo di quello che sembra più probabile, basato su più indizi e su quello che pensano gli altri. Le bugie, specialmente in politica, esistono da sempre, ma le bugie che vanno contro i fatti veri spesso vengono scoperte dalla realtà stessa. Le bugie che si contraddicono da sole durano poco. La finzione, come un romanzo, non è una bugia; l’autore fa finta che la storia sia vera, e il lettore partecipa a questo gioco. La finzione usa dei segnali per farsi riconoscere come tale. Alcuni lettori non capiscono questa differenza, prendono i romanzi per fatti veri o confondono le idee dei personaggi con quelle dell’autore; questo si chiama deficit finzionale. Questa difficoltà a distinguere la finzione dalla realtà si vede anche online, per esempio su Twitter, dove circolano tante opinioni diverse e spesso contraddittorie, come chiacchiere da bar. Ci sono profili falsi, e per alcuni esistere online è come esistere davvero. Queste conversazioni online hanno poco peso sugli eventi importanti o sull’opinione pubblica generale. Anche persone famose usano questi spazi, ma le loro idee contano di più se passano per i mezzi di informazione tradizionali. Le persone comuni forse partecipano per sentirsi importanti. Lo spazio limitato per scrivere rende difficile esprimere idee complesse, e così internet si riempie di pensieri che non hanno un vero valore.Riassunto Lungo
1. La fabbrica della verità
La realtà che ci viene presentata non è mai una semplice descrizione oggettiva dei fatti. Questo è evidente nel giornalismo, dove la notizia non arriva mai senza un’interpretazione. La scelta di cosa riportare, i titoli usati, come vengono disposti i contenuti sulla pagina, il modo in cui la storia viene raccontata e la sua posizione sono tutti elementi che aggiungono un punto di vista. L’idea di obiettività è spesso usata in teoria per nascondere questa interpretazione inevitabile. Un giornalista non è obbligato a essere neutrale in senso assoluto, ma ha il compito di raccontare ciò che sa e come vede le cose. Un buon giornalismo sa distinguere chiaramente i fatti dalle opinioni o dai giudizi personali. Nascondere al pubblico che ogni notizia è il risultato di una selezione e di un modo specifico di guardare la realtà è un’idea che ostacola un’informazione libera e consapevole. Chi scrive deve mostrare la propria prospettiva, ma deve anche far capire che esistono altri modi di vedere le cose.Le parole nei processi legali
Questo principio della costruzione della realtà si manifesta anche in contesti diversi, come nei processi legali. Qui, le prove si basano spesso su segni, e le parole sono uno strumento fondamentale. Le parole hanno un significato di base, diretto (denotativo), ma anche un valore emotivo o associativo (connotativo). In alcuni casi, come nel processo per “plagio” (un reato che esisteva in Italia e riguardava l’influenzare la volontà di una persona), le parole chiave sono state usate soprattutto per il loro impatto emotivo, non per descrivere i fatti in modo neutro. Questo uso delle parole permette di far sembrare azioni che non sono reati come se lo fossero, creando un’idea di colpa basata su idee preconcette della società e su tabù legati al linguaggio. In pratica, si finisce per condannare chi è diverso dai modelli sociali accettati, più che le azioni concrete che ha compiuto.Le parate militari come spettacolo
Anche le parate militari sono un esempio di come la comunicazione costruisca una “verità” che non corrisponde ai fatti oggettivi. Sono uno spettacolo pensato per comunicare potenza e forza. Tuttavia, fornire informazioni precise sulla reale capacità militare di un paese sarebbe un atto di spionaggio. Per questo motivo, le parate devono per forza mostrare una forza che non è quella effettiva; diventano la celebrazione di una rappresentazione non vera. Questa rappresentazione viene poi accettata come “verità” attraverso il rituale pubblico e la percezione collettiva. In diversi ambiti della vita sociale, la comunicazione non si limita a descrivere la realtà, ma la costruisce attivamente, spesso per sostenere certe idee o per rafforzare le regole e i valori della società.Se la realtà è sempre una “fabbrica” di interpretazioni, come può il “buon giornalismo” pretendere di distinguere fatti e opinioni?
Il capitolo, pur mostrando come la realtà sia sempre mediata e interpretata, introduce la nozione di “buon giornalismo” capace di distinguere fatti e opinioni. Questo solleva un interrogativo fondamentale: se ogni narrazione è una costruzione, su quale base poggiano i “fatti” che dovrebbero essere distinti dalle “opinioni”? Per approfondire questa apparente contraddizione e comprendere meglio il rapporto tra linguaggio, percezione e quella che chiamiamo “realtà”, sarebbe utile esplorare la filosofia del linguaggio (ad esempio, le riflessioni di Wittgenstein) e l’epistemologia, oltre a studi specifici sulla sociologia della comunicazione e sui meccanismi cognitivi che influenzano la nostra percezione.2. Il Potere della Narrazione: Fatti, Storie e Misteri
La presentazione delle notizie influenza profondamente la percezione della realtà. Anche quando i fatti riportati sono veri, il modo in cui vengono scelti, evidenziati e collegati ad altri eventi può creare un significato molto diverso da quello oggettivo. Una notizia, pur essendo vera, può essere usata strategicamente per distogliere l’attenzione da altri fatti importanti. Un modo per difendersi da questa manipolazione è chiedersi sempre chi potrebbe trarre vantaggio dalla diffusione di una certa notizia in un determinato momento.L’uso del linguaggio per creare significato
Spesso, dettagli comuni e apparentemente banali vengono resi significativi attraverso l’uso del linguaggio. Ad esempio, descrivere il ritrovamento di “molte paia di scarpe” nella casa di una persona sospettata, anche se possedere diverse paia di scarpe è normale, suggerisce un legame con un crimine in cui le scarpe hanno avuto un ruolo. Allo stesso modo, presentare una persona fermata come in possesso di un “libretto con numerosi indirizzi” trasforma un oggetto quotidiano in un potenziale segno di colpevolezza. Questo accade perché si associano dettagli neutri a contesti negativi, sfruttando i pregiudizi e le aspettative comuni del pubblico.La narrazione nella politica
Questo meccanismo narrativo si applica anche nel mondo della politica. Un leader può costruire una storia su di sé, presentandosi ad esempio come un eroe che affronta grandi sfide o come una vittima di ingiustizie, per contrastare una narrazione negativa diffusa dai media. La forza di questa contro-storia non dipende solo dalla sua struttura interna, ma anche dalla credibilità di chi la racconta. Elementi non verbali e la percezione generale della persona possono minare o rafforzare l’efficacia della narrazione politica.Il “mistero” come ostacolo alla comprensione
Esiste una forte tendenza a considerare eventi negativi, come crimini efferati o malattie gravi, come misteri inspiegabili, quasi manifestazioni di un “Male” assoluto senza cause evidenti. Questo tipo di “pensiero magico” impedisce di cercare e riconoscere le connessioni profonde tra gli eventi e le loro cause reali, siano esse sociali, economiche o fisiche. Cercare e comprendere queste connessioni, al contrario, permette di analizzare i fenomeni in modo razionale e oggettivo. Ad esempio, l’aumento di alcune malattie è strettamente legato all’aumento generale dell’aspettativa di vita della popolazione, non è una semplice fatalità incomprensibile.Ignorare le cause profonde e concentrarsi solo sull’aspetto di “mistero” rende estremamente difficile trovare soluzioni efficaci e favorisce la superstizione, la paura o la ricerca di facili capri espiatori. Comprendere come gli eventi sono collegati tra loro richiede impegno e analisi critica, ma è un passo fondamentale per leggere la realtà in modo consapevole e per contrastare chi cerca di usare il sensazionalismo e il mistero per esercitare controllo o influenza.Ma se la narrazione è il modo in cui diamo senso al mondo, il capitolo non rischia di demonizzarla eccessivamente, contrapponendola in modo troppo netto all’analisi razionale?
Il capitolo giustamente mette in guardia contro l’uso manipolativo della narrazione e la tendenza a rifugiarsi nel “mistero” per evitare l’analisi. Tuttavia, non esplora a sufficienza il ruolo fondamentale che la narrazione ha nella nostra comprensione della realtà. Non è forse attraverso storie e strutture narrative che organizziamo fatti complessi, li rendiamo comprensibili e li memorizziamo? Il problema potrebbe non essere la narrazione in sé, ma piuttosto la sua qualità, la sua onestà e il suo rapporto con i fatti verificabili. Per approfondire questo aspetto, si possono esplorare discipline come la teoria della narrazione, la semiotica o la psicologia cognitiva. Autori come Roland Barthes o Jerome Bruner offrono prospettive diverse su come le storie e i simboli modellano la nostra percezione e la nostra conoscenza.3. L’inganno delle immagini e la resilienza del potere
Le immagini, come foto o filmati, sembrano mostrare la realtà così com’è, a differenza delle parole il cui significato è stabilito per convenzione. Questa apparenza di obiettività le rende molto efficaci per convincere, usate per confermare informazioni o suggerire come interpretarle, anche solo accostandole in modo particolare o aggiungendo didascalie che portano fuori strada.Però, un’immagine non rappresenta un oggetto unico e specifico, ma piuttosto un tipo di oggetto. Una foto di una persona che non conosciamo è l’immagine di una certa categoria di persone. Il suo significato preciso, a chi si riferisce esattamente, dipende dalle parole che l’accompagnano. Così, la fiducia che diamo all’immagine viene guidata dal linguaggio, dimostrando che la parola, che sembra più generale, spesso ha più forza dell’immagine, che sembra più specifica.
La falsificazione come strategia di lotta
La facilità con cui si possono manipolare immagini e informazioni ha portato a vedere la falsificazione come un modo per combattere i grandi sistemi di potere. Questa idea parte dal presupposto che il potere non sia concentrato in un unico punto, ma si basi su una vasta rete di accordi e consensi diffusi tra le persone, chiamati “molecolari”. L’obiettivo è attaccare questa rete con azioni che creano disturbo, come falsificare documenti o causare piccoli problemi nei sistemi, ad esempio con pagamenti sbagliati. Queste azioni mirano a rompere il consenso su cui si basa il sistema, sperando di farlo crollare.
Esempi di questa “guerriglia della falsificazione” includono l’uso non autorizzato di codici telefonici o la diffusione di notizie false e documenti attribuiti ad altri. Nonostante questi tentativi, i grandi sistemi dimostrano una notevole capacità di resistere e adattarsi. Riescono ad assorbire i danni causati dalle falsificazioni o a cambiare le proprie regole e strutture per gestirle meglio. Ad esempio, le case editrici possono aumentare il prezzo dei libri sapendo che verranno fotocopiati, recuperando così le perdite.
Le conseguenze di una falsificazione totale
Se la falsificazione diventasse totale e diffusa, distruggerebbe le condizioni minime di fiducia che sono indispensabili perché qualsiasi gruppo di persone possa convivere. In una situazione in cui tutti mentono e falsificano, non si elimina il potere in sé, ma si creano le condizioni ideali perché emergano nuovi dominatori. Saranno coloro che sono più bravi e spregiudicati nel falsificare a prendere il controllo.
A volte, la ricerca di una verità assoluta si manifesta in forme di comunicazione che, pur essendo tecnicamente esatte, risultano inutili o fuorvianti. Questo accade per mancanza di informazioni importanti o per un’eccessiva attenzione alla precisione letterale, come si vede nelle istruzioni dei farmaci o nelle guide dei software.
Ma è davvero così certo che le bugie sistematiche, soprattutto in politica, vengano sempre smascherate dalla realtà e durino poco?
Il capitolo sostiene che le bugie che vanno contro i fatti concreti vengono spesso scoperte dalla realtà e durano poco. Questa affermazione sembra eccessivamente ottimistica e non tiene conto della potenza e della persistenza della propaganda e della disinformazione organizzata, che possono manipolare la percezione della realtà per lunghi periodi, anche in presenza di fatti contrari. Per comprendere meglio come le bugie possano radicarsi e influenzare la società, nonostante la “realtà”, sarebbe utile approfondire gli studi sulla psicologia delle masse e le tecniche di propaganda. Autori come Le Bon o Bernays offrono spunti, così come le analisi sulla natura del potere e della menzogna politica condotte da Arendt.6. Realtà e Rumore Digitale
Molti lettori hanno difficoltà a distinguere ciò che è inventato da ciò che è reale nei libri. A volte pensano che i pensieri e i sentimenti dei personaggi siano quelli dell’autore. Anche se le storie create possono sembrare molto vere e far riflettere o provare emozioni forti, alcuni lettori non accettano che siano finzione. Non riescono a “sospendere l’incredulità”, cioè a credere temporaneamente alla storia come se fosse vera. Prendono la narrazione come un fatto, perdendo così l’aspetto artistico e gli insegnamenti che la storia può offrire. Questa difficoltà nel capire la finzione si chiama deficit finzionale.Il mondo digitale e il rumore delle informazioni
Una difficoltà simile nel capire le informazioni si vede anche nell’ambiente digitale. Su piattaforme come Twitter, circolano tantissime opinioni diverse. Ci sono profili che non sono veri, e per alcune persone, esistere online sembra uguale a esistere nella realtà. I messaggi che le persone si scambiano sono spesso diversi e si contraddicono tra loro, un po’ come le chiacchiere che si fanno in un bar. Queste conversazioni fatte online, però, hanno in realtà poca influenza sugli eventi importanti del mondo o su quello che pensa la gente in generale. Anche persone famose o importanti usano questi spazi, ma le loro idee probabilmente avrebbero più forza e risonanza se usassero i mezzi di informazione più tradizionali. Le persone comuni forse partecipano a queste discussioni online perché vogliono sentirsi importanti o ascoltate. Però, lo spazio limitato che si ha per scrivere rende difficile spiegare concetti che sono un po’ complicati. Così, internet si riempie di tanti pensieri e opinioni che, alla fine, non hanno un peso reale o un impatto significativo.Se il “rumore digitale” è privo di peso reale, come si concilia questa visione con l’evidente impatto che le piattaforme online hanno su dibattito pubblico e dinamiche sociali?
Il capitolo, pur offrendo spunti interessanti, sembra minimizzare eccessivamente l’influenza del “rumore digitale”, definendolo privo di peso reale. Questa posizione è ampiamente dibattuta e non tiene conto della complessità dell’interazione online. Per comprendere meglio il reale impatto delle piattaforme digitali sulla società e sul dibattito pubblico, è fondamentale approfondire discipline come la sociologia della comunicazione e le scienze politiche, studiando autori che hanno analizzato la società in rete e le nuove forme di sfera pubblica, come Manuel Castells o Jürgen Habermas.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]