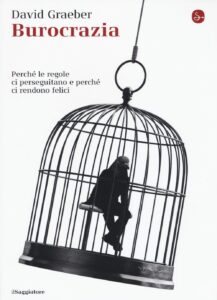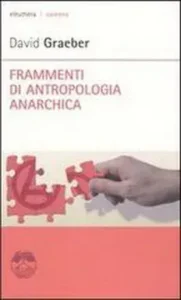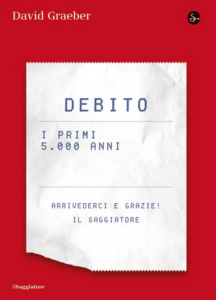1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Progetto democrazia. Un’idea, una crisi, un movimento” di David Graeber ti porta dentro l’esperienza incredibile di Occupy Wall Street, un movimento nato quasi per caso da un’idea semplice ma che ha acceso una scintilla potentissima. Il libro ti spiega come, partendo da una riflessione sulla disuguaglianza economica tra l’1% e il 99% della popolazione e sulla crisi finanziaria del 2008, un gruppo eterogeneo di persone abbia deciso di occupare Zuccotti Park a New York, trasformandolo in un vero e proprio esperimento di democrazia diretta. Non è solo la storia di una protesta, ma un viaggio nelle radici meno conosciute della democrazia, quelle che vanno oltre il voto e si ritrovano in pratiche come il consenso, usato dai partecipanti per prendere decisioni insieme, superando le logiche gerarchiche. Graeber ti fa capire che Occupy Wall Street, nonostante le difficoltà e la repressione poliziesca, ha messo in discussione il sistema, il ruolo del denaro nella politica e ha mostrato che un altro modo di organizzarsi, basato sulla partecipazione e l’uguaglianza, è possibile. È un libro che ti fa pensare alla vera essenza della democrazia e al potere dei movimenti sociali di cambiare il senso comune.Riassunto Breve
Occupy Wall Street nasce in modo inatteso da un’idea simbolica, trovando subito un gruppo di attivisti che rifiuta strutture organizzative rigide a favore della democrazia diretta e del consenso. Il movimento adotta lo slogan “Noi siamo il 99%” per evidenziare la disuguaglianza economica e l’esclusione della maggioranza. L’occupazione di Zuccotti Park diventa un esperimento di democrazia partecipativa, usando il “microfono umano” per comunicare in modo orizzontale nonostante le difficoltà e la polizia. La sua durata iniziale sorprende, favorita da una repressione moderata, dall’uso dei social media che mostrano la brutalità poliziesca e dalla crisi economica del 2008 che colpisce i giovani con debiti e mancanza di prospettive. Occupy si diffonde perché intercetta un sentimento di ingiustizia e rifiuta di integrarsi nel sistema politico, criticando radicalmente la corruzione e il ruolo del denaro nella politica. Anche se i presidi fisici finiscono a causa della repressione e di una narrazione mediatica negativa, la critica al sistema rimane centrale nella sua eredità. Il movimento si collega a una tradizione democratica popolare americana, spesso associata all’anarchismo, che spinge i principi democratici alle estreme conseguenze, a differenza della repubblica rappresentativa voluta dai Padri Fondatori che temevano il potere popolare diretto. La parola “democrazia” ha cambiato significato, usata per descrivere sistemi che evitano la democrazia diretta. Le vere radici del sentimento democratico si trovano in contesti non statali come comunità di pirati o di frontiera influenzate da società indigene, che praticavano autogoverno e consenso. L’anarchismo cerca una società libera basata su uguaglianza e solidarietà, rifiutando la violenza e promuovendo organizzazioni orizzontali. La vera democrazia è un processo di delibera collettiva che valorizza la partecipazione e la creatività. Il processo decisionale basato sul consenso, usato da Occupy, nasce tra i quaccheri e si diffonde in movimenti femministi e anarchici come metodo per coltivare una cultura democratica basata sulla ragionevolezza, che bilancia diverse prospettive, non sulla razionalità calcolatrice del potere. Il consenso richiede ascolto, considerazione delle obiezioni, diritto di veto per principi fondamentali e libertà di non aderire. Le decisioni si prendono in piccoli gruppi, con il consenso assembleare per questioni cruciali. L’azione diretta, spesso legata al consenso, è prefigurativa, crea spazi autonomi e gestisce la polizia come una forza esterna, evitando di riprodurre gerarchie negoziando con essa. La strategia della polizia nelle proteste è politica, mira a disperdere le occupazioni usando la minaccia della forza, contrastabile con la forza morale e la solidarietà. Le azioni di strada sono un conflitto in cui creatività e improvvisazione sono tattiche contro la rigidità poliziesca. Le occupazioni sono una strategia di dualismo di poteri, creando spazi autonomi fuori dal sistema. Occupy ha usato la delegittimazione del sistema politico americano. Le rivoluzioni sono trasformazioni del senso comune, che mettono in discussione le basi della politica. Per una società più libera, bisogna sfidare convinzioni come l’etica produttivista, la natura alienante del lavoro burocratico e la percezione distorta del comunismo. Riconcettualizzare il lavoro per il benessere collettivo, ridurre la burocrazia e recuperare il comunismo come condivisione sono passi importanti. L’obiettivo è una società basata su consenso e rispetto per la diversità, con accesso equo alle risorse e libertà individuale di perseguire valori non quantificabili. La trasformazione del senso comune e il risveglio dell’immaginazione collettiva sono forze rivoluzionarie.Riassunto Lungo
1. La Democrazia Inattesa
Occupy Wall Street nasce da una riflessione sul carattere spesso sorprendente dei movimenti rivoluzionari. Tutto parte da un’idea lanciata dalla rivista Adbusters, che proponeva di realizzare un’occupazione simbolica di Wall Street. Questa proposta iniziale, in modo del tutto inatteso, trova un ambiente favorevole e riscuote successo in un gruppo variegato di attivisti che vivono a New York.Le prime fasi del movimento
La prima assemblea generale del movimento rivela subito l’esistenza di diverse idee sull’organizzazione, in particolare emerge una tensione tra modelli organizzativi verticali e orizzontali. Alcuni gruppi politici strutturati provano a prendere il controllo delle decisioni, ma questo tentativo fallisce. Si afferma invece un modello organizzativo basato sulla democrazia diretta e sulla ricerca del consenso tra i partecipanti. Successivamente si formano gruppi di lavoro dedicati a temi specifici e viene definito un sistema decisionale aperto alla partecipazione di tutti.Lo slogan “Noi siamo il 99%” e l’occupazione di Zuccotti Park
Il movimento adotta rapidamente lo slogan “Noi siamo il 99%”. Con questo slogan, il movimento concentra l’attenzione sulla disuguaglianza economica e sul fatto che la maggior parte della popolazione è esclusa dai processi decisionali più importanti. Wall Street diventa così il simbolo di quell’1% di persone privilegiate, che si contrappone al restante 99% della popolazione.L’occupazione si realizza concretamente nel parco Zuccotti. Questo luogo si trasforma in un vero e proprio esperimento di democrazia partecipativa, nato come risposta alla crisi finanziaria e alle politiche di austerità adottate in quel periodo. L’assemblea generale diventa il centro del movimento, il luogo in cui vengono prese le decisioni più importanti. Per comunicare in modo efficace e includere tutti, viene adottato il sistema del “microfono umano”. Questo strumento permette di superare le difficoltà logistiche tipiche di un grande gruppo e di aggirare la presenza massiccia della polizia. Nonostante le difficoltà iniziali e le incertezze sul futuro, Occupy Wall Street si afferma rapidamente come un movimento di protesta di grande importanza, diffondendosi in molti luoghi e aprendo un dibattito a livello globale sui temi della democrazia e della giustizia sociale.Se il successo di Occupy Wall Street è stato “del tutto inatteso”, come mai movimenti simili si sono verificati in diverse parti del mondo nello stesso periodo?
Il capitolo presenta la nascita di Occupy Wall Street come un evento quasi miracoloso, scaturito dal nulla. Tuttavia, trascura di considerare il contesto socio-politico globale in cui il movimento è emerso. Per comprendere meglio le dinamiche dei movimenti sociali inattesi, sarebbe utile approfondire gli studi di sociologia dei movimenti sociali, in particolare autori come Sidney Tarrow e Charles Tilly, che analizzano le condizioni strutturali e i meccanismi di diffusione delle proteste.2. La Scintilla Inattesa
Occupy Wall Street ha sorpreso tutti, anche la polizia, per quanto è durata all’inizio. La polizia ha scelto di usare una repressione leggera, e questo ha permesso al movimento di diventare più forte. Nonostante la polizia provocasse e i giornali all’inizio fossero contro, l’occupazione è cresciuta velocemente grazie a diverse cose.I social media sono stati molto importanti. Hanno fatto vedere a tutti le immagini della polizia violenta, che i media tradizionali americani non potevano più ignorare, soprattutto perché in quel periodo c’erano proteste democratiche in tutto il mondo. La crisi economica del 2008 ha dato forza al movimento. Tanti giovani avevano debiti per l’università e non avevano speranze per il futuro. Questi giovani si sono riconosciuti nelle critiche di Occupy al sistema finanziario, che diceva che era sbagliato.Il movimento si è diffuso rapidamente perché tanta gente si sentiva trattata ingiustamente. Inoltre, a differenza di altri movimenti prima, Occupy non ha voluto partecipare alla politica tradizionale. Questa scelta radicale ha attirato l’appoggio di molte persone, anche dei lavoratori. Anche loro si sentivano precari come i giovani istruiti e hanno capito che avevano problemi simili. Occupy ha criticato in modo aperto la corruzione nel sistema, il ruolo dei soldi nella politica e un sistema economico che sembrava una truffa.Quando le persone hanno smesso di occupare i luoghi fisici, il movimento non è finito, ma è cambiato. La polizia ha represso le proteste in modo organizzato, i media hanno parlato male del movimento e anche chi era a favore ha smesso di sostenere Occupy. Tutto questo ha fatto finire le occupazioni. Però, l’idea di criticare il sistema e di mettere in discussione il potere dei soldi in politica è rimasta importante grazie a Occupy Wall Street. Il movimento ha fatto una domanda difficile: ma che cos’è davvero la politica e l’economia americana? Sembra che siano piene di corruzione e che le persone importanti non si facciano scrupoli.Se la scelta di Occupy Wall Street di non partecipare alla politica tradizionale è stata una strategia efficace, come si spiega la sua incapacità di tradurre la critica al sistema in cambiamenti politici concreti e duraturi?
Il capitolo presenta la scelta di Occupy di non partecipare alla politica tradizionale come un fattore di successo iniziale, ma non analizza le conseguenze a lungo termine di questa decisione. Per comprendere appieno i limiti e le potenzialità delle strategie di movimento sociale che rifiutano la politica istituzionale, è utile approfondire le teorie sui movimenti sociali e la scienza politica. Autori come Frances Fox Piven e Richard Cloward, con i loro studi sulle strategie dirompenti, o Charles Tilly, con le sue analisi dei repertori di azione collettiva, possono offrire strumenti concettuali utili per valutare criticamente le scelte strategiche di movimenti come Occupy Wall Street.3. Le Radici Nascoste della Democrazia
Occupy Wall Street, movimento di ispirazione anarchica, si inserisce nella tradizione democratica popolare americana. Questa tradizione è spesso osteggiata dalle correnti conservatrici. L’anarchismo non nega la democrazia, anzi, porta i suoi principi alle conseguenze più estreme. Spesso si fatica a comprendere questo concetto a causa di una manipolazione della parola “democrazia”. Oggi, infatti, “democrazia” descrive forme di governo create per evitare i cosiddetti “orrori della democrazia”. Questi “orrori” erano temuti da figure come John Adams.La Diffidenza dei Padri Fondatori verso la Democrazia Diretta
I Padri Fondatori americani non si fidavano della democrazia diretta ateniese. Per questo motivo, scelsero una repubblica rappresentativa. La repubblica rappresentativa era considerata un equilibrio tra monarchia, aristocrazia e democrazia. In questo sistema, governava un’aristocrazia naturale di persone elette. La democrazia diretta, con le sue assemblee popolari, era vista con sospetto. Si temeva che la “massa” potesse chiedere l’abolizione dei debiti e la ridistribuzione della proprietà.La Trasformazione del Significato di “Democrazia”
La parola “democrazia” ha cambiato significato nel tempo. All’inizio, “democrazia” era un termine negativo. Poi, è diventato uno strumento per la politica, perdendo il suo vero significato per la gente comune. Le persone comuni associavano la democrazia a libertà e uguaglianza. La storia più comune che viene raccontata identifica la democrazia con la “civiltà occidentale” e le sue istituzioni. Questa narrazione ignora le origini più profonde e diverse della democrazia.Le Origini Inaspettate del Sentimento Democratico
Le origini del pensiero democratico si possono trovare in luoghi inaspettati. Ad esempio, nelle comunità di pirati del Settecento, che erano organizzate in modo molto egualitario. Oppure, nelle comunità di frontiera americane, influenzate dalle società indigene. Questi gruppi, che non erano controllati dallo Stato, hanno provato forme di autogoverno basate sull’accordo di tutti e sulla partecipazione. Questi esempi offrono modi diversi di intendere la democrazia rispetto alla democrazia rappresentativa. L’anarchismo si presenta come un pensiero politico che vuole una società libera, basata sull’uguaglianza e sull’aiuto reciproco. L’anarchismo rifiuta la violenza e preferisce modi di organizzarsi orizzontali e basati sul consenso. Quindi, la vera democrazia non è solo votare. È piuttosto un processo in cui si decide insieme, dove tutti partecipano in modo equo e si usa la creatività democratica. Questi sono gli elementi fondamentali per costruire una società veramente libera.Ma il consenso, in pratica, non rischia di diventare un freno all’azione, specialmente quando l’urgenza richiede decisioni rapide e magari meno “ragionevoli”?
Il capitolo presenta il consenso come metodo decisionale ideale, quasi panaceistico, senza però affrontare adeguatamente le sfide concrete della sua applicazione. In contesti reali, la lentezza e la difficoltà di raggiungere un accordo unanime potrebbero paralizzare l’azione, soprattutto in situazioni che richiedono tempestività. Per comprendere meglio i limiti operativi del consenso, sarebbe utile approfondire gli studi di autori che si sono occupati di teoria delle decisioni e dinamiche di gruppo, analizzando come diversi modelli decisionali si adattano a contesti e urgenze differenti.5. Lo Svelamento delle Illusioni
Strategie delle forze dell’ordine nelle proteste
La strategia delle forze dell’ordine nelle azioni di protesta si rivela di natura politica. L’obiettivo principale è minimizzare i disagi causati dalle proteste e disperdere rapidamente le occupazioni. Spesso, le forze dell’ordine utilizzano la minaccia della forza come strumento di negoziazione. Questa tattica, però, può essere efficacemente contrastata dalla forza morale e dalla solidarietà dei manifestanti. Le azioni di strada possono essere viste come una forma di conflitto. In questo contesto, la creatività e l’improvvisazione diventano strumenti tattici fondamentali per i manifestanti, capaci di sorprendere le forze dell’ordine, che spesso agiscono in modo rigido e prevedibile.Le occupazioni come strategia di potere duale
Le occupazioni rappresentano una strategia per creare un “dualismo di poteri”. Con le occupazioni, si creano spazi autonomi che si pongono al di fuori delle strutture politiche ed economiche esistenti. Sono state adottate diverse strategie di occupazione in vari contesti. Alcuni esempi includono la creazione di istituzioni alternative, la negoziazione di spazi di autonomia con le autorità, e la delegittimazione del sistema politico esistente. Un esempio significativo è Occupy Wall Street, che ha utilizzato la strategia di delegittimazione, sfruttando la diffusa sfiducia nei confronti del sistema politico ed economico americano.Rivoluzioni e trasformazione del senso comune
Le rivoluzioni sono processi che trasformano profondamente il modo di pensare comune, mettendo in discussione le basi stesse della politica e della società. Per costruire una società più libera e giusta, è essenziale mettere in discussione alcune idee che sono profondamente radicate nella nostra cultura. Tra queste, troviamo l’etica produttivista, che esalta il lavoroFine a sé stesso, la natura alienante del lavoro burocratico e una visione negativa del comunismo. È fondamentale cambiare prospettiva su questi temi. Dobbiamo iniziare a considerare il lavoro come un’attività che mira al benessere di tutti, ridurre il peso eccessivo della burocrazia e recuperare il vero significato del comunismo, inteso come principio di condivisione e aiuto reciproco.Obiettivo finale: una società basata su consenso e diversità
L’obiettivo finale di questi cambiamenti è la creazione di una società dove il consenso e il rispetto per le differenze siano i valori fondamentali. In una società ideale, tutti dovrebbero avere la possibilità di realizzare i propri ideali e aspirazioni. L’uguaglianza, in questo senso, significa garantire a tutti un accesso equo alle risorse necessarie. La vera libertà individuale si manifesta nella capacità di definire e perseguire i propri valori, che sono molteplici e non possono essere ridotti a semplici numeri. Per raggiungere questi obiettivi, è necessario trasformare il modo di pensare comune e risvegliare l’immaginazione collettiva. Queste forze possono generare cambiamenti rivoluzionari, capaci di modificare anche le realtà politiche più solide e apparentemente immutabili.Ma è davvero così semplice sovvertire un sistema politico ed economico delegittimato, come suggerisce il capitolo?
Il capitolo sembra presentare una visione delle dinamiche di potere e del cambiamento sociale forse eccessivamente ottimistica e lineare. L’idea che la delegittimazione del sistema esistente, unita alla “forza morale” e alla “creatività” dei manifestanti, sia sufficiente a generare un “dualismo di poteri” e una trasformazione rivoluzionaria, potrebbe sottovalutare la complessità delle forze in gioco. Per una comprensione più articolata delle dinamiche rivoluzionarie e delle strategie di potere duale, sarebbe utile approfondire il pensiero di autori come Gene Sharp, che ha analizzato in dettaglio le dinamiche della lotta nonviolenta e le condizioni per il successo di movimenti di resistenza civile, o studiare le opere di politologi come Giovanni Sartori, per comprendere meglio le dinamiche dei sistemi politici e le sfide alla loro trasformazione.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]