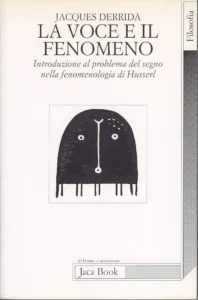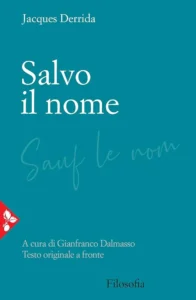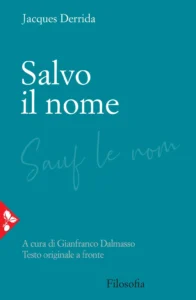1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Pensare al non vedere. Scritti sulle arti del visibile” di Jacques Derrida non è il solito libro sull’arte. Dimentica l’idea che l’arte sia solo “visiva”. Derrida usa la decostruzione per farci vedere che le “arti dello spazio”, come la pittura o l’architettura, funzionano come testi, pieni di tracce e segni che non sono sempre visibili. È un viaggio che esplora come il disegno sia legato alla cecità, come la firma di un artista sia più complessa del semplice nome, e come l’invisibile sia fondamentale per capire ciò che vediamo. Attraverso l’analisi di opere e artisti, dalla pittura al disegno, dalla fotografia al cinema e persino all’architettura, il libro ci mostra che l’immagine, la memoria e la testimonianza sono intrecciate in modi sorprendenti, spesso spettrali. Non è solo teoria, ma un modo per ripensare l’esperienza stessa dell’arte e del guardare, sfidando le nostre idee su cosa significa vedere e cosa significa creare. È un invito a guardare oltre la superficie, nel “sotto” delle opere, e a capire che anche nel visibile c’è sempre un po’ di non vedere.Riassunto Breve
L’applicazione della decostruzione all’arte sposta l’attenzione dal primato della vista e del discorso, tipici del pensiero occidentale, verso le “arti dello spazio”, che includono anche l’invisibile e sono considerate arti dei ciechi. Le opere d’arte, anche quelle non verbali come pittura e architettura, possiedono una struttura testuale data dalla spaziatura e si inseriscono in una rete di riferimenti. Il concetto di “testo” si amplia oltre il discorso, mostrando l’operatività della decostruzione anche in campi non verbali. La firma di un’opera è l’evento stesso dell’opera, la sua traccia, che richiede una “controfirma” sociale e istituzionale per essere riconosciuta come arte pubblica. Il linguaggio non è solo significato, ma ha un “corpo” non discorsivo legato al tono, connettendosi alle arti non verbali. L’arte è vista come una forma di “pensiero” che resiste all’egemonia della filosofia. La decostruzione non distrugge, ma è condizione per l’invenzione, mettendo in discussione le fondamenta esistenti. Il pensiero occidentale privilegia vista, presenza e parola parlata, ma questa centralità si basa su uno scarto, un intervallo, il “tratto” o “traccia”, che rende possibile la visibilità ma in sé non è visibile. L’esperienza autentica è l’incontro inatteso con l’altro radicale. Il disegno lavora con questo tratto differenziale, essendo un’esperienza in parte “cieca”, non basata sulla visione immediata. L’illustrazione trasforma, usando il tratto per legare visibile e leggibile. Il tratto, sottratto alla piena visibilità, mantiene un aspetto segreto che offre resistenza. La cecità è centrale nel disegno; il disegnatore si affida alla mano, brancolando nell’invisibile. L’atto del disegnare implica un non vedere, basandosi sulla memoria. Il tratto stesso produce visibilità ma si sottrae allo sguardo. L’autoritratto evidenzia questa cecità: l’occhio che vede non si vede. L’identificazione di un autoritratto richiede un’indicazione esterna. La storia del disegno è legata alla memoria e all’apprensione della cecità, come nella leggenda di Butade. L’opera di Colette Deblé esplora questa relazione con il lavis, citando e rigenerando immagini storiche. L’esperienza del disegno, come la lettura, implica un non vedere. L’espressione “salvare i fenomeni” si esplora nell’arte che inserisce le parole nello spazio visivo, rendendo la parola una “cosa” intraducibile. Il disegno va oltre la rappresentazione, designa, firma, insegna, è un percorso di trasmissione. La mano che disegna è centrale, guidata da un processo che cerca la forma e culmina in un punto critico. L’opera, una volta finita, si separa dal creatore. La pittura di Atlan affronta il sublime, legandosi al divieto di immagini e al silenzio. Il “dessous”, il supporto fisico, è fondamentale per l’unicità e l’originalità dell’opera, permettendone l’autonomia e la circolazione. L’opera provoca un impatto emotivo, una visita inattesa. La fotografia rivela la verità (aletheia) attraverso luce e ombra, fissando eventi unici. Le immagini della diaspora mostrano come l’identità si mantenga nell’esilio, mescolando antico e moderno. La testimonianza è centrale, specialmente per l’irrappresentabile come la Shoah; fotografie e video fungono da testimoni. Il video sfida le definizioni tradizionali, esplorando immagine, testo e soggetto. Le immagini visive iscrivono e rivelano aspetti complessi della storia e dell’identità. Le tecniche moderne intensificano l’esperienza dei fantasmi, operando su una struttura fantomatica. L’epoca attuale trasforma il posto della scrittura, introducendo nuove strutture testuali e di tele-scrittura. La gestione politica delle tecnologie richiede di sviluppare il potenziale senza sacrificare i media esistenti, conciliando pubblico e privato. Il cinema è un’arte spettrale, legata alla psicoanalisi e a una singolare modalità di credenza. È l’arte popolare per eccellenza, unendo emozione e riproducibilità. Il teatro è legato alla visibilità e al sacrificio, offrendo uno spazio alternativo per il discorso politico, mescolando tempi e forme. Spettri e teatro si legano al lavoro del lutto politico e alla virtualizzazione dell’eredità. L’immagine filmata, pur potente, non ha valore legale di prova come la parola scritta. La forza di Shoah sta nella presentazione senza rappresentazione della parola testimoniale. La registrazione della voce è cruciale, dando alla presenza viva una nuova possibilità di “esserci”. Il montaggio nel cinema è paragonabile alla decostruzione nella scrittura. Le tecnologie digitali avvicinano scrittura e montaggio. L’immagine è iscrizione e confisca della memoria, conservazione e interpretazione violenta; gli archivi sono iniziative di potere. L’eredità spettrale, come quella di Marx, solleva domande sull’ereditare e sul nome. Il teatro esplora la crisi della rappresentazione politica. Lo spettro si lega alla virtualizzazione del capitale e alla realtà artefatta dei media. L’immagine di sé è definita dagli altri, creando molteplici volti. Esiste una resistenza a essere intrappolati, un sentirsi “sopravvissuti in sospensione”, trovando forza nelle contraddizioni tra passato e presente, in relazione con l’altro e il tempo disarticolato.Riassunto Lungo
1. Oltre il visibile: l’arte come testo e firma nello spazio
L’applicazione della decostruzione alle arti porta a superare l’idea che la vista e il discorso siano al centro della comprensione, come spesso accade nella filosofia occidentale. L’attenzione si sposta dalle “arti visive” alle “arti dello spazio”. Questo cambiamento è importante perché lo spazio non è percepito solo attraverso la vista; include anche ciò che non si vede. Per questo motivo, le arti spaziali sono considerate anche arti accessibili a chi non vede.L’opera d’arte come testo nello spazio
Anche le opere d’arte che non usano parole, come un quadro o un edificio, hanno una struttura simile a un testo. Il modo in cui gli elementi sono disposti nello spazio crea una sorta di “testualizzazione”, anche senza un vero discorso. Le opere d’arte non esistono da sole, ma si inseriscono in una rete di differenze e relazioni con altre opere e contesti. Allargare il concetto di “testo” in questo modo è cruciale e dimostra che la decostruzione non si applica solo a scritti o discorsi, ma agisce anche in ambiti che sembrano non verbali, rivelando la loro complessa struttura interna.La firma e la controfirma dell’opera
La firma di un’opera d’arte non è semplicemente il nome dell’artista. È l’evento unico dell’opera stessa, il suo esistere nel mondo come una traccia irripetibile. Tuttavia, questa “firma” da sola non basta per fare di un oggetto un’opera d’arte riconosciuta. Richiede una “controfirma” da parte della società, delle istituzioni e del pubblico. L’opera d’arte è per sua natura pubblica; non esiste un’arte che rimanga completamente privata. Questo processo di riconoscimento sociale (la controfirma) precede in un certo senso la firma dell’artista, creando una relazione complessa e non lineare nel tempo.Il corpo del linguaggio e l’arte come pensiero
Anche il linguaggio gioca un ruolo particolare. Le parole non sono solo strumenti per trasmettere significati chiari e definiti. Possiedono un “corpo”, un aspetto non legato al significato esplicito, ma al tono, al suono, al ritmo, che le connette alle arti che non usano parole. L’arte è vista come una forma di “pensiero” che va oltre la filosofia tradizionale. Resiste al dominio della filosofia e stimola nuove riflessioni e modi di comprendere il mondo, mostrando che il pensiero può manifestarsi in forme diverse dal discorso razionale.La decostruzione come condizione per l’invenzione
In questo contesto, la decostruzione non significa distruggere, ma è una condizione necessaria per creare e inventare qualcosa di nuovo. Permette di mettere in discussione le basi su cui si fondano le idee e le pratiche esistenti, aprendo la strada a nuove possibilità. Questa forza che mette in discussione le strutture consolidate è attiva in molti campi, non solo nelle discussioni teoriche o accademiche, ma anche nelle istituzioni che si occupano d’arte e nelle pratiche artistiche stesse, spingendo continuamente verso il rinnovamento e la trasformazione.Se l’arte non esiste in privato, come si distingue un oggetto qualsiasi da un’opera d’arte prima che la società la ‘controfirmi’?
Il capitolo afferma che l’opera d’arte non può esistere in privato e necessita di una “controfirma” sociale per essere riconosciuta. Questa posizione, pur evidenziando il ruolo cruciale del contesto e delle istituzioni, lascia aperta la questione di cosa renda un oggetto “arte” nel momento stesso della sua creazione, prima del riconoscimento pubblico. Per approfondire questo dibattito, è utile esplorare la filosofia dell’arte, in particolare le teorie che riguardano la definizione di arte, il ruolo dell’intenzione dell’artista e il rapporto tra opera e contesto. Autori come Arthur Danto o Nelson Goodman offrono prospettive diverse su questi temi.2. Il tratto invisibile e l’esperienza inattesa
Il pensiero occidentale ha da tempo privilegiato la vista, la presenza immediata e la parola parlata rispetto ad altri modi di percepire e comunicare. Questa preferenza si manifesta in concetti come l’idea platonica, l’intuizione intesa come visione diretta e l’idea di verità come svelamento di ciò che è nascosto. Questo orientamento, che valorizza ciò che è presente e visibile o udibile, è stato definito logocentrismo o fonocentrismo. Tuttavia, questa centralità della vista è spesso sostenuta, in modo non dichiarato, da un privilegio del tatto. L’esperienza della verità si esprime spesso attraverso figure di contatto e vicinanza.Il Tratto: Lo Spazio Nascosto
Sia la vista che il tatto, nonostante sembrino esperienze dirette, si basano su uno scarto, un intervallo, una spaziatura. Questa spaziatura è ciò che viene chiamato il “tratto” o la “traccia”. È un elemento che crea differenza e rende possibile la percezione, sia essa visiva o tattile. Eppure, questo tratto in sé non è né pienamente visibile né pienamente tangibile. È come uno spazio nascosto che permette alle cose di apparire e di essere toccate.L’Esperienza Autentica e Imprevedibile
L’esperienza autentica, quella che ci segna davvero, non è qualcosa che vediamo arrivare lentamente, come un evento previsto all’orizzonte. È piuttosto ciò che irrompe in modo improvviso e inatteso. È un incontro con qualcosa di radicalmente altro, qualcosa che non potevamo prevedere o inglobare nelle nostre aspettative. Questo tipo di esperienza va oltre le nostre solite categorie di chi percepisce (soggetto) e cosa viene percepito (oggetto). Non si basa sulla capacità di anticipare o controllare, ma sull’apertura a ciò che viene, anche se imprevedibile.Il Tratto nel Disegno e nell’Illustrazione
Il disegno lavora proprio con questo tratto differenziale, con questo spazio che rende possibile la forma ma che sfugge alla piena visibilità. L’atto del disegnare, nel suo momento più creativo, è un’esperienza che è in un certo senso “cieca”, non si basa sulla semplice riproduzione di un oggetto che si ha già davanti agli occhi. L’illustrazione, intesa nel suo senso più profondo, non è una semplice copia visiva di un testo scritto. È invece una trasformazione che usa il tratto per creare un legame forte tra ciò che si vede e ciò che si legge. Anche se questo legame è inseparabile, mantiene una differenza tra i due elementi. Questo processo non si limita a mostrare ciò che è già noto, ma usa gli elementi del testo o dell’immagine come strumenti per aprire nuove possibilità e nuovi significati.Tratto, Politica e Decostruzione
Il tratto, proprio perché non è completamente visibile o afferrabile, conserva un aspetto nascosto o segreto. Questa sua capacità di resistere alla piena esposizione e alla trasparenza totale ha una rilevanza anche nello spazio politico. Offre una forza di resistenza contro il controllo e la pubblicità assoluta, creando uno spostamento o una messa in discussione del modo in cui intendiamo la politica. L’approccio chiamato decostruzione si occupa proprio di indagare questa logica del tratto e della traccia, mettendo in discussione le opposizioni tradizionali e le gerarchie che ne derivano.Ma siamo sicuri che un concetto così sfuggente e “invisibile” come il “tratto” possa davvero fare da fondamento all’esperienza concreta e persino alla critica politica?
Il capitolo introduce il “tratto” come elemento fondamentale per la percezione, definendolo però in termini negativi (né visibile né tangibile). Questa sua natura astratta rende difficile afferrare il suo ruolo concreto nell’esperienza sensibile. Inoltre, il capitolo collega questo concetto a implicazioni politiche e a un approccio filosofico specifico (la decostruzione) senza forse esplicitare a sufficienza il percorso logico che lega l’esperienza percettiva fondamentale a queste sfere più ampie. Per comprendere meglio questa argomentazione, è utile approfondire la filosofia contemporanea, in particolare il pensiero di autori come Jacques Derrida, che ha elaborato concetti come “traccia” e “differanza”, e studiare come questi concetti astratti vengano applicati all’analisi del linguaggio, della percezione e delle strutture sociali e politiche.3. La Cecità al Cuore del Segno
Il disegno è strettamente legato all’esperienza della cecità. Chi disegna, proprio come chi non vede, si affida al tatto della mano per capire lo spazio e rappresentare ciò che è visibile. La mano si muove in un’area che non si vede, ed è da questo movimento nell’invisibile che nasce il disegno. L’interesse di chi disegna per le persone cieche, per gli occhi feriti o mancanti, e per le mani, dimostra quanto questa riflessione sulla propria condizione sia centrale.Il Disegno come Atto di Non-Vista
L’atto stesso del disegnare implica una forma di non vedere. Anche quando si guarda attentamente un soggetto, il disegno che ne deriva non è una copia esatta di ciò che si percepisce in quell’istante, ma si basa su ciò che si ricorda o si elabora. La linea, il segno che usiamo per separare e definire le forme, non si vede di per sé; è qualcosa che crea la visibilità, ma che resta invisibile allo sguardo. L’esperienza del disegno è, in questo senso, un viaggio che attraversa l’idea di accecamento.L’Autoritratto e lo Sguardo Nascosto
L’autoritratto mette in evidenza questa cecità intrinseca. Un artista che cerca di disegnare il proprio sguardo non può vederlo nel momento stesso in cui sta guardando. L’occhio che vede non è visibile a sé stesso. Riconoscere un disegno come un autoritratto non dipende solo da quello che si vede nell’immagine, ma richiede un’informazione esterna, come un titolo o un riferimento. Chi guarda l’autoritratto, prendendo il posto dello specchio, rende in un certo senso opaca l’immagine riflessa, come se accecasse l’artista che si sta ritraendo.La Memoria e l’Assenza
La storia del disegno è profondamente connessa alla memoria e all’idea di affrontare la cecità, come racconta l’antica leggenda di Butade. Si narra che Butade disegnò il profilo dell’ombra del suo amante prima che lui partisse, creando così un’immagine per non dimenticare colui che non avrebbe più visto.Esplorare la Visione nell’Arte Contemporanea
L’opera di Colette Deblé, che usa la tecnica del lavis (disegno dilavato), esplora a fondo questa relazione tra disegno, fluidità, memoria e creazione. I suoi disegni di corpi femminili, spesso rielaborazioni di opere d’arte del passato, usano l’acqua per “impregnare” e “imprimere” le forme, facendo nascere nuove immagini da quelle già esistenti. Questo modo di “citare” attraverso l’uso dell’acqua è una forma di rinascita, un modo per vedere “attraverso” le immagini storiche. Il suo lavoro è un processo di “sericitazione”, che unisce l’idea di serie e quella di citazione, dove ogni disegno, pur richiamando opere precedenti, mantiene la sua identità unica.L’esperienza del disegno, come quella della lettura, implica un non vedere: leggere significa percepire il significato delle parole senza soffermarsi sulla loro forma grafica essenziale. Disegno, vista, parola e lettura si intrecciano in un’esperienza complessa che include sempre una dimensione di accecamento, un punto in cui la visione diretta si ritira per lasciare spazio ad altre forme di percezione e creazione.Il “fantasma” di Marx è uno strumento analitico o un’evocazione letteraria che rischia di appiattire la complessità?
Il capitolo intreccia il concetto di spettro per legare eredità politica, spazio teatrale, economia virtuale e identità personale. Sebbene suggestivo, questo approccio potrebbe beneficiare di una maggiore distinzione tra metafora e analisi rigorosa. Per esplorare queste connessioni con più profondità, si potrebbero considerare studi specifici sulla teoria critica, la sociologia del teatro, le trasformazioni del capitalismo finanziario e le teorie dell’identità nell’era digitale. Autori come Derrida o studiosi di economia politica contemporanea potrebbero offrire prospettive più articolate.9. Tracce e Incontri: Derrida tra Scritti e Immagini
Si trovano articoli e interviste, ma anche partecipazioni a film e trasmissioni televisive. Questo materiale documenta la vasta presenza di Derrida in diversi ambiti culturali e mediatici.Articoli e Interviste
Una parte importante di questi scritti e conversazioni riguarda l’architettura. Ci sono dialoghi con architetti come Peter Eisenman e Daniel Libeskind, e interventi in eventi di settore come la Biennale di Architettura o su riviste specializzate. Altre interviste toccano temi diversi, dalla filosofia all’arte, dalla fotografia a discussioni su specifiche figure culturali. Queste conversazioni avvengono con vari interlocutori, sia in contesti accademici che mediatici, dimostrando la capacità di Derrida di confrontarsi con pubblici e argomenti differenti.Film e Televisione
Le apparizioni video includono diverse forme, dai documentari alle interviste filmate e ai progetti multimediali. Si trova in film che esplorano il suo pensiero, l’architettura (come Deconstructivist Architects), o temi sociali e culturali più ampi. Partecipa anche a trasmissioni televisive e video di conferenze o dibattiti pubblici, offrendo spunti e riflessioni in vari contesti. Sono registrate queste presenze in archivi specifici, rendendo accessibile la sua immagine e la sua voce oltre i testi scritti.Affermare che Derrida fosse presente in film e interviste basta a documentare la sua “vasta presenza” culturale, o si rischia di ridurre il suo complesso pensiero a mere apparizioni mediatiche, ignorando il dibattito (e le resistenze) che tali incursioni hanno generato?
Il capitolo si limita a elencare le diverse piattaforme mediatiche e i temi toccati da Derrida, ma non approfondisce il contenuto specifico di questi interventi né la loro ricezione, in particolare in ambiti controversi come l’architettura. Per comprendere veramente il significato di queste “tracce”, è fondamentale esplorare il dibattito critico che ha accompagnato le incursioni di Derrida in campi non strettamente filosofici. Approfondire la teoria architettonica contemporanea e gli studi culturali può offrire il contesto necessario. Autori come Bernard Tschumi o Peter Eisenman, che hanno dialogato con Derrida, o studiosi che hanno analizzato la decostruzione nell’architettura, possono fornire spunti cruciali.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]