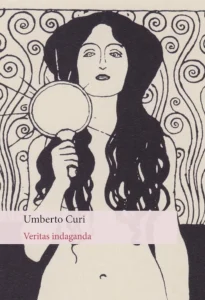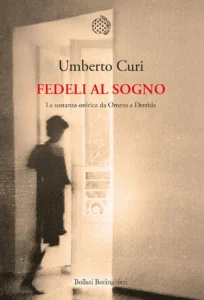1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Parlare con Dio. Un’indagine fra filosofia e teologia” di Umberto Curi ci porta in un viaggio affascinante attraverso i testi sacri e le interpretazioni che hanno plasmato la nostra comprensione del divino e dell’umano. Il libro esplora come la parola di Dio, trasmessa e tradotta, arrivi a noi attraverso figure chiave come Mosè e Giobbe, mettendo in discussione la giustizia retributiva e aprendo la strada a un rapporto più profondo e personale con Dio, anche di fronte alla sofferenza inspiegabile. Ci immergiamo poi nella fede di Abramo, la cui obbedienza radicale sul monte Moriah, dove è chiamato a sacrificare Isacco, rappresenta un superamento della ragione e della legge, un credere nell’assurdo che anticipa la logica cristiana. Questo percorso ci conduce attraverso le beatitudini di Matteo, che propongono una felicità che va oltre il mondo, e la misericordia cristiana, un’azione attiva che rende prossimo chiunque, anche lo straniero o il nemico, come dimostra la parabola del Samaritano. Il libro analizza anche il perdono, che rompe la logica del “occhio per occhio”, e il concetto di kairós, l’attimo opportuno della rivelazione divina, contrapposto al tempo lineare. La Passione di Cristo viene indagata come un dolore redentivo che eccede il linguaggio umano, esplorando come arte, musica e cinema abbiano cercato di rappresentarne l’ineffabile mistero, da Giotto a Pasolini, fino alla musica di Bach. Infine, il silenzio, inteso non come assenza ma come pienezza d’ascolto, e il grido di interrogazione, come quello di Giobbe, emergono come vie per un incontro trasformativo con Dio, in un dialogo continuo tra fede, amore e ragione che sfida le nostre concezioni del tempo, dell’errore e della stessa morte divina.Riassunto Breve
La trasmissione della parola divina, come le “dieci parole” date a Mosè, non arriva direttamente al popolo ma attraverso mediazioni umane, implicando una perdita rispetto all’originale inaccessibile e riflettendo i limiti dell’uomo. La vicenda di Giobbe mette in crisi l’idea di giustizia retributiva, dove la sofferenza è vista come punizione per il peccato. Giobbe, giusto e innocente, soffre immensamente e non si rassegna, ma grida e desidera contendere direttamente con Dio, spostando l’attenzione dal parlare *di* Dio al parlare *a* Dio. Il suo coraggio sfida la logica della retribuzione e apre a un rapporto di fiducia anche nell’inspiegabile dolore. Abramo rappresenta una fede che supera la giustizia retributiva e la ragione. La sua prova sul monte Moriah, la richiesta di sacrificare Isacco, sfida ogni logica; la sua risposta “eccomi!” è obbedienza come ascolto attivo. La fede di Abramo è un paradosso, credere nell’assurdo, un doppio movimento di rinuncia e riappropriazione. L’interpretazione cristiana, come quella di Paolo, vede la fede di Abramo nel credere nella resurrezione, collegandola a Cristo e ponendolo come padre della fede cristiana, distinta dalla legge giudaica e basata sulla grazia e l’accettazione del paradosso. Il viaggio al Moriah simboleggia il passaggio dalla legge (cammino orizzontale) alla fede (ascesa verticale). Le beatitudini presentano una logica non mondana: la felicità piena (*makárioi*) è attuale, la mitezza (*praótes*) non si conforma alla logica politica e i miti ereditano la terra in un capovolgimento dei valori comuni. La misericordia cristiana non è solo sentimento ma movimento attivo verso l’altro; il prossimo (*plesíos*) è chi viene avvicinato con compassione, come mostra il Samaritano che si muove *verso* l’uomo ferito. Il perdono (*per-donare*) rompe la logica della retribuzione (“occhio per occhio”), andando oltre la necessità di pena, come nell’episodio dell’adultera dove Gesù manifesta sovrabbondanza di misericordia. Il tempo della rivelazione cristiana (Apocalisse) è l’attimo opportuno (*kairós*) già presente, un “svelamento” (*apokalýpsis*) che richiede decisione immediata. Il “discorso duro” di Gesù lega pane terreno e celeste, vita materiale e spirituale, richiedendo impegno radicale, ma la misericordia divina è sovrabbondante anche per chi inciampa. La Passione di Cristo è dolore redentivo, unico. Il linguaggio verbale (*logos*) è insufficiente a esprimere la sua ambivalenza e mistero; altre forme espressive come arte, musica e cinema cercano di renderla visibile. Tentativi di rappresentazione diretta e quantitativa (come in alcuni film) falliscono nel cogliere la forza redentrice, riducendola a strazio. Approcci che rarefanno la parola e usano musica e arte visiva (come Pasolini) mostrano l’ineffabilità del mistero, la Passione come morte di Dio eccede la capacità del linguaggio umano. L’unica parola che resta è “Figlio”, rimandando alla condizione umana e a Cristo. Questo limite nella rappresentazione riflette il paradosso del parlare di Dio, non manifesto ma compiuta manifestazione. Il dialogo tra fede e ragione richiede riconoscimento di questo limite umano. Esistono diverse forme di silenzio: *tacere* (assenza di suono) e *silere* (condizione attiva di ascolto). Il silenzio biblico è *tacere* davanti a Dio per ascoltare, base dell’obbedienza (“ascoltare attentamente”). Il silenzio positivo è pienezza, base per ascolto autentico e responsabilità (rispondere a una chiamata). La vita monastica vive il *silere*, con un tempo diverso (*chrónos* non lineare) che permette ricerca interiore e ascesi (esercizio attivo per valorizzare sé e aprirsi al divino). Giobbe, uomo giusto che soffre, interroga Dio con un grido, mettendo in crisi la visione tradizionale. Dio risponde da un turbine, mostrando grandezza e mistero, non spiegando la sofferenza ma parlando *con* Giobbe, portandolo da un sapere per sentito dire a un vederlo direttamente. Sofferenza e grido conducono a conoscenza profonda, oltre logica umana. Silenzio di ascolto e grido di interrogazione sono vie per incontro trasformativo. La fede non è comprensione immediata, si manifesta in figure come Giobbe e Abramo. L’obbedienza è ascolto profondo che porta all’azione (*ob-audire*, *ypó-akoúein*). Abramo obbedisce anche alla richiesta di sacrificare Isacco, una “sospensione teleologica dell’etico” dove il comando divino supera la legge morale. La fede di Abramo è credere contro ogni speranza, fidandosi della promessa divina nonostante l’impossibile. L’Epistola agli Ebrei interpreta la sua disponibilità come fede nella risurrezione. La fede si distingue dalla conoscenza razionale, si rapporta al paradosso ed è certezza alta, non immediatezza infantile ma possibilità intravista dopo riflessione. Il Cristianesimo introduce l’amore radicale per il prossimo, inclusi i nemici, superando l’amore per chi è amabile. Questo amore incondizionato (*agape*) non abolisce la legge ma la compie, andando oltre la giustizia retributiva. La giustizia si ottiene per grazia mediante fede in Cristo, non per legge. La fede libera dalla maledizione della legge e unisce a Cristo. L’amore del prossimo è compimento della legge, reso possibile da grazia e fede. Dio stesso è amore, fondamentale per la fede cristiana. Il pensiero antico distingue sventure casuali (*atychèmata*), errori non intenzionali (*hamartèmata*) e azioni ingiuste deliberate (*adikèmata*). Il diritto greco classico sanziona diversamente a seconda dell’intenzione, differenziandosi dalla stretta retribuzione (“occhio per occhio”). Il perdono è una risposta che va oltre la logica retributiva. Il tempo non è solo successione lineare (*Chronos*) ma include momenti decisivi (*Kairos*), il tempo opportuno legato alla rivelazione, dove ciò che è nascosto viene alla luce, generando anche divisione. Concetti apocalittici riflettono l’importanza del momento decisivo. Azioni umane ed errori si collocano in queste dimensioni del tempo e della risposta. Sistemi legali valutano colpe, ma esiste il perdono. Il tempo è segnato da momenti cruciali che alterano eventi e rivelano verità nascoste, con possibili separazioni o giudizi. La Passione di Cristo è ampiamente rappresentata in cultura, basata sui Vangeli. Iconografia e pittura esplorano la sofferenza e morte (es. Giotto). Si descrivono i colpi subiti da Gesù e il rapporto tra sofferenza e conoscenza. Interpretazioni artistiche recenti includono cinema (Pasolini, Vangelo secondo Matteo, La ricotta) dove musica (Bach, Passione secondo Matteo) ha ruolo. La musica classica offre espressione per la Passione.Riassunto Lungo
1. La Parola Tradotta e la Contesa dell’Uomo
La trasmissione della parola divina
Le “dieci parole” non sono solo comandi, ma raccontano l’incontro tra il Signore e Mosè. Non arrivano direttamente al popolo, ma passano attraverso Mosè. Anche la loro forma scritta subisce dei cambiamenti, come quando le prime tavole vengono rotte e ne vengono scritte di seconde. Questo modo di trasmettere e “tradurre” il messaggio implica che qualcosa si perde; la parola di Dio nella sua forma originale non può essere raggiunta. Le parole che arrivano a noi mostrano più i limiti degli esseri umani che la vera volontà o l’identità di Dio.La sfida di Giobbe alla giustizia
La storia di Giobbe mette in discussione l’idea che la sofferenza sia sempre una punizione per il peccato. Giobbe è un uomo giusto che affronta terribili sventure pur non avendo commesso colpe, e questo mette in crisi la credenza nella giustizia retributiva. I suoi amici continuano a sostenere che lui sia colpevole, ma Giobbe non accetta di confessare peccati che non ha commesso e afferma la sua innocenza. La sua reazione non è quella di accettare passivamente, ma di esprimere la sua sofferenza e il desiderio di confrontarsi direttamente con Dio. Questo confronto cambia la prospettiva: non si tratta più di parlare su Dio, ma di parlare a Dio. La forza di Giobbe sta nel suo coraggio di sfidare Dio, andando oltre la semplice logica del merito e della punizione. Questo apre la strada a un rapporto con Dio basato sulla fiducia, anche quando il dolore non trova spiegazione. Questa sfida segna un cambiamento importante, superando la visione tradizionale e offrendo un modo diverso di capire la sofferenza.Se la parola divina è intrinsecamente inafferrabile nella sua forma originale a causa dei limiti umani nella trasmissione e traduzione, come possiamo essere certi che le interpretazioni successive, inclusa quella presentata nel capitolo, non siano anch’esse viziate da tali limiti, distorcendo ulteriormente il messaggio divino?
Il capitolo suggerisce che la trasmissione della parola divina, passando attraverso intermediari umani e subendo modifiche, porta inevitabilmente a una perdita e a una distorsione del messaggio originale. Tuttavia, non viene fornito un criterio chiaro per distinguere tra le inevitabili “perdite” e le distorsioni che potrebbero compromettere l’essenza del messaggio stesso, né viene affrontata la questione di come le diverse traduzioni e interpretazioni possano coesistere o confliggere. Per approfondire questo aspetto, sarebbe utile esplorare discipline come la filologia, la semiotica e la teoria della traduzione, consultando opere di studiosi come Umberto Eco, che ha ampiamente trattato il tema della traduzione e dell’interpretazione.2. La Fede che Supera il Mondo
Abramo incarna una fede che va oltre la semplice idea di giustizia, quella per cui si riceve in base a ciò che si fa. La sua fede non si basa sulla logica umana o sulla ragione comune. Questo è evidente nella prova che affronta sul monte Moriah, dove gli viene chiesto di sacrificare suo figlio Isacco. È una richiesta che sfida ogni comprensione razionale e ogni legge. La sua risposta “eccomi!” non è solo accettazione passiva, ma un’obbedienza profonda, intesa come un ascolto attivo e libero, un “ascoltare stando di fronte” a Dio. La fede di Abramo è un vero paradosso: trasforma quello che sembrerebbe un atto terribile in un gesto sacro, iniziando proprio dove la ragione umana si ferma. Questa fede non è facile; implica angoscia e un grande rischio, un credere anche nell’assurdo. È un movimento complesso che richiede sia di lasciare andare qualcosa sia di riappropriarsene in modo nuovo.La Fede Cristiana e la Legge
L’interpretazione cristiana, come quella proposta dall’apostolo Paolo, vede nella fede di Abramo un significato ancora più profondo. Paolo interpreta la vicenda credendo che Abramo avesse fede nel fatto che Dio potesse persino riportare in vita Isacco. Questo collega direttamente la storia di Abramo alla resurrezione di Cristo, posizionando Abramo come una figura fondamentale non solo per l’ebraismo, ma come padre della fede in un senso specificamente cristiano, che va oltre i confini del Primo Testamento. La fede cristiana si distingue in modo netto dalla legge giudaica. Non si fonda sull’osservanza di regole o precetti, ma sulla grazia divina e sull’accettazione di ciò che sembra impossibile o contraddittorio. Pensiamo all’idea che Dio si sia fatto uomo e abbia vissuto nel tempo, o al comando di amare i propri nemici: sono concetti che vanno contro la logica comune del mondo.Il Simbolo del Viaggio verso Moriah
Il viaggio di Abramo verso il monte Moriah diventa un simbolo potente di questa differenza tra la logica del mondo e quella della fede. Il cammino che si svolge in orizzontale rappresenta la legge e il modo di pensare tipico del mondo terreno, fatto di regole e scambi. L’ascesa verticale verso il monte, invece, simboleggia la fede che eleva l’uomo e lo porta all’incontro con Dio. Questo passaggio dal piano orizzontale a quello verticale indica un cambiamento radicale, un vero e proprio capovolgimento del modo di vedere la realtà e di agire. È un movimento che lascia indietro la logica terrena per abbracciare quella divina.Le Beatitudini: Una Felicità non del Mondo
Un altro esempio di questa logica che non appartiene al mondo si trova nelle beatitudini presentate nel Vangelo di Matteo. Essere definiti “beati”, usando la parola greca makárioi, significa godere di una felicità piena e completa, che è attuale, non qualcosa che si riceverà solo in futuro come ricompensa. Tra queste beatitudini, spicca quella che riguarda la mitezza (praótes). La mitezza è una virtù che non si adatta per nulla alla logica della politica, che è spesso vista come legata al conflitto, alla competizione e all’uso della forza. I miti, si dice, erediteranno la terra; ma questa eredità non la otterranno attraverso mezzi politici, guerre o lotte di potere. La riceveranno in un modo che si trova al di beyond di queste categorie terrene, in un completo capovolgimento dei valori che il mondo considera importanti. La fede e le virtù che vengono dalla prospettiva cristiana si pongono quindi in netto contrasto con la saggezza e le strutture di potere del mondo comune.Se la fede di Abramo implica un credere nell’assurdo e un capovolgimento della logica umana, come si concilia questo con la necessità di un’obbedienza “libera” e “attiva”, e non meramente passiva, di fronte a un comando divino che sfida ogni razionalità e legge?
Il capitolo presenta la fede di Abramo come un paradosso che inizia dove la ragione umana si ferma, un movimento complesso che richiede di lasciare andare e riappropriarsi. Tuttavia, la natura di questa “obbedienza attiva e libera” di fronte a un comando intrinsecamente irrazionale e moralmente problematico, come il sacrificio del figlio, rimane poco chiara. Si suggerisce che la fede cristiana si distingue dalla legge giudaica basandosi sulla grazia divina e sull’accettazione dell’impossibile, ma senza fornire un quadro più dettagliato su come l’individuo possa navigare questa tensione tra la richiesta divina e la propria capacità di giudizio morale e razionale. Per approfondire la comprensione di questa dinamica, potrebbe essere utile esplorare testi che analizzano la filosofia della religione, in particolare le opere di Søren Kierkegaard, che affronta il concetto di “salto della fede” e la natura paradossale dell’esistenza religiosa. Inoltre, uno studio più approfondito della teologia morale e dell’etica delle virtù potrebbe offrire strumenti per comprendere come conciliare l’obbedienza a un principio superiore con la responsabilità individuale.3. L’attimo opportuno della Misericordia Rivelata
La misericordia cristiana non è un semplice sentimento di compassione, ma un movimento concreto verso l’altro. Non è prossimo chi è già vicino per legami o geografia, ma chi viene attivamente avvicinato con un gesto di cura e attenzione. L’esempio della parabola del Samaritano lo dimostra chiaramente: mentre il sacerdote e il levita passano oltre, o addirittura “contro” l’uomo ferito, il Samaritano si muove attivamente “verso” di lui. Questa azione, questo andare incontro all’altro, è l’essenza della misericordia (éleos), che rende prossimo anche chi è sconosciuto o potrebbe essere percepito come estraneo o ostile.Il Perdono che Trasforma
Collegato a questo movimento di avvicinamento è il perdono, che va inteso come un “dono” che rompe completamente la logica umana di dare in base a quanto si riceve o si merita. Nei sistemi basati sulla giustizia retributiva, come l’antico principio “occhio per occhio”, c’è una corrispondenza diretta tra la colpa commessa e la pena inflitta. Il perdono, invece, non si limita a sostituire una pena con un’altra o a cancellare il debito in modo formale; va oltre la necessità di una retribuzione. L’episodio della donna adultera, dove Gesù non la condanna, illustra questa sovrabbondanza di misericordia che supera le strette regole della legge e offre una possibilità di vita nuova.Il Tempo Presente della Rivelazione
Questa manifestazione di misericordia e perdono accade in un tempo particolare, che nella rivelazione cristiana, specialmente nell’Apocalisse, non è il tempo misurabile degli orologi (chrónos) né l’eternità senza inizio né fine (aión). È invece l’attimo opportuno (kairós), un tempo che non è proiettato in un futuro lontano o catastrofico, ma che è già qui, presente e accessibile. L’Apocalisse è infatti uno “svelamento” (apokalýpsis) di una realtà che è già in atto. Questo tempo presente del kairós richiede una risposta immediata da parte di chi lo riconosce e una prontezza costante a vivere secondo questa rivelazione.La Richiesta Radicale e la Misericordia Abbondante
Vivere in questo kairós di misericordia e perdono implica un impegno profondo, che a volte può sembrare difficile o come un “discorso duro”, come quello di Gesù sul pane di vita. Questo insegnamento lega indissolubilmente la necessità del nutrimento terreno, della vita materiale, a quella del nutrimento celeste, della vita spirituale. Accettare questa unità e l’impegno radicale che ne deriva può portare a difficoltà e “inciampi” per molti. Tuttavia, la misericordia divina si dimostra sovrabbondante e disponibile anche per coloro che faticano a comprendere o che si allontanano, come simboleggiato dalle dodici ceste di pane avanzate dopo la moltiplicazione, segno di un dono che supera ogni bisogno e ogni aspettativa.Se il perdono è una risposta che va “oltre la semplice logica della punizione”, come conciliare questa dimensione con la necessità di un sistema legale che, per sua natura, si basa su logiche di causa-effetto e proporzionalità tra reato e sanzione, specialmente in contesti dove la rivelazione di verità può generare divisioni?
Il capitolo introduce il concetto di perdono come un elemento che trascende la mera logica punitiva, contrapponendolo a sistemi basati sull'”occhio per occhio”. Tuttavia, non viene chiarito come questo approccio possa integrarsi concretamente con la struttura di un ordinamento giuridico che necessita di principi chiari e applicabili per garantire giustizia e ordine sociale. La potenziale divisione generata dalla “rivelazione” in momenti cruciali (Kairos) solleva interrogativi sulla gestione delle conseguenze emotive e sociali, che sembrano rimanere in secondo piano rispetto alla dicotomia tra punizione e perdono. Per approfondire queste dinamiche, sarebbe utile esplorare discipline come la filosofia del diritto, concentrandosi su autori che hanno trattato il concetto di giustizia riparativa, e la psicologia sociale, per comprendere le dinamiche di gruppo e la gestione dei conflitti in seguito a rivelazioni o eventi epocali. Un punto di partenza potrebbe essere lo studio delle opere di Hannah Arendt sulla complessità della giustizia e della responsabilità umana, e di autori che analizzano il ruolo del perdono nelle società contemporanee.8. La Morte Divina nelle Rappresentazioni Umane
La Passione di Cristo è un tema centrale e molto studiato, rappresentato in moltissime forme d’arte e cultura. La base di tutto sono i racconti che si trovano nei Vangeli, che offrono la storia principale di questi eventi.La Passione nell’Arte Visiva
Le immagini hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nel mostrare la Passione. Si possono osservare le raffigurazioni create dagli artisti nel corso della storia, comprese le opere di pittori come Giotto. Queste opere si concentrano molto nel far vedere la sofferenza e il momento della morte. Si approfondisce come l’arte ha cercato di rendere visibile il dolore provato.Interpretazioni Moderne: Cinema e Musica
Anche il cinema ha affrontato questo argomento, offrendo nuove prospettive. Le visioni di registi come Pier Paolo Pasolini sono importanti, specialmente nel suo film basato sul Vangelo secondo Matteo e nell’episodio La ricotta. In queste opere, anche la musica diventa uno strumento per esprimere la Passione. Allo stesso modo, la musica classica ha dato vita a composizioni fondamentali su questo tema, come la Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, che è un esempio molto noto di come la musica possa raccontare questa storia.Considerando che il capitolo si concentra sulla “Morte Divina nelle Rappresentazioni Umane” attraverso l’arte e la musica, perché non viene contestualizzato il significato teologico e filosofico della Passione di Cristo al di là delle sole rappresentazioni artistiche?
Il capitolo analizza la Passione di Cristo principalmente attraverso le sue manifestazioni artistiche e musicali, citando Giotto, Pasolini e Bach. Tuttavia, manca un’esplorazione più approfondita delle ragioni per cui questo evento è stato così centrale nella cultura umana e quali implicazioni teologiche e filosofiche esso porta con sé. Per comprendere appieno il peso di queste rappresentazioni, sarebbe utile approfondire il dibattito teologico sulla natura della sofferenza divina e il suo impatto sulla concezione dell’umanità, magari consultando testi di teologi come Hans Urs von Balthasar o filosofi che hanno indagato il concetto di sacrificio e redenzione. La mancanza di questo contesto lascia aperte domande sul perché la Passione continui a risuonare così profondamente, al di là della sua mera rappresentazione estetica.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]