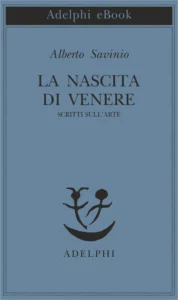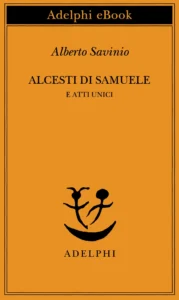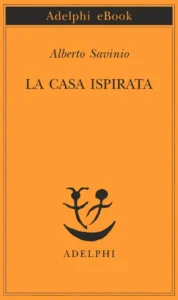1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Palchetti romani” di Alberto Savinio ti catapulta nel cuore del teatro italiano degli anni ’30, offrendo uno sguardo critico e spesso impietoso sul suo stato di salute. Savinio non è un semplice spettatore, ma un osservatore acuto che analizza la scena romana e non solo, smascherando la decadenza causata, a suo dire, dal verismo e dalla mediocrità dilagante. Il libro esplora i diversi generi, dal teatro borghese al dialettale, dal giallo al varietà, cercando l’autenticità e la “tragedia” perduta in un mondo di artificio e superficialità. Attraverso l’analisi di spettacoli specifici e la critica della recitazione degli attori italiani, Savinio dipinge un quadro vivido di un’arte in crisi, contrapponendo la ricerca di stile e verità di figure come Pirandello o i fratelli De Filippo alla vacuità di molte produzioni contemporanee. È un viaggio appassionato tra i palcoscenici, le platee e le illusioni del teatro italiano, dove la critica teatrale diventa un modo per riflettere sulla civiltà stessa.Riassunto Breve
Il teatro italiano si presenta come una forma di espressione impura e decaduta che necessita di essere salvata, raccogliendo impurità come altre forme d’arte collettive. La causa principale di questa decadenza è il verismo, considerato un equivoco che serve da rifugio per la mediocrità e infetta gli attori, facendoli vergognare della trasformazione e riducendoli a fantasmi privi di verità artistica. Il palcoscenico verista è confuso, mostra personaggi che si lamentano e allontana gli artisti consapevoli. Il teatro deve toccare il fondo per ritrovare spirito e funzione, recuperando espressione indiretta, ritmo, accento, conoscenza della vita, eleganza e proprietà di linguaggio. Esempi come *La Prima Legione*, *Inventiamo l’Amore*, *Sedici Anni*, *Il Successo*, *Il Piccolo Re* mostrano questa condizione di grottesco, superficialità, noia e falsità, dove la vera arte sta nell’intellettualismo o metafisica spesso etichettati negativamente. Il teatro borghese manca di terrore e fantasia, riducendo la potenza drammatica; il genere “giallo” emerge come tragedia contemporanea, esponendo la vulnerabilità umana. L’attore non deve apparire naturale ma raggiungere un “tipo” tramite il trucco. Teatri sperimentali come il Teatro delle Arti mostrano strutture non convenzionali ma scelte di opere “tubercolari” e influenze russe meccaniche sollevano dubbi. Il teatro dialettale si eleva, mentre quello italiano si abbassa, importando spettacoli stranieri mediocri e mostrando un cosmopolitismo esteriore. Nel teatro nazionale si mettono in scena “piatte crudità” senza trasformazione artistica, con recitazione forzata e pubblico legato a gusti superati. La drammaturgia nazionale manca di profondità mentale e indifferenza verso i movimenti metafisici; l’arte separata dalla filosofia appare spettacolo di mentecatti. Drammi con violenza superficiale falliscono. Anche il giornalismo ha retorica e un “tipo” umano specifico. L’opera di Pirandello, specialmente *I Giganti della Montagna*, cerca un mondo superiore, un passaggio a una realtà diversa, superando le convenzioni umane con autorità poetica. Altri spettacoli mostrano naturalismo eccessivo (*Cugino Filippo*) o affinità con Dostoevsky (*L’Abito Nuovo*). Il teatro attuale annoia il pubblico, che finge interesse. Autori come G.B. Shaw sono visti come equivoci, le loro opere mancano di sostanza. Il “giallo” italiano è letteratura bassa e conformista, imitazione senza romanticismo criminale. La recitazione è spesso insufficiente, con problemi di dizione. Il teatro offre una riproduzione indiretta del pubblico, rivelando verità nascoste. Alcuni spettacoli riprendono vecchi modelli di varietà e rivista, perpetuando una “scemenza” legata a un vecchio spirito nazionale schietto. Il successo del teatro dialettale si basa sulla rappresentazione della vita quotidiana del pubblico, che si identifica e prova piacere nel vedere il proprio linguaggio elevato. Si osserva una decadenza nella tecnica teatrale, molti attori mancano della scienza per la recitazione collettiva; ci sono attori stilizzati (esterni) ma pochi di stile (radicati nell’essere). Dina Galli è un esempio di attore di stile. Riento rappresenta l’attore solo, Spadaro ha uno stile unico, Chiezel l’acrobata dei movimenti. Alcune forme teatrali mancano di sostanza (Plauto non fa più ridere) o falliscono nella comunicazione (teatro russo senza parola, commedie con tesi deboli). Il teatro italiano manifesta un “feudalismo letterario”, con influenza basata sui vizi, portando a opere distanti dalla realtà come quelle di Sem Benelli. Spettacoli come *Processo Folckner* hanno allestimenti poco credibili e trame artificiose. Il compito dell’attore è creare “evidenza”, riprodurre la realtà dei tipi umani fino al surreale; molti falliscono riempiendo il vuoto con falsa poesia. Attori come Govi creano evidenza con gesti precisi, agendo da specchio per il pubblico. Le compagnie dialettali mostrano maggiore capacità e omogeneità. Il teatro contemporaneo manca di profondità e originalità, trattando temi importanti con superficialità (*Conchiglia*). Opere recenti sono prive di peso e memoria (*Dopo divorzieremo*). Il teatro verista e borghese si giustifica nell’illusione o nella soddisfazione del pubblico che si compiace delle proprie miserie, portando a mediocrità. Un teatro nuovo richiede fantasia e illusione, più vicine al varietà. Le rappresentazioni di Shakespeare sono rare e spesso banalizzate (*La bisbetica domata* senza prologo). Opere contemporanee sono vuote (*Napoleone unico*). Si produce troppo e affrettatamente. Manca la musicalità del teatro antico; gli attori dovrebbero imparare a cantare. Il teatro affronta il pericolo del “dolorismo”, rappresentazione basata solo sulla sofferenza, segno di inferiorità. Attrici come Irma ed Emma Gramatica superano il dolorismo con forza e tecnica. Opere straniere mostrano crudezza tematica (*Catherine empereur*) o mediocrità ricercata (*Quadriglia* di Guitry). L’intellettuale degenere evita la verità per un concetto errato di eleganza (*La guerre de Troie n’aura pas lieu*). Il teatro di costumi (*La Niña boba*) richiede animo sereno ma non soddisfa la “fame da barbari”. Il “teatro dolorista” (*Delirio del personaggio*) è un trucco, indizio di plebeismo mentale. Teatri moderni con attrezzature avanzate mostrano commedie prive di spessore (*Vicende di famiglia*). Il pubblico preferisce il teatro “verista” che riproduce le miserie quotidiane. Il teatro dialettale è visto come lingua inferiore, la sua attrattiva sta nella rivincita di un complesso d’inferiorità e nella protezione della mediocrità. La caricatura è scontro tra sacro e sacrilegio; Edoardo De Filippo incarna l'”uomo-caricatura”. Trattare argomenti sacri è difficile, l’uomo tende all’irriverenza. L’artista predilige soggetti su cui può esercitare dominio. Emerge il tipo della “Nora italiana”, che cerca riconoscimento intellettuale, incontrando pregiudizi. La farsa genuina si basa sull’illogicità, la “pochade” soddisfa desideri bassi. La cultura americana manca di dèi, risulta infantile e ricicla temi europei superficialmente. Il pompierismo artistico è arte banale ma solenne, priva di spirito, si annida nei grandi concetti. Edmond Rostand è un pompiere puro. Manzoni si adatta alla sua epoca, la sua arte manca dirompenza, ma *Adelchi* ha bellezza formale compiuta, una mirabile superficie senza destino profondo. Il dialetto è lingua diminuita, si giustifica solo con personaggi diminuiti (*I fradei Castiglioni*). L’arte ha un codice morale interno, distinto dalla morale comune; molti artisti lo ignorano (*Donna senza uomo*). Portare la filosofia sul palcoscenico (*Critone*, *Fedone*) dimostra il potere della parola. Una parte della cultura si è formata sulle cromolitografie, espressione di una civiltà compiuta, contrapposta al falso «socialismo plastico» attuale. *Villafranca* è una cromolitografia vivente. *Alta montagna* non fa vivere l’ambiente, riflette gusto borghese falso. Le commedie di Bernstein (*Cuore*) sono il peggio del teatralismo borghese, false e superficiali. Il teatro Argentina presenta atmosfera ordinaria. Commedie poliziesche mancano di drammaticità e poesia, funzionano come giochi di società. *Come vi garba* di Shakespeare è spettacolo di grande valore, basato sulla parola, rappresenta una condizione di civiltà. La regia di Copeau valorizza gli attori. Il teatro popolare dialettale si riduce alla farsa (*In pretura*), appellandosi a istinti bassi. La compagnia di Casaleggio è estremo esempio di anacronismo e semplicità popolaresca. Il teatro di alta civiltà usa solo la parola. Commedie moderne (*Scuola di perfezionamento*) mancano di movimento e eloquio. Il varietà contemporaneo manca autenticità, usa luci per nascondere difetti, manca fantasia del vecchio varietà. Attori come i De Filippo mostrano naturalezza e dignità, continuando la realtà della vita. Un pubblico superficiale cerca il “buffo” e si rispecchia in compagnie che privilegiano la futilità (Tòfano). Il “processo” in scena non è arte, ma trascrizione meccanica. L’interesse per il processo teatrale deriva dalla fascinazione per l’individuo sottomesso alla società. Il teatro attraversa crisi, il varietà è rifugio. Un incontro di pugilato rivela la lotta dell’uomo contro il destino, rinascita della tragedia. I drammi gialli esplorano il Male, il medico come potenziale delinquente. Il palcoscenico vasto dell’Arena delle Feste è inadatto all’arte varia, evidenzia piccolezza umana. Macario emerge per semplicità e umanità, interpreta lo stupido in contrasto con l’intelligente. L’esperienza teatrale estiva mostra contrasti: comodità banale (*Lo scandalo Mackenzie*) contro vitalità musicale (*Sulle onde della radio*). Alcuni gialli speculativi sono noiosi (*La legge*). *La Nave* di D’Annunzio all’aperto introduce verismo, ma l’opera appare meno convincente nella crudeltà. *Morte in vacanza* ha personaggi tipici di riviste. Torino ha teatri inattivi, mancanza di attività nonostante necessità di teatro colto. Un “superspettacolo” si rivela assurdo e volgare. L’attività teatrale in Italia centrale mostra indigenza, mancanza di tappeti nei teatri, prevalenza di varietà o dialettali. A Roma, l’unica prosa è una rivista con ballerine seminude. *La modella* mostra commedia datata e recitazione disordinata. Il teatro attuale privilegia effetto immediato e sfarzo scenico inutile (*Francesca da Rimini*), manca sostanza e verità. *Ghibli* usa temi coloniali superficialmente. C’è consapevolezza dell’artificiosità e crudeltà gratuita. Serve teatro serio, intelligente, onesto, che educhi il pubblico. La farsa contemporanea manca gioia, espone realtà cruda, mostrando tristezza e angoscia, riflettendo una “triste bestia”. I personaggi mancano distacco per la vera farsa. La civiltà nel teatro è linguaggio ed eloquenza. Goldoni dimostra comprensione della “metafisica del linguaggio”, il dialetto è scelta drammatica (*Casa nova*). Il teatro contemporaneo ha sfide: Cocteau è noioso (*La Voix humaine*), Shakespeare “si straccia” (*La dodicesima notte*). Pirandello rappresenta volontà di grandezza, curiosità, fiducia nella “pazzia”. Stefano Landi rappresenta il mondo come lo sogna. Aretino incarna potere derivato dal terrore, la sua opera è estetismo debole, resta tristezza vuota. Le rappresentazioni di Aretino (*La Cortigiana*) rimuovono elementi “aretineschi”. *Una lettera smarrita* manca durata, si “sgonfia”, priva di eccesso per l’immortalità. L’arte duratura richiede peso e profondità. Il pubblico a teatro ha parte attiva ma comoda, si sente al sicuro, gode di essere adulato. È un’entità anonima, priva di personalità. È necessario trattarlo come personaggio, ricordargli i doveri. Il teatro italiano tende a generi leggeri. Il successo di drammi gialli e varietà, calo di prosa e dialettale, riflette preferenze del pubblico, portando a teatro meno profondo.Riassunto Lungo
1. Il Declino del Palcoscenico Italiano
Il teatro appare come una forma d’arte impura e in decadenza che ha bisogno di essere salvata. Le forme espressive che coinvolgono molte persone tendono a raccogliere impurità, diventando veicoli di ciò che è considerato volgare o degradato. L’interesse per il teatro non è un caso isolato, ma fa parte di un desiderio più ampio di salvare le forme d’arte che si trovano in crisi. Questa situazione critica richiede un intervento urgente per recuperare la dignità e la funzione del palcoscenico.La Causa Principale del Declino: Il Verismo
La causa principale del declino del teatro italiano è identificata nel Verismo. Questo movimento è visto come un equivoco, un rifugio per la mediocrità che ha contagiato gli attori. Gli attori, influenzati dal Verismo, arrivano a vergognarsi di trasformarsi e mascherarsi, rinunciando così alla loro vera natura di interpreti. Il Verismo è paragonato a una forma di “socialismo” nel teatro, che ha apparentemente “liberato” l’attore ma in realtà lo ha svuotato, riducendolo a una figura debole incapace di agire e parlare con autentica verità artistica.Lo Stato del Palcoscenico Verista
Il palcoscenico dominato dal Verismo è caratterizzato da confusione e disordine. Non offre al pubblico “cose da vedere” nel senso artistico, ma solo personaggi che si lamentano dei loro problemi quotidiani. Gli artisti più consapevoli evitano questo tipo di teatro, considerandolo un luogo di scarsa qualità e discredito. Anche i progressi tecnici hanno contribuito al suo peggioramento, focalizzando l’attenzione su una realtà superficiale anziché sulla profondità artistica.La Via per la Ripresa
Prima di poter ritrovare il suo spirito e la sua funzione, il teatro deve toccare il fondo. Per recuperare il suo valore, è essenziale che ritrovi l’espressione indiretta, il ritmo, l’accento, una profonda conoscenza della vita, l’eleganza e la proprietà di linguaggio. Queste qualità sono fondamentali per l’arte e permettono di superare la semplice rappresentazione per raggiungere una verità più profonda.Esempi della Decadenza
Alcune opere teatrali mostrano chiaramente questa condizione di decadenza. La Prima Legione presenta personaggi grotteschi e una recitazione urlata. Inventiamo l’Amore è superficiale e volgare, suggerendo che solo le macchiette mantengono quell’elemento di follia ed eccesso necessario all’arte. Sedici Anni affronta temi psicologici in modo noioso. Il Successo è una riproposizione banale e infantile, con modifiche al testo e alla messa in scena, e una recitazione priva di stile e dizione. Il Piccolo Re è un esempio di teatro verista falso, dove i personaggi non risultano credibili nella loro presunta realtà. Questo teatro verista non mostra la verità, ma una maschera convenzionale e quasi caricaturale. La vera arte e la verità si trovano spesso in ciò che viene etichettato come intellettualismo o metafisica.Davvero il Verismo è la causa principale del declino del teatro italiano, o questa è una semplificazione che ignora la complessità del contesto storico e artistico?
Il capitolo identifica nel Verismo la causa principale del declino del teatro italiano, ma questa tesi, per quanto suggestiva, rischia di trascurare la complessità dei fattori che influenzano l’evoluzione di una forma d’arte. Il declino di un genere o di una pratica artistica è raramente imputabile a un singolo movimento, ma è spesso il risultato di un intreccio di cambiamenti sociali, economici, culturali e dell’emergere di nuove forme espressive. Per comprendere appieno il contesto e valutare la validità di questa tesi, sarebbe utile approfondire la storia del teatro italiano tra Ottocento e Novecento, studiando non solo il Verismo ma anche i movimenti che lo hanno preceduto e seguito, analizzando il rapporto tra teatro e società, e considerando l’impatto di altre arti e dei mutamenti nel gusto del pubblico. Autori come Roberto Alonge o Guido Davico Bonino possono offrire prospettive storiche più ampie sul periodo.2. Scene Sperimentali e Misteri Moderni
Il teatro borghese manca di terrore e fantasia, limitando la sua forza drammatica. Questo tipo di teatro non riesce più a toccare le corde profonde dello spettatore. Guglielmo Giannini cerca di riportare in vita il destino tragico del teatro, usando la radio come strumento scenico per reintrodurre mistero e terrore. In questo contesto, il genere “giallo” si propone come la vera tragedia dei nostri tempi. Il giallo riesce a mostrare la fragilità umana in modo potente, quasi come fa l’idea della morte.Un nuovo spazio per la sperimentazione
A Roma è stato inaugurato il Teatro delle Arti, pensato come uno spazio sperimentale sostenuto dallo Stato. L’intento principale di questa iniziativa è quello di superare la mediocrità che caratterizza il teatro borghese tradizionale. Si vuole creare un ambiente dove nuove forme e idee possano essere esplorate liberamente. Questo teatro nasce con l’ambizione di rinnovare la scena teatrale italiana. Si propone come un luogo dove esplorare nuove direzioni artistiche.La struttura del Teatro delle Arti
La concezione architettonica del Teatro delle Arti include diversi elementi innovativi. Il palcoscenico, ad esempio, è diviso in sezioni, permettendo una maggiore flessibilità scenica. Non c’è la ribalta tradizionale; la luce è fornita da riflettori, un approccio moderno all’illuminazione teatrale. Anche l’illuminazione generale è particolare, con finestre finte che contribuiscono a creare una luce diffusa nell’ambiente. Questa attenzione ai dettagli strutturali mira a definire un’esperienza scenica diversa.Le prime rappresentazioni e le loro critiche
Le prime opere messe in scena al Teatro delle Arti sono state scelte tra autori importanti come Alfieri, Verga e Pirandello. Queste rappresentazioni sono state affidate agli allievi di un’accademia, offrendo loro un’opportunità pratica. Tuttavia, la scelta di testi come “In portineria” di Verga e “L’imbecille” di Pirandello è stata definita “tubercolare”, sollevando dubbi sulla loro appropriatezza per un teatro sperimentale o per scopi didattici. Si percepisce anche una forte influenza del teatro russo, in particolare nel lavoro di Tatiana Pavlova. Questa influenza si manifesta con elementi come l’isterismo meccanico, una tendenza che sembra poco adatta al contesto teatrale italiano contemporaneo.Stile di recitazione e imperfezioni in scena
Per quanto riguarda la recitazione, si suggerisce che l’attore non debba puntare alla naturalezza, ma piuttosto a creare un “tipo” ben definito, anche attraverso l’uso del trucco, un approccio visto ad esempio in Zacconi. Nonostante gli intenti, alcune rappresentazioni mostrano debolezze evidenti. Si notano imprecisioni nella rappresentazione di figure come la polizia, che non appaiono credibili. Ci sono anche errori specifici, come l’uso scorretto delle desinenze nei nomi russi, un dettaglio che disturba l’accuratezza. Inoltre, la pronuncia delle parole straniere da parte degli attori italiani rivela una difficoltà nel liberarsi di vecchie e superate abitudini sceniche.Le installazioni artistiche
All’interno del teatro sono presenti anche installazioni artistiche, come sculture e dipinti. Purtroppo, queste opere d’arte non sempre si integrano bene con l’ambiente circostante. In molti casi, le installazioni appaiono inadeguate o persino goffe, non contribuendo positivamente all’atmosfera complessiva dello spazio sperimentale. La loro presenza non sembra arricchire l’ambiente come forse era nelle intenzioni.Ma se il teatro nasce per essere sperimentale, perché lo si critica con metri convenzionali?
Il capitolo descrive il Teatro delle Arti come uno spazio destinato alla sperimentazione, nato proprio per superare la mediocrità del teatro borghese. Tuttavia, le critiche mosse alle prime rappresentazioni sembrano giudicare gli spettacoli in base a criteri di “appropriatezza” o “adeguatezza” al contesto italiano, o a dettagli tecnici come l’accuratezza dei nomi russi. Questo solleva un dubbio: se l’obiettivo è esplorare nuove forme e idee, non è forse necessario accettare che le prime prove possano apparire “inadeguate” o “goffe” secondo i canoni stabiliti? Per comprendere meglio questa tensione tra sperimentazione e critica, sarebbe utile approfondire la storia del teatro d’avanguardia e le teorie della critica teatrale dell’epoca. Autori come Artaud o Brecht offrono prospettive diverse su cosa significhi “teatro sperimentale” e su come valutarne gli esiti, mentre lo studio della critica teatrale italiana del periodo può fornire il contesto per capire i metri di giudizio utilizzati.3. Scene di un Teatro Amaro
Il teatro di oggi mostra due facce molto diverse. Da una parte, il teatro che usa il dialetto è visto come più importante. Dall’altra, il teatro in italiano sembra meno apprezzato. Le rappresentazioni in dialetto riempiono le sale e toccano le emozioni del pubblico, anche se a volte si fermano solo alle caratteristiche tipiche della regione in modo superficiale. Eppure, alcuni artisti che lavorano con il dialetto sono molto bravi. Sanno usare le tecniche del teatro come i grandi autori del passato, specialmente nel modo in cui costruiscono la scena e creano i personaggi.Il teatro in italiano e le influenze esterne
Nel teatro in italiano, si tende a portare in scena spettacoli stranieri che non sono sempre di grande qualità. C’è anche la voglia di mostrare di essere aperti al mondo, usando parole straniere nel parlare di tutti i giorni e anche a teatro. Alcuni spettacoli che arrivano da fuori affrontano argomenti molto forti e crudi. Mostrano i rapporti umani in modo freddo, quasi scientifico, come se si osservassero animali. Questo modo di scrivere per il teatro parla di temi legati al sesso in modo molto diretto e a volte risulta sgradevole.I temi difficili, la recitazione e la reazione del pubblico
Sul palcoscenico nazionale, si scelgono spesso storie tristi e dolorose. Ma il modo in cui vengono presentate non le trasforma in arte. Invece di lavorare sulla realtà così com’è per farla diventare una vera opera teatrale, si mostrano solo “cose crude presentate così come sono”. Queste scene non riescono a coinvolgere davvero chi guarda. Anche gli attori sembrano recitare in modo forzato e senza profondità. La reazione del pubblico a questi spettacoli fa capire che la gente preferisce ancora cose vecchie che non vanno più bene. A volte, capita che durante lo spettacolo succedano cose non previste. Questi momenti inattesi finiscono per essere più interessanti della rappresentazione stessa.Ma è davvero possibile liquidare Pietro Aretino come un volgare senza idee, segnando la “fine di un periodo”, o è questa una lettura superficiale che ignora la sua complessità e il suo contesto storico?
Il capitolo offre un giudizio estremamente severo su Pietro Aretino, liquidandolo come un autore la cui forza deriva solo dalla paura e la cui volgarità nasconde una mancanza di idee profonde, arrivando a dichiarare la “fine di un certo periodo per la poesia”. Questa visione, pur legittima come interpretazione, appare riduttiva e potenzialmente anacronistica, trascurando il contesto storico e culturale in cui Aretino operò. La sua figura è complessa: fu un maestro della satira, un osservatore acuto della società rinascimentale e un innovatore nell’uso della prosa volgare. Per comprendere appieno Aretino e il suo impatto, è fondamentale approfondire la storia del Rinascimento italiano, lo studio della satira e della retorica dell’epoca, e confrontare la sua opera con quella di contemporanei come Machiavelli o di altri grandi satirici.33. La Comoda Potenza del Pubblico Teatrale
A teatro, il pubblico occupa una posizione particolare. Mentre autori e attori sono esposti al giudizio e si mettono in gioco, chi siede in platea si sente al sicuro. Gode del privilegio di essere adulato e considerato sempre nel giusto, anche quando i fatti sembrano dimostrare il contrario. Questa libertà di esprimere un giudizio rapido su un’opera che ha richiesto tempo e fatica per essere creata appare ingiusta, soprattutto considerando il lavoro dietro le quinte.L’Anonimato e la Responsabilità del Pubblico
Il pubblico è spesso un’entità anonima. Non ha una personalità definita né una responsabilità diretta, e il rispetto che riceve a volte sembra simile a quello tributato ai defunti. Nonostante questa condizione, è importante iniziare a considerare il pubblico come un vero e proprio personaggio, quasi un attore, che ha i suoi doveri e non dovrebbe godere di completa immunità. Lodare un pubblico anonimo è facile, perché un complimento rivolto a nessuno non costa nulla. Per mantenere il suo anonimato, il pubblico dovrebbe almeno evitare di segnalare la propria presenza con rumori inutili.L’Influenza del Pubblico sui Generi Teatrali
Questa posizione del pubblico influenza direttamente il tipo di spettacoli offerti. Il teatro italiano mostra infatti una chiara tendenza verso generi più leggeri e meno impegnativi. I drammi gialli e gli spettacoli di varietà riscuotono grande successo, mentre il teatro di prosa e quello dialettale registrano risultati inferiori. I dati del 1938 confermano questa situazione, mostrando un calo negli incassi per prosa e dialettale e un aumento notevole per il varietà. Questi numeri indicano chiaramente come le preferenze del pubblico guidino le scelte artistiche, orientando il teatro verso proposte meno profonde rispetto al passato.Ma è davvero la ‘comoda potenza’ del pubblico a determinare i generi teatrali, o il capitolo semplifica eccessivamente, ignorando il peso di storia, economia e contesto sociale?
Il capitolo, pur sollevando un punto interessante sulla posizione del pubblico, pecca di eccessiva semplificazione nel fare di quest’ultimo il motore quasi unico dell’evoluzione dei generi teatrali, appoggiandosi peraltro su un’istantanea storica specifica. Per uscire da questa visione riduttiva e comprendere le reali forze che plasmano il palcoscenico, è indispensabile allargare lo sguardo. Lo studio della storia del teatro nel suo complesso, l’analisi socio-economica del settore culturale e l’approfondimento del contesto storico in cui certi dati sono stati raccolti (come l’Italia del 1938) sono passaggi obbligati. Solo così si può apprezzare la complessità delle dinamiche che legano artisti, produttori, pubblico e potere, ben oltre la mera preferenza per il varietà.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]