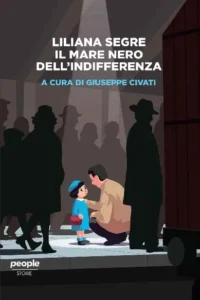1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Non siete fascisti ma” di Giuseppe Civati è un libro che scava a fondo in quella zona grigia della politica italiana dove si incontrano comportamenti e idee che richiamano il fascismo, anche quando chi li adotta si definisce diversamente. Il testo analizza come il nazionalismo aggressivo, la nostalgia per un passato distorto e l’uso di simboli e retoriche tipiche del fascismo persistano nel dibattito pubblico e nelle azioni di certi gruppi e figure della destra italiana. Civati mette in luce l’amnesia storica che affligge l’Italia, una sorta di “dimenticatoio” collettivo che porta a minimizzare o negare aspetti cruciali del nostro passato, dal fascismo al colonialismo, rendendo fertile il terreno per il complottismo e la negazione della realtà, anche su temi come il cambiamento climatico. Il libro sottolinea come questa tendenza a creare nemici e diffondere teorie cospirative, come quella della “sostituzione etnica”, sia strettamente legata al nazionalismo e al razzismo. In sostanza, Civati ci spinge a riflettere su come certi elementi del “fascismo eterno” descritto da Umberto Eco siano ancora presenti e pericolosi, e su quanto sia fondamentale difendere i principi antifascisti su cui si basa la Costituzione italiana contro queste manifestazioni ambigue ma insidiose.Riassunto Breve
In Italia si osservano manifestazioni di fascismo dichiarato e legami con quel mondo anche da parte di chi non si definisce fascista, caratterizzate da nazionalismo, aggressività e nostalgia, visibili in simboli, gesti e discorsi ambigui che non rispettano la Costituzione. Episodi recenti mostrano questa tendenza, come il sostegno di Forza Nuova a un raid razzista, manifestazioni a Predappio con richiami al fascismo, incitamenti all’odio contro persone rom, cene commemorative della marcia su Roma con figure politiche, scelte contrastanti come intitolare una via ad Almirante, l’uso di inni fascisti da parte di assessori o proposte di reintitolare parchi a familiari di Mussolini. Anche in politica, partiti con radici nel fascismo mantengono simboli legati a quella storia, nonostante dichiarino sorpresa per la presenza di neofascisti al loro interno. Alcuni leader usano citazioni e slogan tipici del fascismo, evitando di condannarlo. Questi gruppi accusano paradossalmente le istituzioni democratiche di essere autoritarie, pur richiamandosi a un regime che sopprimeva la libertà. La Costituzione italiana nasce come reazione al fascismo, e l’antifascismo è un suo elemento fondamentale; ignorare le manifestazioni attuali significa trascurare le basi della democrazia. Esiste una tendenza a negare il fascismo per invalidare l’antifascismo, come nel dibattito sulle Foibe, usato per equiparare antifascisti e fascisti. Si osserva un doppio standard nel trattare manifestazioni diverse, come l’assalto al Campidoglio rispetto a proteste come Black Lives Matter. Gruppi complottisti sono spesso armati, e in Italia c’è una spinta a promuovere l’idea che i cittadini debbano armarsi, favorendo i produttori di armi. Si minimizzano azioni fasciste, come l’assalto alla Camera del Lavoro, e si usa il termine “fascismo” in modo distorto per attaccare gli oppositori. L’Italia soffre di un’amnesia storica generalizzata, dimenticando aspetti come il fascismo, il colonialismo, la dittatura, la deportazione. Questa memoria selettiva porta a scelte di ricorrenze nazionali che mostrano mancanza di consapevolezza storica. Quando la memoria svanisce, subentra il complottismo, dimenticando le basi della Costituzione e la storia del razzismo, portando a mancanza di rispetto per le minoranze e perdita di umanità. Nonostante ciò, alcuni negano l’esistenza del razzismo. La negazione della realtà si manifesta nella questione climatica, dove la destra nega il cambiamento climatico perché non ha confini, sfida il capitalismo e il nazionalismo. L’Italia è vulnerabile al cambiamento climatico, ma la negazione aumenta con la preoccupazione pubblica, con attacchi agli ambientalisti definiti “fondamentalisti”. Questo atteggiamento rifiuta la scienza, legandosi a nazionalismo e populismo che difendono lo status quo. La tendenza alla negazione si vede anche nell’atteggiamento “No” (No vax, No euro) e nell’attaccare manifestazioni antifasciste o figure come Liliana Segre. Il “buonismo” italiano minimizza i crimini storici commessi in patria e nelle colonie, difendendo i responsabili. Richieste di “pieni poteri” evocano precedenti storici legati a dittature, in contrasto con proteste contro poteri governativi simili. Simboli e azioni legate al fascismo vengono minimizzati come “goliardia”, sminuendo la loro gravità e ricordando come la Marcia su Roma fu sottovalutata. Leader dell’estrema destra internazionale si riuniscono per definire una visione politica comune basata su Dio, patria, famiglia, proprietà, contraria a ideologia di genere, lobby LGBT, immigrazione di massa, multiculturalismo. Identificano nemici come globalisti, politicamente corretto, burocrati europei, fondamentalismo islamico. La retorica è semplificata, basata su false alternative, con una percezione di essere vittime di una cospirazione globale. I programmi sono generici, focalizzati su riduzione tasse e contrasto immigrazione, con poca analisi economica. Prevale un desiderio di ritorno a un passato idealizzato e paura del futuro. Il nazionalismo si basa sulla creazione di nemici, spesso attraverso l’ossessione per il complotto internazionale. Xenofobia, nazionalismo e complottismo si sostengono a vicenda. Il complottismo è una strategia diffusa nella destra italiana, con l’uso della teoria della “sostituzione etnica” da parte di leader politici per parlare di immigrazione e cambiamenti climatici, o suggerire complotti sull’origine del COVID-19. La teoria del “grande rimpiazzo” è legata al suprematismo bianco e ispira atti violenti. L’opposizione a leggi come lo ius scholae si basa sull’argomento della “sostituzione etnica”, rivelando razzismo. Nazionalismo, complotto e razzismo sono strettamente connessi. Un senso di frustrazione diffuso, dovuto a un modello economico percepito come ingiusto, mancanza di prospettive e scarsa credibilità delle istituzioni, apre la strada a soluzioni considerate sbagliate. È necessario affrontare le cause di questa frustrazione e spiegare la pericolosità delle proposte di fanatici e fascisti. Elementi del “fascismo eterno” continuano a manifestarsi, come il culto di una tradizione alterata, critica verso gli intellettuali, nazionalismo contro cosmopolitismo, complottismo, sessismo, machismo, antiparlamentarismo e uso di slogan per manipolare la realtà. La presenza congiunta di questi elementi richiede attenzione. La politica deve intervenire sui problemi sociali che generano frustrazione e contrastare le degenerazioni che su questa prosperano, perché quanto descritto è già accaduto e può ripetersi. L’uso di slogan storicamente associati al fascismo, pur negando un’identità fascista, rientra in questo quadro.Riassunto Lungo
1. Presenze e ambiguità
In Italia esiste un’area politica dove si incontrano persone con idee vicine al fascismo e altre che si definiscono non fasciste ma che mostrano legami o comportamenti simili. Questa zona è caratterizzata da un forte nazionalismo, aggressività e nostalgia per il passato, e si riconosce in simboli e gesti che richiamano il fascismo. Non mancano però le ambiguità e discorsi che sembrano non rispettare i principi della nostra Costituzione.Situazioni che fanno riflettere
Diversi fatti recenti mostrano chiaramente queste tendenze. A Macerata, dopo un grave omicidio, un partito di estrema destra ha appoggiato l’autore di un attacco razzista, mentre un importante politico ha condannato l’episodio senza però nominarne l’origine ideologica. A Predappio, si continuano a vedere manifestazioni con simboli e gesti che richiamano il fascismo. A Roma, durante una protesta contro l’arrivo di persone rom, alcuni gruppi di estrema destra hanno incitato all’odio. Ci sono state anche cene per ricordare la marcia su Roma, a cui hanno partecipato alcune figure politiche.Episodi nelle istituzioni e nello sport
Anche nelle istituzioni e nella politica si notano episodi simili. A Verona, ad esempio, è stata approvata la cittadinanza onoraria per Liliana Segre, una scelta importante, ma allo stesso tempo si è deciso di intitolare una via a Giorgio Almirante, decisioni che molti considerano difficili da conciliare. Un assessore regionale è stato sorpreso a cantare un inno fascista. Un deputato ha proposto di cambiare il nome di un parco dedicato a Falcone e Borsellino per intitolarlo a un familiare di Mussolini. Queste manifestazioni si vedono anche nel mondo dello sport, con tifosi che fanno richiami al fascismo.Partiti e simboli dal passato
Alcuni partiti politici hanno origini che affondano nel periodo fascista. Nonostante si dichiarino a volte sorpresi dalla presenza di neofascisti tra i loro membri, scelgono di mantenere simboli che fanno parte di quella storia. Inchieste giornalistiche hanno rivelato legami tra alcune figure politiche e ambienti che richiamano il fascismo. Si osserva anche come certi leader politici utilizzino frequentemente citazioni e slogan tipici del fascismo nei loro interventi pubblici e sui social media. Questo avviene spesso senza che venga espressa una chiara condanna del fascismo.Accuse paradossali
È un fatto curioso che questi gruppi e figure politiche accusino spesso le istituzioni democratiche di essere autoritarie o addirittura ‘fasciste’, come è accaduto ad esempio in riferimento a misure sanitarie. Questo è un paradosso evidente, perché il fascismo è l’esatto contrario della democrazia e della libertà di espressione. Tali figure rivendicano con forza la libertà di parola, ma allo stesso tempo si richiamano a un regime che quella libertà l’ha completamente eliminata per imporre il proprio controllo.Le basi della nostra democrazia
La Costituzione italiana è nata proprio come risposta alla dittatura fascista e ai suoi orrori. I suoi principi fondamentali, come il diritto d’asilo, riflettono l’esperienza diretta di chi è stato costretto a fuggire dal regime per salvarsi. L’antifascismo non è quindi un’opinione politica tra le altre, ma un elemento essenziale e non negoziabile su cui si basa la nostra Costituzione. Ignorare o cercare di minimizzare il fascismo e le sue manifestazioni attuali significa trascurare e indebolire le fondamenta stesse della democrazia italiana.Se l’antifascismo è non negoziabile, come si spiega la presenza di un’area politica che il capitolo descrive come ambigua o legata a simboli fascisti?
Il capitolo evidenzia una chiara tensione tra i fondamenti antifascisti della Costituzione e la persistenza di comportamenti, simboli e retoriche che richiamano il fascismo in una specifica area politica. Tuttavia, non approfondisce sufficientemente gli strumenti concettuali e analitici necessari per comprendere questa contraddizione e per distinguere un richiamo storico o simbolico da un effettivo progetto politico neofascista. Per esplorare questa complessa dinamica, è utile approfondire gli studi sulla storia del fascismo e del post-fascismo in Italia, le analisi sulla natura della democrazia e dei suoi avversari, e le ricerche sulla memoria collettiva e l’uso politico dei simboli. Discipline come la storia contemporanea, la scienza politica e la sociologia offrono prospettive cruciali. Tra gli autori che hanno affrontato questi temi, si possono considerare Renzo De Felice, Emilio Gentile, Norberto Bobbio e Umberto Eco.2. Il dimenticatoio della storia italiana
In Italia, c’è una diffusa amnesia storica. Molti aspetti importanti del passato, come la storia del fascismo, del colonialismo, della dittatura e delle deportazioni, sembrano essere dimenticati o messi da parte. Questa mancanza di memoria porta a una visione selettiva della storia. Si tende anche a negare l’esistenza del fascismo, a volte per sminuire l’importanza dell’antifascismo. Questo si vede, ad esempio, nel dibattito sulle Foibe, che viene usato per mettere sullo stesso piano chi era contro il fascismo e chi lo sosteneva.Esempi e confronti
Si assiste anche a una negazione o a un tentativo di minimizzare azioni di stampo fascista. Un esempio è l’assalto alla Camera del Lavoro da parte di gruppi come Forza Nuova, che viene a volte sminuito. Allo stesso modo, alcuni politici usano la parola “fascismo” in modo improprio o distorto per attaccare chi la pensa diversamente. Un fenomeno simile, che mostra un doppio standard, si osserva negli Stati Uniti. Lì, movimenti come “antifa” sono etichettati come terroristi, mentre gruppi come i Proud Boys sono presentati come patrioti. L’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, compiuto da sostenitori di Trump con idee complottiste, evidenzia questa differenza di trattamento rispetto a proteste come quelle di Black Lives Matter.Complottismo e accesso alle armi
Questi gruppi che aderiscono a teorie del complotto, spesso basate su idee assurde, sono in molti casi armati. Negli Stati Uniti, il dibattito sulla facilità con cui si possono ottenere armi è strettamente legato a forti interessi economici e politici. La possibilità di armarsi per difesa personale è un tema ricorrente. Anche in Italia, pur avendo regole sull’accesso alle armi più severe, c’è chi spinge su questa idea, una campagna che finisce per favorire chi produce e vende armi.Le conseguenze della mancanza di memoria
Quando la memoria storica si perde, si fa spazio a idee basate sul complotto, che non hanno fondamento. Si dimenticano i principi fondamentali della nostra Costituzione, le ragioni dietro le convenzioni internazionali e la lunga storia del razzismo. Questa perdita di consapevolezza porta a non rispettare le minoranze e, alla fine, a una diminuzione della nostra umanità. Si arriva al punto in cui persino le vittime non sono ricordate con un nome, ma restano solo “dispersi”. Nonostante questi segnali, c’è chi continua a negare che esista un problema di razzismo.Ma questa “diffusa amnesia storica” è un dato oggettivo o l’interpretazione di parte di un dibattito complesso?
Il capitolo presenta con forza l’idea di una vasta e pericolosa perdita di memoria storica in Italia, legandola direttamente a fenomeni come il complottismo e l’intolleranza. Tuttavia, il concetto di “memoria storica” è esso stesso un terreno di scontro, non una realtà monolitica. Diverse interpretazioni del passato coesistono e competono nello spazio pubblico. Affermare una “dimenticanza” diffusa rischia di semplificare eccessivamente il dibattito, ignorando le ragioni (anche legittime, seppur contestabili) dietro certe narrazioni alternative o le dinamiche complesse della formazione della memoria collettiva. Per approfondire questa tematica e comprendere meglio le sfide legate alla narrazione del passato, è utile esplorare gli studi sulla memoria collettiva e pubblica, la sociologia della storia e le analisi del discorso politico. Autori come Maurice Halbwachs, Pierre Nora o Jeffrey Olick possono offrire strumenti concettuali per analizzare come le società costruiscono, mantengono e trasformano i loro ricordi del passato, evidenziando che la “memoria” è spesso un processo attivo e selettivo, influenzato da dinamiche sociali e politiche, piuttosto che una semplice “dimenticanza”.3. La negazione della realtà
La questione climatica è un esempio centrale di come venga negata la realtà. In diverse forme, si tende a negare che il clima stia cambiando. Questo accade per ragioni profonde: il clima non ha confini, suggerisce un destino comune per tutti i popoli e mette in discussione il sistema economico attuale, che molti difendono. I nazionalisti, convinti di poter affrontare le sfide da soli, trovano particolarmente difficile accettare questa realtà globale che richiede cooperazione. Per contrastare il messaggio scientifico e l’allarme pubblico, si usano spesso tattiche di delegittimazione contro gli oppositori, come è successo nel caso di Greta Thunberg. Questo atteggiamento si inserisce in una visione più ampia che rifiuta la scienza, specialmente quando gli esperti sono quasi unanimemente d’accordo su un tema. Si lega a posizioni nazionaliste e populiste che mirano a difendere lo stato attuale delle cose contro ogni cambiamento, anche quando la situazione sta peggiorando.Altre forme di rifiuto
Questa tendenza a negare la realtà si manifesta in diversi ambiti, non solo quello climatico. Si osserva, ad esempio, nell’atteggiamento definito “No”, che include posizioni come No vax o No euro. Questo approccio si presenta spesso contraddittorio e ipocrita, con l’unica eccezione notevole del rifiuto generalizzato delle tasse. La stessa dinamica si vede nel modo di reagire alle manifestazioni antifasciste: invece di confrontarsi con il tema, si preferisce attaccare chi protesta. Analogamente, si assiste ad attacchi diretti e mirati verso figure pubbliche come Liliana Segre, promossi da specifici movimenti di protesta.Il ‘buonismo’ e la storia
Un altro aspetto legato alla negazione della realtà è quello del cosiddetto “buonismo” italiano. Questa visione tende a minimizzare o giustificare i crimini storici commessi sia in Italia sia nelle ex colonie, come le violenze avvenute in luoghi come la Libia o l’Etiopia. Si tratta di un atteggiamento che cerca di autoassolvere il passato nazionale. Invece di riconoscere le sofferenze inflitte, questo “buonismo” finisce per difendere chi fu responsabile di tali azioni. Questo atteggiamento si pone in netto contrasto con chi, invece, sceglie di mostrare solidarietà e vicinanza nei confronti delle vittime di quei crimini storici.Ma l’opposizione a determinate politiche migratorie o sulla cittadinanza si riduce sempre e solo a complottismo razzista, o esistono altre (seppur discutibili) argomentazioni politiche o sociali che andrebbero considerate per completezza?
Il capitolo lega in modo molto diretto e quasi esclusivo l’opposizione a leggi come lo ius scholae alla teoria della “sostituzione etnica” e al razzismo. Sebbene questa connessione sia indubbiamente presente e spesso centrale nel dibattito, un’analisi più approfondita potrebbe beneficiare dall’esplorare l’intero spettro delle motivazioni addotte dai detrattori di tali leggi, anche quelle che non si configurano immediatamente come complotti, per comprendere meglio la complessità del fenomeno politico. Per approfondire questi aspetti, sarebbe utile consultare studi sulla sociologia delle migrazioni, sull’analisi del discorso politico e sulla teoria del populismo. Autori come Cas Mudde o Teun A. van Dijk offrono strumenti concettuali per analizzare le retoriche politiche e i pregiudizi sociali.6. Frustrazione e Fascismo Eterno
Un diffuso senso di frustrazione nasce da un modello economico percepito come ingiusto e faticoso, dalla mancanza di prospettive per il futuro e dalla scarsa credibilità delle istituzioni. Questa situazione può portare a reazioni che spingono verso soluzioni considerate sbagliate. È necessario affrontare le cause profonde di questa delusione e spiegare chiaramente perché le proposte di fanatici e fascisti sono pericolose e non risolvono i problemi. La politica ha il compito di intervenire sui problemi sociali che generano frustrazione e di contrastare le degenerazioni che proprio su questa frustrazione trovano terreno fertile. Questo è fondamentale perché quanto descritto da Eco è già accaduto in passato e può accadere di nuovo. L’uso di slogan storicamente legati al fascismo, come “Dio, Patria e famiglia”, rientra in questo quadro, anche quando chi li usa nega di essere fascista.I segni del fascismo eterno
Alcuni elementi fondamentali di ciò che Umberto Eco ha chiamato “fascismo eterno” continuano a manifestarsi nella società, dimostrando la persistenza di certi schemi di pensiero e azione. Questi punti includono il culto di una tradizione spesso alterata, la critica verso gli intellettuali, un nazionalismo basato sull’origine nazionale che si oppone all’apertura verso culture diverse, il credere a teorie del complotto, il sessismo e il machismo, e l’opposizione al sistema parlamentare. Si osserva anche l’uso di un linguaggio semplificato fatto di slogan usati per manipolare la descrizione dei fatti sociali e politici. La presenza congiunta di questi elementi, anche in forme apparentemente innocue, richiede grande attenzione da parte di tutti.Ma è davvero così lineare il passaggio dalla frustrazione sociale alla manifestazione del “fascismo eterno”, o questa lettura rischia di semplificare eccessivamente dinamiche ben più complesse?
Il capitolo individua nella frustrazione un terreno fertile per l’emergere di fenomeni riconducibili ai “segni” del fascismo eterno. Tuttavia, l’argomentazione potrebbe beneficiare di una maggiore profondità nell’analisi del nesso causale. Presentare la frustrazione come motore quasi esclusivo rischia di ignorare il concorso di altri fattori determinanti: la crisi delle rappresentanze politiche, l’efficacia di specifiche strategie retoriche e di propaganda, il ruolo dei media, le trasformazioni economiche globali, o le dinamiche psicologiche collettive che vanno oltre il mero senso di delusione. Per arricchire la comprensione di questi processi, sarebbe opportuno confrontarsi con studi di sociologia politica che analizzano le cause del populismo e dell’autoritarismo, o con opere di psicologia delle masse. Autori come Gustave Le Bon, Elias Canetti, o pensatori contemporanei che studiano le crisi della democrazia liberale offrono spunti critici che permettono di contestualizzare e sfidare l’idea di una relazione causa-effetto troppo diretta tra frustrazione e “fascismo eterno”.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]