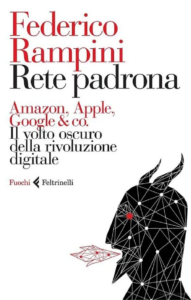1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Non ci possiamo più permettere uno Stato sociale Falso!” di Federico Rampini è un libro che ti prende subito perché sfida un’idea che sentiamo spesso: che lo Stato sociale sia un lusso che non possiamo più permetterci, soprattutto in tempi di crisi economica e globalizzazione. Rampini smonta questa tesi confrontando il tanto decantato “modello americano”, che a ben guardare nasconde disuguaglianza, povertà diffusa e poca mobilità sociale, con quello di paesi europei come la Germania o i paesi nordici. Questi ultimi dimostrano che si può essere competitivi a livello globale mantenendo un forte Welfare State, sindacati solidi e servizi pubblici di qualità. Il libro analizza poi le fragilità dell’Eurozona, esplorando come la crisi abbia messo a nudo problemi strutturali, il ruolo a volte oscuro della finanza e della speculazione, e il dibattito acceso tra l’austerity e nuove idee economiche come la MMT (Modern Monetary Theory), che propone approcci radicalmente diversi alla gestione del debito pubblico. Non manca uno sguardo critico sull’Italia, evidenziandone le debolezze legate alla bassa produttività e a fattori culturali come l’evasione fiscale, che rendono difficile sostenere il modello sociale. In pratica, Rampini non si limita a dire che lo Stato sociale non è morto, ma spiega perché e come alcuni paesi riescono a farlo funzionare, mentre altri, come l’Italia, faticano, suggerendo che la soluzione non è tagliare tutto, ma affrontare i nodi strutturali e culturali che minano la fiducia e l’efficienza. È un viaggio attraverso l’economia e la politica di Stati Uniti ed Europa che ti fa riflettere su cosa significhi davvero prosperità e giustizia sociale oggi.Riassunto Breve
L’America viene spesso vista come un modello vincente, ma la realtà interna mostra molte difficoltà. Milioni di persone vivono in povertà, il reddito medio è diminuito per i lavoratori e la classe media si sta riducendo, creando una società con pochi ricchi e molti con meno potere d’acquisto. La possibilità di migliorare la propria condizione sociale è limitata, inferiore a quella di diversi paesi europei. Chi nasce povero spesso rimane povero. Questo succede anche perché non c’è un sistema di assistenza sociale forte e i sindacati sono deboli. Anche le pensioni private non bastano per molti. Nonostante le tasse non siano molto più basse che in Europa, i servizi pubblici sono scarsi: sanità privata costosa, istruzione pubblica non sempre buona e università a pagamento, trasporti limitati. Il lavoro è poco sicuro, si può essere licenziati facilmente, e le aziende non investono nella formazione dei dipendenti. C’è una grande concentrazione di ricchezza: l’1% più ricco guadagna molto di più, mentre gli altri restano fermi. Questa élite, fatta soprattutto di banchieri e manager, influenza le decisioni del governo, anche grazie a leggi che permettono di spendere molti soldi in politica. Grandi aziende come Walmart mostrano questo tipo di capitalismo aggressivo, con stipendi bassi e molto potere sui fornitori.Esiste però un modello diverso, quello di paesi come Germania e quelli nordici. Loro sono molto competitivi a livello globale pur avendo stipendi alti, sindacati forti, servizi sociali per tutti, attenzione all’ambiente e buona istruzione. Questo dimostra che non è necessario abbassare i salari e i diritti per competere. Questo modello funziona perché è ben finanziato con le tasse. Nei paesi dove ci sono problemi economici, la difficoltà non è la qualità dei servizi, ma l’incapacità di pagarli a causa di debiti e deficit. Questo dipende dalla mancanza di fiducia tra le persone e nelle istituzioni, che porta a molta evasione fiscale e lavoro nero. Dove c’è poca fiducia, il sistema sociale non regge. La Germania, dopo la riunificazione, ha un’economia forte basata sulla stabilità, un certo tipo di capitalismo, accordi tra imprese e sindacati e sindacati moderati. Questo modello, chiamato “capitalismo renano”, potrebbe essere un esempio per l’Europa. Però la Germania non cerca di imporre questo modello, in parte per via della sua storia, in parte perché il suo successo si basa molto sulle esportazioni. Per esportare tanto, altri paesi devono comprare tanto e quindi avere dei debiti. La Germania risparmia e produce, mentre altri spendono. Questo crea uno squilibrio. La Germania è restia a spendere di più al suo interno per aiutare gli altri paesi, vedendo l’economia in modo molto rigido e criticando chi si indebita facilmente.Le crisi finanziarie mostrano che i mercati non sono sempre puliti; ci sono stati casi in cui grandi banche hanno aiutato i governi a nascondere i loro debiti usando strumenti finanziari complicati, guadagnando molto. Un piccolo gruppo di banche controlla il mercato di questi strumenti in modo poco chiaro. Anche le agenzie che giudicano l’affidabilità economica degli stati hanno molto potere e a volte hanno avuto conflitti di interesse. La speculazione finanziaria sfrutta le debolezze dei paesi, come il debito alto. L’euro doveva portare più equilibrio, ma non è diventato un rifugio sicuro come il dollaro, anche perché manca un governo unico europeo e una finanza comune. I problemi dell’eurozona vengono in gran parte da errori fatti al suo interno.Le grandi crisi portano a cambiare le regole. Dopo la crisi del 1929, ci furono leggi per separare le banche normali da quelle che facevano investimenti rischiosi. Questa separazione è stata tolta prima della crisi del 2008, contribuendo ai problemi. Oggi, la crisi richiede nuove regole per la finanza e il lavoro. L’idea di spendere meno (austerity) in Europa peggiora le cose. Non si vuole tornare a uno Stato che controlla tutto, ma si vedono i danni del liberismo estremo. Dall’America arriva una nuova idea, la Modern Monetary Theory (MMT), che dice che uno Stato che stampa la sua moneta non ha limiti di spesa o debito. La banca centrale può finanziare lo Stato stampando soldi, e questo serve per far crescere l’economia, non aumentando le tasse. Secondo questa teoria, l’inflazione diventa un problema solo quando tutti hanno lavoro.L’Italia ha una grande debolezza economica nell’euro, perdendo competitività rispetto alla Germania. Strumenti finanziari di aiuto non risolvono i problemi di fondo, che sono culturali e legati all’inefficienza dello Stato. L’evasione fiscale, la mancanza di senso civico, il favoritismo e la corruzione rendono l’Italia poco produttiva. Gli italiani lavorano molte ore, ma producono meno ricchezza per ora lavorata rispetto a Stati Uniti, Germania e Francia. Dall’arrivo dell’euro, l’Italia ha perso molta produttività verso la Germania. Questa differenza rende difficile stare insieme nell’eurozona, che non ha modi per aiutare i paesi più deboli come fanno gli Stati Uniti tra i loro stati. Senza diventare più produttiva, la posizione dell’Italia nell’euro è difficile. Una visione geopolitica divide l’Europa tra paesi avanzati come la Germania e paesi come Italia, Grecia e Portogallo, che hanno problemi economici più grandi. Questo fa capire che l’Italia deve risolvere i suoi problemi interni per trovare la sua strada.Riassunto Lungo
1. Il Sogno Americano Sotto Esame
La realtà interna degli Stati Uniti è un quadro complesso, lontano dall’immagine di modello superiore spesso contrapposta a un’Europa vista come statalista e in declino. Milioni di americani vivono al di sotto della soglia di povertà. Il reddito medio per i lavoratori a tempo pieno è diminuito rispetto al 1973, e la classe media si sta riducendo. Questo crea una “società a clessidra”, dove pochi sono molto ricchi e una base più ampia di cittadini perde potere d’acquisto, affrontando crescenti difficoltà economiche nella vita di tutti i giorni.Mancanza di opportunità e supporto sociale
La mobilità sociale verso l’alto è limitata, risultando inferiore rispetto a quella di molti paesi europei, come Danimarca e Inghilterra. Gran parte delle persone che nascono nel 20% più povero della popolazione tende a rimanervi anche in età adulta. Questa situazione mette in discussione la validità del mito del Sogno Americano, che promette l’ascesa sociale basata sul merito e sul duro lavoro. La mancanza di un sistema di Welfare State solido e la debolezza delle organizzazioni sindacali contribuiscono significativamente a questa immobilità sociale, lasciando molti cittadini senza una rete di sicurezza adeguata.Servizi pubblici e sicurezza economica
Il sistema pensionistico basato su fondi privati, come i piani 401k, si dimostra insufficiente per garantire una vecchiaia serena a molti, in particolare per la generazione dei baby boomers, costringendoli a continuare a lavorare anche dopo l’età pensionabile. Nonostante la pressione fiscale non sia molto inferiore a quella riscontrata in Europa, i cittadini americani ricevono in cambio pochi servizi pubblici essenziali. La sanità è prevalentemente privata e molto costosa, l’istruzione pubblica è spesso di qualità inferiore e l’accesso all’università richiede pagamenti elevati. Anche i trasporti pubblici sono limitati in molte aree del paese. Il mercato del lavoro è caratterizzato da una generale insicurezza; i dipendenti possono essere licenziati con facilità, il che non spinge le aziende a investire nella formazione dei propri lavoratori, peggiorando ulteriormente la stabilità economica delle famiglie.Concentrazione di ricchezza e influenza politica
Si assiste a una crescente concentrazione di ricchezza e potere nelle mani di pochi. L’1% più ricco della popolazione ha visto i propri redditi aumentare enormemente negli ultimi decenni, mentre la maggioranza dei cittadini ha visto il proprio potere d’acquisto ristagnare o diminuire. Questa élite economica, in particolare lo 0,1% composto in gran parte da banchieri e top manager, esercita un’influenza diretta e significativa sulle politiche governative. Decisioni legali come la sentenza Citizens United hanno ulteriormente rafforzato questo potere, permettendo spese illimitate in politica da parte di aziende e gruppi di interesse. Aziende come Walmart, il più grande datore di lavoro privato al mondo, rappresentano un esempio lampante di questo modello di capitalismo aggressivo, caratterizzato da bassi salari, la distruzione di posti di lavoro nelle piccole imprese locali e un enorme potere contrattuale nei confronti dei fornitori a livello globale, alimentando così l’aumento delle disuguaglianze sociali ed economiche.Quanto è valida la contrapposizione tra un’America in crisi e un’Europa implicitamente presentata come modello, data la complessità e le differenze interne di entrambi i contesti?
Il capitolo imposta un confronto tra Stati Uniti ed Europa che, pur utile per evidenziare le criticità americane, rischia di semplificare eccessivamente la realtà di entrambi i contesti. L’Europa non è un blocco monolitico e presenta al suo interno profonde differenze economiche, sociali e istituzionali. Approfondire le specifiche caratteristiche dei diversi modelli di Welfare State europei e le loro sfide attuali, così come considerare le variazioni regionali e demografiche all’interno degli stessi Stati Uniti, fornirebbe un quadro più sfumato e completo. Per esplorare queste dinamiche comparative e le radici storiche della disuguaglianza, può essere utile consultare studi di economia comparata e sociologia, con particolare attenzione ad autori come Thomas Piketty.2. Il Prezzo della Fiducia Sociale
Molti pensano che la globalizzazione costringa i paesi a ridurre stipendi e diritti per competere. Questo modello, visto in paesi come gli Stati Uniti, suggerisce che per avere successo bisogna impoverirsi. Eppure, paesi come Germania, Olanda, Austria, Svizzera, Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia dimostrano il contrario. Loro competono a livello mondiale mantenendo stipendi alti, sindacati forti, ottimi servizi sociali e sistemi educativi di qualità. Queste nazioni dimostrano che è possibile essere competitivi senza abbassare gli standard di vita dei cittadini.Perché l’austerità?
Anche se il modello tedesco-nordico funziona, la Germania spinge per l’austerità nei paesi del Sud Europa come Italia, Grecia, Spagna e Portogallo, chiedendo tagli alla spesa sociale. Questo sembra strano, ma la ragione è semplice: un modello sociale generoso funziona solo se ci sono abbastanza soldi per pagarlo, e questi soldi vengono dalle tasse. La sostenibilità di questi servizi dipende interamente dalla capacità dello stato di raccogliere fondi sufficienti. Se le entrate fiscali non coprono le spese, il sistema va in crisi.La Fiducia e le Tasse
Nei paesi che faticano, i servizi pubblici spesso sono di buona qualità, ma non ci sono i soldi per mantenerli. Questo succede perché per anni si è speso più di quanto si è incassato con le tasse, creando debiti e deficit enormi. Alla base di questo problema c’è la mancanza di fiducia: la fiducia tra le persone e la fiducia nelle istituzioni dello stato. Quando la fiducia è poca, molti cercano di non pagare le tasse e lavorano ‘in nero’. Questo significa che tante persone usano i servizi pubblici – sanità, istruzione, trasporti – ma non contribuiscono a pagarli. Questa evasione diffusa, insieme a una pubblica amministrazione che a volte non funziona bene, rende impossibile finanziare un sistema di welfare generoso.Un Patto Sociale Necessario
Quindi, i paesi dove le persone si fidano, pagano le tasse e rispettano le regole possono permettersi un sistema di assistenza sociale forte. Al contrario, dove c’è poca fiducia e molta evasione, il sistema non regge e crolla. Per questo, paesi come la Germania trovano difficile aiutare nazioni dove i cittadini non sentono il dovere di contribuire e rispettare le leggi fiscali. Il sistema europeo di benessere e solidarietà funziona davvero solo se tutti i paesi si basano su un accordo forte tra i cittadini, fatto di lealtà e volontà di dividere i costi per il bene comune. Questo accordo, un vero patto sociale, è fondamentale perché il modello europeo possa essere sostenibile e giusto per tutti i suoi membri.Ridurre la sostenibilità del welfare alla sola ‘fiducia’ non rischia di ignorare un quadro ben più complesso?
Il capitolo presenta la fiducia come il perno attorno a cui ruota la sostenibilità del sistema di welfare e la capacità di competere globalmente. Sebbene la fiducia e la conseguente propensione al rispetto delle regole fiscali siano indubbiamente cruciali, l’argomentazione rischia di semplificare eccessivamente un fenomeno multidimensionale. La funzionalità di uno stato sociale e la sua capacità di finanziarsi dipendono anche dalla qualità intrinseca delle istituzioni (efficienza della pubblica amministrazione, giustizia, contrasto alla corruzione), dalla struttura economica del paese, dalle politiche industriali, dalla distribuzione della ricchezza e da fattori storici e politici specifici. Concentrarsi quasi esclusivamente sulla “fiducia” come causa principale delle differenze tra i modelli rischia di trascurare queste altre leve fondamentali. Per approfondire la complessità di questi temi, si possono esplorare gli studi sull’economia istituzionale, la scienza politica comparata e la sociologia economica. Autori come Acemoglu, Putnam o Esping-Andersen offrono prospettive più ampie sui fattori che determinano il successo istituzionale, il capitale sociale e la varietà dei modelli di welfare state.3. Il paradosso della virtù esportatrice
Dopo la riunificazione, la Germania si trovò con un’economia molto solida e un modello sociale considerato un esempio di stabilità. Questo sistema, spesso chiamato “capitalismo renano”, si basava su pilastri precisi: una moneta forte e stabile, un tipo di capitalismo tradizionale, la collaborazione strutturata tra imprese e sindacati (nota come Mitbestimmung) e una generale moderazione da parte delle organizzazioni sindacali nelle richieste salariali. Queste caratteristiche rendevano il modello tedesco estremamente interessante per le altre nazioni europee. Molti si chiedevano se l’Europa intera potesse adottare un approccio simile, pensando a una sorta di “germanizzazione” del continente sul piano economico e sociale. Sembrava che la Germania avesse la forza e il modello giusto per esercitare una grande influenza.Perché la Germania non ha guidato l’Europa
Nonostante questo potenziale, la Germania non ha esercitato pienamente la sua influenza politico-culturale. In parte, questo dipende dalla storia: il ricordo delle guerre passate la rende una “superpotenza timida”, poco incline a imporre la sua visione. C’è anche una ragione economica: il modello tedesco si basa molto sulle esportazioni, mantenendo sempre attivi commerciali elevati. Per vendere molto all’estero, altri paesi devono comprare molto, finendo spesso in disavanzo. La “virtù” tedesca del risparmio, necessaria per esportare più di quanto si consuma, richiede il “vizios” di altri paesi, che devono spendere e indebitarsi.Lo squilibrio e la crisi del 2008
Questo squilibrio a livello mondiale è diventato molto chiaro con la crisi economica del 2008. Paesi come gli Stati Uniti si sono trovati molto indebitati a causa dei loro consumi, mentre nazioni come Cina, Giappone e Germania erano grandi creditori ed esportatori. La “dottrina Obama” propose di riequilibrare la situazione: i paesi indebitati dovevano risparmiare, mentre quelli con grandi risparmi (e surplus) dovevano spendere di più al loro interno per aiutare l’economia globale. La Germania è stata tra i paesi che hanno fatto meno per aumentare la spesa interna.La visione economica tedesca
La resistenza tedesca a spendere di più si basa su una visione dell’economia vista quasi come una regola morale, dove è fondamentale non spendere mai più di quanto si guadagna. C’è una forte diffidenza verso modelli basati sul credito facile, come quello anglo-americano, considerato la causa della crisi. Questa prospettiva, però, non tiene conto delle idee di economisti come Keynes. Secondo queste idee, in momenti di crisi con molte risorse non utilizzate (come lavoratori disoccupati o fabbriche ferme), aumentare la spesa pubblica, anche indebitandosi, può essere necessario per far ripartire l’economia e, in futuro, aumentare le entrate dello stato.Moneta forte e le scelte strategiche
La Germania ha mantenuto una politica monetaria rigorosa e una moneta forte, cosa che spinge le sue industrie a competere sui mercati esteri puntando su alta tecnologia e qualità, non sui prezzi bassi. Questo supporta il modello basato sulle esportazioni. La scelta di non diffondere attivamente il proprio modello in Europa può essere vista sia come una prudenza dovuta alla sua storia, sia come una decisione per mantenere la propria forte posizione, che in parte dipende dagli squilibri con gli altri paesi. A differenza di nazioni come gli Stati Uniti, la Germania non ha investito molto per promuovere le sue idee e i suoi valori (“soft power”) in Europa.L’idea che uno Stato che emette la propria moneta possa spendere “illimitatamente” finanziato dalla banca centrale, con l’inflazione che diventa un rischio “concreto solo quando l’economia opera in condizioni di pieno impiego”, non ignora forse i pericoli di svalutazione, instabilità finanziaria e i numerosi esempi storici di iperinflazione causata da un eccessivo finanziamento monetario?
Il capitolo presenta la Modern Monetary Theory (MMT) come una soluzione innovativa e una sfida all’ortodossia, sottolineando l’assenza di limiti alla spesa per uno Stato sovrano che emette la propria moneta. Tuttavia, questa affermazione centrale della MMT, così come la sua tesi sull’inflazione, è estremamente controversa e non trova consenso unanime tra gli economisti. Il capitolo non esplora a fondo le critiche mosse a questa teoria, né considera i rischi concreti che un finanziamento monetario su larga scala potrebbe comportare, indipendentemente dal livello di occupazione, in termini di perdita di valore della moneta, fuga di capitali o bolle speculative. Per comprendere meglio la complessità del dibattito e le potenziali insidie di un approccio basato sul finanziamento illimitato, sarebbe utile approfondire le critiche alla MMT, studiare la storia monetaria e i casi di iperinflazione (anche in contesti non di pieno impiego), e confrontarsi con le posizioni di economisti che mettono in guardia contro i rischi di un eccessivo intervento monetario, come ad esempio quelle riconducibili alla scuola austriaca o a molti economisti monetaristi.6. Il Peso della Cultura e la Nuova Mappa del Mondo
L’Italia affronta una notevole fragilità economica all’interno dell’unione monetaria europea. Questa debolezza è segnata da una perdita costante di competitività rispetto alla Germania, che si protrae da tempo. Strumenti finanziari come i fondi salva-Stati o gli scudi anti-spread non riescono a risolvere questi squilibri che affondano le radici nella struttura stessa del sistema economico e sociale del paese. La causa principale di questa situazione risiede in problemi di natura culturale e nell’inefficienza dell’apparato statale.Le cause della bassa produttività
Secondo un’analisi del «Washington Post», l’evasione fiscale diffusa, la scarsa partecipazione civica, il favoritismo basato su legami personali (nepotismo) e la corruzione contribuiscono a creare una crisi di produttività che sembra non avere fine. Nonostante gli italiani dedichino molte ore al lavoro ogni anno (circa 1744), la quantità di ricchezza prodotta per ogni ora lavorata è bassa, attestandosi intorno ai 45 dollari di PIL. Questo dato è significativamente inferiore rispetto a paesi come gli Stati Uniti, dove si superano i 60 dollari, o Germania e Francia, che si posizionano oltre i 55 dollari. Dall’adozione dell’euro, l’Italia ha visto la sua produttività diminuire del 30% rispetto alla Germania.Il contesto dell’Eurozona
Questo ampio divario nella capacità di produrre ricchezza in modo efficiente rappresenta il punto debole dell’unione monetaria. A differenza di sistemi economici più integrati, come quello degli Stati Uniti, l’Eurozona non dispone di meccanismi efficaci per compensare le differenze tra le economie dei paesi membri. Mancano, ad esempio, la possibilità per i lavoratori di spostarsi facilmente dove c’è più richiesta o forme di condivisione delle risorse fiscali tra gli Stati. Questa mancanza rende difficile la convivenza all’interno della stessa area monetaria per economie con livelli di produttività così diversi. Senza un deciso miglioramento della produttività, la partecipazione dell’Italia all’euro appare difficile da sostenere nel lungo periodo, con i settori meno efficienti che finiscono per pesare su quelli più dinamici e di successo.Una diversa visione del mondo
Una prospettiva geopolitica che considera i legami culturali e storici, proposta da studiosi come Joel Kotkin, offre una nuova interpretazione della mappa globale. Secondo questa visione, l’Europa si divide in aree distinte. Da un lato, emerge una “Lega Anseatica” guidata dalla Germania, caratterizzata da una forte proiezione internazionale, elevati livelli di istruzione e una spiccata capacità di innovazione. Dall’altro lato, si trovano le “Repubbliche dell’Olivo”, che includono paesi come Italia, Grecia e Portogallo. Queste nazioni condividono radici culturali profonde, ma mostrano significative distanze sul piano economico, evidenziate da tassi di povertà più elevati, una minore percentuale di popolazione attiva e un alto livello di debito pubblico. Questa interpretazione, pur essendo stimolante e a tratti provocatoria, sottolinea l’urgenza per l’Italia di affrontare le proprie inefficienze strutturali e individuare un percorso di sviluppo che tenga conto di queste specificità.Ma è davvero la “cultura” la causa principale dei problemi economici italiani, o questa visione rischia di essere una semplificazione eccessiva che ignora fattori strutturali e di contesto?
Il capitolo pone una forte enfasi sui problemi “culturali” e sull’inefficienza statale come radice della bassa produttività e della fragilità economica italiana, citando anche una divisione geopolitica in blocchi culturali come le “Repubbliche dell’Olivo”. Sebbene questi fattori abbiano indubbiamente un peso, l’argomentazione potrebbe beneficiare di un’analisi più approfondita su come esattamente questi elementi culturali si traducano in specifici meccanismi economici di inefficienza, e su quanto altri fattori, come la struttura industriale del paese, le politiche europee specifiche, gli investimenti in ricerca e sviluppo, o le dinamiche del mercato del lavoro, contribuiscano al divario di produttività. Per esplorare queste sfumature, sarebbe utile approfondire gli studi di economia istituzionale, che analizzano l’impatto delle regole e delle norme (formali e informali) sull’economia, e confrontare diverse scuole di pensiero sull’analisi della produttività e della competitività internazionale. Autori come Daron Acemoglu o Robert Gordon offrono prospettive diverse su questi temi.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]