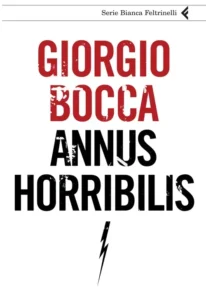1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Noi terroristi. 12 anni di lotta armata ricostruiti e discussi con i protagonisti” di Giorgio Bocca ti catapulta negli anni Settanta in Italia, un decennio di trasformazioni profonde e spesso caotiche. Questo libro non è solo una cronaca, ma un tentativo di capire dall’interno la nascita e lo sviluppo della lotta armata, esplorando la sovversione giovanile, il declino della classe operaia tradizionale e il senso di esclusione di molti giovani. Attraverso le pagine, incontrerai le Brigate Rosse, i NAP, Prima Linea e altri gruppi, analizzando le loro motivazioni, spesso un mix di idealismo, impazienza e fraintendimenti della realtà sociale e industriale. Il racconto si snoda tra le fabbriche di Torino e Milano, le piazze infuocate, le prigioni del popolo dove furono detenuti personaggi come Aldo Moro e Mario Sossi, e le risposte dello Stato, dal generale Dalla Chiesa al controverso uso del pentitismo e della tortura. È un percorso per comprendere le dinamiche interne del terrorismo, i conflitti tra capi come Curcio e Moretti, e come un’intera generazione ha percorso un cammino violento che l’ha portata alla sconfitta, lasciando un segno indelebile nella storia d’Italia.Riassunto Breve
Gli anni Settanta in Italia sono un periodo di grandi cambiamenti, finiscono le certezze del dopoguerra e l’industria inizia a declinare, anche se c’è molta mobilitazione operaia. In questo clima nasce una forte sovversione giovanile, fatta di movimenti studenteschi e operai autonomi, molto diversi tra loro e senza un progetto politico chiaro, ma uniti dal rifiuto del passato e dalla sensazione di essere esclusi. La lotta armata non appare dal nulla, ma cresce dalle proteste, vista da alcuni come l’unica via per affrontare le tensioni sociali che i partiti e i sindacati non riescono a gestire. È una scelta quasi personale per molti, un modo per sentirsi vivi. Questo periodo è una “guerra strisciante” che colpisce persone importanti, portando violenza e morte nella vita di tutti i giorni. La sovversione giovanile si sbaglia, pensa che il declino sia l’inizio di una rivoluzione, ma non capisce i veri cambiamenti in atto, come la deindustrializzazione, perché manca una cultura che spieghi cosa sta succedendo. I giovani che scelgono la violenza non hanno guide chiare e agiscono più per istinto e idee sbagliate sulla realtà, finendo per essere sconfitti. I primi brigatisti, che compaiono tra il 1969 e il 1971, sono giovani impazienti che vogliono agire subito contro il capitalismo, si sentono diversi dai vecchi rivoluzionari perché “fanno quel che dicono”. Per loro, liberarsi da una vita già decisa si lega alla politica. Si dicono marxisti, ma in realtà sono più idealisti, vogliono cambiare tutto subito. Oltre alle Brigate Rosse (BR), ci sono tanti altri gruppi, spesso piccoli e che durano poco, che usano la violenza nelle piazze e hanno idee confuse. Non capiscono bene la classe operaia, che vedono come un blocco unico. Molti di questi gruppi spariscono presto. Un aspetto importante è il “cattocomunismo”, molti brigatisti vengono da ambienti cattolici e passano dalla fede religiosa a quella rivoluzionaria, portandosi dietro il bisogno di dogmi e l’idea di un paradiso in terra. Giangiacomo Feltrinelli, un editore ricco, si unisce alla lotta armata, ma la sua visione è un po’ vecchia, legata alla Resistenza, e non capisce i cambiamenti sociali. Muore nel 1972 mentre mette una bomba. Le BR nascono dalle lotte in fabbrica, usano violenza contro i capi e si nascondono tra gli operai. Imparano a rubare auto e falsificare documenti. I primi sequestri, come quello di Macchiarini, sono tentativi di “giustizia operaia” ma mostrano che la realtà è più complicata. Le BR pensano che la gente non li denunci perché li appoggia, vedono la paura o la diffidenza verso lo stato come consenso. Ma la gente è più furba, usa la situazione a suo vantaggio ma non partecipa alla lotta armata. Le BR cambiano strategia, attaccano direttamente lo stato, che chiamano “Stato imperialista delle multinazionali” (SIM), visto come un nemico unico e potente. L’attacco alla Fiat e il sequestro Amerio nel 1973 cercano di portare la guerriglia in fabbrica, ma l’isolamento delle BR aumenta con la violenza. Il sequestro del giudice Sossi nel 1974 è un’operazione lunga e complessa, fatta per esporre presunti piani segreti e spingere il PCI a un’alleanza, ma il PCI si avvicina alla DC. Sossi si mostra diverso da come appare in pubblico, e questo crea divisioni nello stato sulla trattativa. La Corte d’Appello lo libera, ma il governo e il PCI bloccano tutto. Il caso Sossi spinge le BR a diventare più organizzate e militari, creando una struttura con direzioni e fronti, a scapito della base. Il rapporto con il PCI è difficile, all’inizio c’è ambiguità, ma poi il PCI si allontana per le azioni BR. C’è una parte della base comunista che pensa ancora alla lotta armata. Il terrorismo di sinistra nasce anche dalla delusione di giovani che finiscono per politicizzare la criminalità. La storia di Silvano Girotto, “Frate Mitra”, mostra i legami tra estrema sinistra e servizi segreti, lui collabora con i carabinieri e porta all’arresto di Curcio e Franceschini nel 1974. Questi arresti colpiscono molto le BR. Intanto, nel Sud Italia, nascono i NAP (Nuclei Armati Proletari), che si occupano dei carcerati e del “proletariato illegale”. Sono meno organizzati delle BR e subiscono molte perdite, poi le BR assorbono una parte dei NAP a Roma. Le BR hanno due anime: i “movimentisti” come Curcio, impulsivi e legati all’azione, e gli “organizzativisti” come Moretti, più prudenti e attenti alla pianificazione. Gli organizzativisti prendono il sopravvento perché i movimentisti vengono arrestati prima. La liberazione di Curcio dal carcere è un’azione rischiosa fatta per motivi emotivi. La morte di Mara Cagol, figura importante, segna un passaggio per le BR, che diventano più rigide. Le forze dell’ordine, con Dalla Chiesa, migliorano le indagini usando informatori e controlli. Dopo il 1975, il terrorismo continua per la crisi sociale, nasce un “terrorismo diffuso” nelle periferie, fatto da giovani che cercano azione e usano le armi, a volte mascherando rapine come azioni politiche. Le BR di Moretti si riorganizzano, diventano una “macchina guerrigliera” efficiente, puntano all’autonomia logistica e giustificano gli omicidi come colpi contro il sistema. I vecchi brigatisti criticano questa svolta militarista. Nonostante le critiche, le BR di Moretti sono operative. Le BR diventano più efficienti con azioni come l’attacco a Coco e il sequestro Costa per finanziarsi. A Torino, un piccolo gruppo di brigatisti operai terrorizza la città, colpendo capi Fiat e figure dello stato e del PCI, come Casalegno e Berardi. La colonna BR di Genova si infiltra nelle fabbriche e colpisce figure legate all’industria e al PCI, come Guido Rossa, ucciso perché considerato una spia. Intanto, nel 1977, nasce un movimento sociale diffuso, spontaneo e violento, fatto di studenti e emarginati, che si scontra con la polizia e il PCI. La fine della vita contadina crea disagio, soprattutto nelle città universitarie come Padova, dove nasce l’Autonomia, un movimento che cerca certezze e giustifica la violenza, occupando università e saccheggiando. L’Autonomia è organizzata in modo paramilitare e ha leader che incitano alla violenza. Il Movimento del ’77 è una massa di giovani imprevedibili, diversi dalle BR, che legittimano la violenza diffusa. Dall’Autonomia nasce Prima Linea (PL), un gruppo militarista che cerca di dare ordine al caos, ma è approssimativo e crede in una guerra civile imminente. PL si vede come un esercito di liberazione e usa la violenza diffusa, mescolando militanza e vita privata, formando un “branco”. Le azioni violente, come le gambizzazioni e gli omicidi, sembrano quasi normali per loro, spinti dalla paura di non contare nulla. Lo stato risponde al terrorismo con il generale Dalla Chiesa, che usa metodi duri e non sempre legati alle garanzie legali, puntando su specialisti e controllo del territorio. Le città diventano più sicure, ma la società vive nella paura. Le BR decidono di colpire il “cuore dello stato” e scelgono Aldo Moro, visto come il centro del potere DC. L’obiettivo è dimostrare che la rivoluzione è possibile e ottenere il riconoscimento dei prigionieri. L’azione in via Fani nel 1978 è un attacco militare preparato, basato sulla sorpresa. Il rapimento di Moro sconvolge il paese. Durante la prigionia, Moro si mostra un politico esperto, diverso da come lo vedevano le BR. Lo stato, guidato da Andreotti e appoggiato dal PCI, sceglie la linea della “fermezza” totale, rifiutando ogni trattativa pubblica. Nonostante i tentativi di mediazione, le BR uccidono Moro il 9 maggio 1978, anche per la pressione dello stato. Il corpo viene lasciato in via Caetani per colpire DC e PCI. L’azione è un successo militare ma porta a una crisi interna nelle BR. Dopo Moro, le BR reclutano giovani meno preparati, l’organizzazione peggiora. L’ideologia si frammenta, i nemici diventano tanti. La direzione BR non sa sfruttare il successo politico. Intanto, l’industria cambia con la robotizzazione, il ruolo degli operai e del sindacato cambia. Le aziende reagiscono con forza all’estremismo. Anche PL cambia dopo il 1978, diventa più violenta e irrazionale, spinta dalla repressione e dalla rivalità con le BR. Le azioni di PL diventano sempre più simboliche e scollegate dalla politica. La “marcia dei quarantamila” a Torino nel 1980 mostra il rifiuto della violenza da parte della società. Il pentitismo aiuta a smantellare i gruppi armati. Il gruppo “28 marzo” è un esempio di terrorismo giovanile borghese, legato a problemi familiari, che colpisce giornalisti come Tobagi. Le BR attraversano una crisi profonda tra il 1979 e il 1981, si dividono in diverse fazioni per le differenze sulla strategia. Il sequestro D’Urso nel 1980, guidato da Giovanni Senzani, serve a Senzani per affermare la sua leadership e la sua idea di “partito guerriglia”, che include anche il mondo carcerario. I prigionieri cercano di mantenere un ruolo politico. La crisi delle BR mostra una grande confusione e una violenza sempre meno capita. Dopo i colpi subiti, le BR lasciano Milano, dove nasce la colonna Walter Alasia, più legata alle fabbriche e alle lotte sindacali, ma che pratica l’omicidio politico. La Walter Alasia opera quasi da sola e critica la leadership di Moretti. La rottura tra le BR centrali e la Walter Alasia diventa definitiva. Le BR morettiane sono in declino, Moretti viene arrestato grazie a un informatore. Giovanni Senzani prende il controllo di una parte delle BR con il suo “partito guerriglia”, cercando nuove idee e includendo le “tensioni sociali” e le “devianze”. Il sequestro Cirillo a Napoli è l’azione più nota di questo gruppo, che include una trattativa per il riscatto con la DC e forse contatti con la camorra. Il gruppo di Senzani è fragile e i suoi membri collaborano subito con la giustizia. La sua idea di un nuovo proletariato rivoluzionario non funziona. Il sequestro del generale americano Dozier nel 1981 è un’azione fatta male che porta lo stato a usare metodi non garantisti. Dopo la liberazione di Dozier nel 1982, i brigatisti catturati vengono torturati dalla polizia. Nonostante le prove, il governo nega o minimizza. Il terrorismo spinge lo stato a fare leggi più dure, con carceri speciali e più potere alla polizia. Viene introdotta la legge sui pentiti, che dà sconti di pena a chi collabora, ma viene criticata perché premia il tradimento e si basa sulle delazioni. I detenuti reagiscono con violenza contro i pentiti in carcere. Anche se il terrorismo è sconfitto, la questione della giustizia e del trattamento dei detenuti, molti dei quali giovani che hanno seguito altri, rimane aperta.Riassunto Lungo
1. L’Avanguardia Perduta
Gli anni Settanta in Italia portano una trasformazione profonda, segnando la fine delle certezze del dopoguerra, come l’idea di progresso continuo e l’espansione industriale. Il 1970 vede il picco dell’occupazione industriale, da cui inizia il declino della classe operaia, anche se appare ancora forte e mobilizzata. In questo clima di cambiamento, emerge una sovversione tra i giovani, con movimenti studenteschi e operai autonomi. Non è una rivoluzione organizzata, ma una rapida mutazione sociale. Il movimento è molto vario, senza un piano politico chiaro, e unisce idee diverse. Un punto in comune è il rifiuto della cultura e delle sicurezze delle generazioni precedenti, perché molti giovani si sentono messi da parte o schiacciati dai cambiamenti in corso.La Scelta della Violenza
La lotta armata non nasce all’improvviso, ma si sviluppa gradualmente dalle forme di protesta che la precedono. Alcuni la vedono come l’unica strada possibile, quasi un effetto fisico delle tensioni sociali che i modi tradizionali di fare politica e sindacato non riescono a gestire. Per alcuni, scegliere la lotta armata diventa una questione quasi esistenziale, un modo per affermare chi sono. Questa fase è segnata da una “guerra strisciante” che colpisce persone importanti, riportando la violenza e la morte nella vita di tutti i giorni. Le esperienze dirette, come l’arresto e il ferimento di Giorgio Semeria o la descrizione del conflitto come un “labirinto” di specchi fatta da Enzo Fontana, mostrano la brutalità e la confusione di quel periodo difficile.Un’Avanguardia Fuori Tempo
La sovversione giovanile degli anni Settanta si rivela essere una sorta di “avanguardia fuori tempo”. C’è un errore nel capire l’epoca: si scambia un momento di declino per l’inizio di una nuova era rivoluzionaria. Questo succede in parte perché manca una cultura capace di capire i cambiamenti in atto, sia nei partiti di sinistra che nella società in generale. I giovani che si ribellano non hanno guide culturali solide o un’analisi chiara di come stanno cambiando l’economia e la società, non vedono la rivoluzione informatica o la deindustrializzazione. Spesso agiscono spinti da sentimenti personali, da sogni di un mondo perfetto e da una visione non corretta della realtà e della storia. Questo li porta a scegliere una strada violenta che alla fine li porta alla sconfitta.Affermare che la violenza politica degli anni Settanta derivi principalmente da un “errore nel capire l’epoca” non rischia di ignorare altre cause profonde e complesse?
Il capitolo propone una lettura interessante, identificando nella mancata comprensione dei cambiamenti economici e sociali (come la deindustrializzazione e la rivoluzione informatica) una causa centrale dell’azione dell’avanguardia giovanile, portandola a una scelta violenta e alla sconfitta. Tuttavia, ridurre un fenomeno così complesso e tragico a un mero “errore di analisi” rischia di semplificare eccessivamente le motivazioni e le dinamiche in gioco. Per cogliere appieno le radici della lotta armata e della sovversione di quel decennio, è fondamentale integrare questa prospettiva con l’analisi del contesto politico specifico, delle ideologie che animavano i movimenti, delle interazioni con le istituzioni e del clima sociale generale. Approfondire la storia politica e sociale degli anni Settanta, studiando autori che hanno analizzato il periodo da diverse angolazioni, può offrire una visione più completa e sfaccettata, evitando spiegazioni riduttive.2. Impazienza e Fede Rivoluzionaria
I primi brigatisti, attivi tra il 1969 e il 1971, erano giovani animati da una forte impazienza e dal desiderio di agire subito contro il sistema capitalistico. Si definivano come coloro “che facevano quel che dicevano”, volendo distinguersi dai rivoluzionari di un tempo per la loro trasparenza e coerenza. In questi giovani, il bisogno di liberarsi da una vita che sentivano già decisa si univa strettamente alla spinta politica. Anche se si consideravano marxisti, la loro visione tendeva a un idealismo forte, con il desiderio di cambiare tutto e ottenere risultati immediati. Questa sicurezza nell’azione li accompagnava anche quando le loro idee sembravano lontane dalla realtà concreta.Altri Gruppi Sovversivi
Accanto alle Brigate Rosse, in quel periodo esistevano molti altri gruppi che cercavano la sovversione, spesso senza durare a lungo. Questi gruppi si facevano notare nelle piazze, usavano servizi d’ordine armati e lanciavano slogan che parlavano al mondo intero. Le differenze tra le loro idee non erano sempre chiare, e la ricerca di potere riguardava sia piccoli ambienti come università o fabbriche, sia l’idea di una rivoluzione globale. C’era una visione sbagliata della classe operaia, immaginata come un blocco unico pieno di grandi qualità, mentre in realtà era molto diversa al suo interno e divisa. I capi più intellettuali provavano a capirla, ma i loro piani, come occupare le fabbriche senza che gli operai fossero d’accordo, mostravano quanto fossero lontani dalla realtà. Questi gruppi vivevano di simboli e momenti importanti, come i funerali politici che univano persone di diverse provenienze sociali. Anche se dicevano di voler combattere l’imperialismo, la loro azione si concentrava su scontri nelle città e tra cittadini, evitando obiettivi militari importanti. La maggior parte di questi gruppi scomparve in poco tempo.Il Legame con il Cattocomunismo
Un aspetto particolare di quest’area di sovversione è il legame che viene chiamato “cattocomunismo”. Esiste infatti una connessione tra chi ha fondato le Brigate Rosse e alcuni gruppi di origine cattolica. Questi gruppi condividevano l’idea di doversi liberare dall’oppressione del sistema capitalistico. La cultura laica aveva poco spazio, mentre le tradizioni cattolica e comunista venivano portate agli estremi. Molti dei capi e dei membri più attivi venivano da ambienti cattolici. Il passaggio dalla fede religiosa a quella rivoluzionaria avveniva spesso in modo diretto, mantenendo alcuni bisogni tipici: la ricerca di verità assolute, una solidarietà molto forte quasi fanatica, e l’attesa di un mondo ideale qui sulla terra. Questa mentalità che abbracciava ogni aspetto della vita si manifestava in un misto di visione negativa del presente e attesa di un futuro migliore quasi miracoloso.Dato quanto descritto nel capitolo, non sorge spontaneo chiedersi se questa “fede rivoluzionaria”, così idealistica e spesso distante dalla realtà concreta e dal consenso della classe operaia, non fosse più un fenomeno di auto-affermazione ideologica che un progetto politico realmente radicato?
Il capitolo descrive efficacemente l’impazienza e l’idealismo dei primi brigatisti e di altri gruppi, evidenziando il loro distacco dalla realtà della classe operaia e la prevalenza di azioni simboliche. Tuttavia, la natura esatta di questa “fede rivoluzionaria” e il suo legame con le radici culturali, inclusa l’influenza del “cattocomunismo”, meriterebbero un’analisi più approfondita per comprendere come e perché si sia sviluppata una visione così disconnessa dalla base sociale che si pretendeva di rappresentare. Per esplorare queste lacune, è utile approfondire la storia intellettuale e sociale dell’Italia di quel periodo, studiando autori che hanno analizzato le dinamiche dei movimenti politici radicali, il rapporto tra intellettuali e classi popolari, e le specifiche commistioni ideologiche che caratterizzarono gli anni ’70.3. Dalla Villa alla Clandestinità: Percorsi Incrociati
Giangiacomo Feltrinelli, uomo di origini agiate e noto editore, scelse di intraprendere la lotta armata, facendosi conoscere con il nome di battaglia “Osvaldo”. La sua figura appare complessa e suscita valutazioni diverse tra chi lo conobbe. Alcuni ex partigiani lo vedevano come un possibile ponte con le esperienze rivoluzionarie sudamericane, pur ritenendo superata la sua preoccupazione per un imminente colpo di stato fascista e la sua idea di guerriglia urbana. I membri storici delle Brigate Rosse provavano stima politica nei suoi confronti, ma lo trovavano di difficile comprensione, diviso tra i suoi contatti internazionali e una visione ancora legata ai tempi della Resistenza. Notavano come non riuscisse a cogliere pienamente i cambiamenti sociali avvenuti tra il ’68 e il ’69, ma ammiravano il coraggio dimostrato nell’abbandonare la sua vita privilegiata.Il percorso politico di Feltrinelli
Il percorso politico di Feltrinelli fu inizialmente incerto, caratterizzato dalla ricerca di riconoscimento e dalla fondazione dell’Istituto Feltrinelli. Dopo il 1968, la sua attività sovversiva si intensificò, concentrandosi sulla preparazione di una resistenza armata contro un temuto golpe fascista. Richiamava apertamente l’esperienza dei Gruppi di Azione Partigiana, ma le sue prime azioni concrete rimasero limitate. Scelse di vivere in clandestinità pur non essendo attivamente ricercato, cambiando aspetto e acquistando proprietà usando false identità. La sua vita terminò tragicamente a Segrate nel 1972, dilaniato dall’esplosivo che stava piazzando su un traliccio.La nascita e l’azione delle Brigate Rosse
Le Brigate Rosse emersero intorno al 1970, trovando terreno fertile nelle lotte operaie delle fabbriche. Utilizzavano la violenza e la diffusione di volantini contro i dirigenti, interpretando e cavalcando il malcontento presente negli ambienti di lavoro. Operavano in una sorta di “clandestinità di massa” direttamente all’interno delle fabbriche. L’azione compiuta a Lainate nel 1971 rappresentò un momento chiave che le portò all’attenzione pubblica. Iniziarono a perfezionare tattiche tipiche della lotta urbana, come il furto di automobili e la falsificazione di documenti.Dibattiti interni e prime azioni
All’interno del gruppo si sviluppò un dibattito significativo riguardo alla gestione del “logistico”, ovvero le attività di supporto pratico: era meglio affidarle a specialisti o coinvolgere direttamente gli operai? Prevalse l’approccio tecnico e specialistico, che in seguito si rivelò una debolezza, diventando una fonte di pentiti. I primi sequestri, come quelli di Macchiarini, Labate e Mincuzzi, furono concepiti come tentativi di attuare una “giustizia proletaria”. Tuttavia, queste azioni misero in luce la complessità umana delle vittime e, in alcuni casi, l’atteggiamento opportunistico di certi operai. La base operaia su cui le BR contavano iniziò a ridursi a causa delle ristrutturazioni industriali, segnale di un fallimento strategico. Nonostante l’impatto mediatico, la forza numerica delle Brigate Rosse rimase sempre piuttosto limitata nei primi anni.Le Brigate Rosse e i media
Il rapporto delle Brigate Rosse con i mezzi di informazione fu caratterizzato da ostilità, nonostante il loro desiderio implicito di ottenere consenso e visibilità. Questa contraddizione derivava in parte da un certo provincialismo e da pregiudizi radicati all’interno del gruppo. Dal canto suo, la stampa faticava a comprendere la natura del fenomeno, contribuendo a creare immagini spesso distorte della realtà delle BR. Le Brigate Rosse, nate dai movimenti sociali, finirono per vivere sempre più nel riflesso mediatico, arrivando a misurare il successo delle proprie azioni in base allo spazio che riuscivano a conquistare sui giornali. La conoscenza diretta e reale della loro organizzazione e dei loro obiettivi venne progressivamente meno, sostituita da una percezione romanzesca e superficiale. La debolezza teorica delle Brigate Rosse e l’ignoranza della stampa contribuirono insieme a definire questa percezione pubblica. La loro comunicazione scritta, affidata a documenti e volantini, ebbe scarso peso nel dibattito pubblico; veniva studiata quasi esclusivamente dalle forze dell’ordine. In definitiva, la “critica delle armi”, ovvero le azioni violente, si dimostrò più chiara e comprensibile al pubblico rispetto alla “critica delle idee” che intendevano promuovere.Davvero il sequestro Cirillo si riduce a una ‘complessa trattativa’, o il capitolo omette di affrontare le torbide implicazioni politiche e i dibattiti ancora aperti su quell’evento?
Il capitolo, pur menzionando il sequestro Cirillo e la sua trattativa, non approfondisce adeguatamente le dinamiche politiche e istituzionali che lo caratterizzarono, né le controversie che ancora oggi lo circondano. Per comprendere appieno la portata di quell’evento e le sue implicazioni sul rapporto tra Stato e terrorismo, sarebbe utile esplorare la storiografia e le analisi politiche che hanno cercato di far luce sui retroscena della trattativa. Si possono consultare gli scritti di storici e giuristi che hanno analizzato quel periodo, come Vladimiro Satta o Guido Neppi Modona, per ottenere una visione più completa e critica.16. La risposta dello Stato e il prezzo delle garanzie
Il sequestro del generale Dozier da parte delle BR nel 1981 segna un cambiamento importante nel modo in cui lo Stato affronta il terrorismo. Dopo la liberazione di Dozier a Padova nel gennaio 1982, i brigatisti catturati furono portati in una struttura di polizia. Qui subirono torture. Le testimonianze descrivono percosse, sevizie sugli organi genitali, bruciature di sigarette e scariche elettriche. Queste testimonianze sono considerate affidabili, dato che furono rilasciate dopo che i prigionieri avevano deciso di collaborare, un momento in cui non avevano motivo di inventare accuse contro lo Stato. Questa pratica crudele richiama metodi usati in passato.La reazione politica e le nuove leggi repressive
Quanto accaduto ai prigionieri divenne un caso politico. Il governo negò l’accaduto o minimizzò, parlando solo di maltrattamenti isolati. Anche la televisione di stato ignorò le accuse di tortura. La violenza del terrorismo spinse lo Stato ad adottare misure sempre più dure. Furono introdotti decreti che istituirono carceri speciali, allungarono il tempo massimo di detenzione prima del processo e diedero più tempo alla polizia prima di informare il magistrato.L’introduzione della legge sui pentiti
Un’altra misura fondamentale fu l’introduzione della legge sui pentiti. Questa legge offriva sconti di pena significativi a chi decideva di collaborare con la giustizia. Inizialmente un fenomeno limitato, la collaborazione si diffuse rapidamente tra i detenuti. I pentiti non si limitavano a confessare i propri reati, ma fornivano delazioni estese, facendo nomi di chiunque li avesse aiutati anche in minima parte. Questa legge fu criticata perché sembrava premiare il tradimento e indebolire i principi fondamentali dello stato di diritto. Si basava sul sentito dire invece che su prove concrete, creando una catena di accuse difficili da verificare e controllare. Parte della magistratura si lasciò influenzare dai risultati rapidi che si potevano ottenere con le dichiarazioni dei pentiti.Le reazioni in carcere e le questioni aperte
La decisione di collaborare ebbe conseguenze gravi all’interno delle carceri. La reazione degli altri detenuti contro i pentiti fu violenta all’interno delle carceri, con aggressioni e omicidi. Nonostante la sconfitta del terrorismo, rimase aperta la questione di come fosse stata amministrata la giustizia e del trattamento riservato ai detenuti, molti dei quali giovani che avevano semplicemente seguito altri e che si ritrovarono a scontare pene molto severe in carceri speciali.Considerando le torture e il sistema dei pentiti basato sul ‘sentito dire’, quanto è affidabile la ‘verità’ processuale emersa in quegli anni?
Il capitolo solleva dubbi significativi sui metodi impiegati dallo Stato per contrastare il terrorismo, dalla tortura alle criticità della legge sui pentiti, basata sul “sentito dire”. La domanda sulla solidità della “verità” processuale è centrale per comprendere l’eredità di quel periodo. Per approfondire, è fondamentale studiare la storia del diritto penale d’emergenza, le testimonianze e le analisi critiche sui processi degli anni di piombo. Approfondire il pensiero di giuristi come Stefano Rodotà o storici come Sergio Luzzatto può offrire prospettive essenziali su questi temi complessi.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]