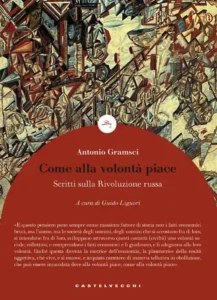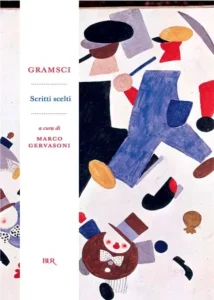Contenuti del libro
Informazioni
“Nel mondo grande e terribile antologia degli scritti 1914-1935” di Antonio Gramsci è una raccolta che ti immerge nel suo pensiero critico, sviluppato in anni pazzeschi, tra guerre mondiali e rivoluzioni. Gramsci analizza a fondo la storia italiana, dalla questione meridionale al Risorgimento, e cerca di capire come il proletariato, unendo operai e contadini, possa cambiare tutto. Al centro c’è l’idea di egemonia: non basta prendere il potere, devi costruire un consenso, una visione del mondo, e in questo la filosofia della praxis, che lega teoria e pratica, è fondamentale. Vedrai le sue riflessioni sul fascismo, sui consigli di fabbrica come base di un nuovo stato, e su fenomeni globali come l’americanismo e il fordismo. È un viaggio nel pensiero di Gramsci, che ti mostra come la lotta politica sia una complessa guerra di posizione, dove le idee contano quanto l’azione.Riassunto Breve
Il pensiero critico nasce dall’analisi dei grandi eventi storici, come le guerre mondiali e la Rivoluzione Russa, che cambiano la società e la politica. Si vede nel proletariato la forza capace di trasformare il mondo, superando le divisioni nazionali e sociali, come quelle tra operai del Nord e contadini del Sud in Italia. La politica non è solo prendere il potere dello Stato, ma costruire un consenso diffuso nella società civile, un’egemonia. Gli intellettuali hanno un ruolo importante in questo, non da soli, ma legati alle classi sociali, aiutando a creare una visione del mondo che rispecchi i loro interessi. La filosofia diventa prassi, cioè unione di teoria e azione, per capire e cambiare la realtà. Si critica chi rende il pensiero rigido e dogmatico, proponendo invece di adattarlo alle situazioni specifiche di ogni paese. Si analizzano anche i nuovi modi di produrre, come l’americanismo e il fordismo, riconoscendo la loro forza ma sottolineando la necessità di superarli con un cambiamento morale e intellettuale che valorizzi il lavoro e la collaborazione tra i popoli. La lotta politica diventa una “guerra di posizione”, una battaglia lunga e complessa per conquistare l’egemonia culturale prima di cambiare la società e lo Stato. Il partito politico è visto come l’organizzatore di questa volontà collettiva, creando nuovi intellettuali e una visione del mondo adatta alle sfide moderne.In Italia, la crisi porta a cercare soluzioni ai problemi storici irrisolti. Il Partito Socialista cerca un ruolo specifico, non solo come parte del proletariato mondiale, ma come una forza che si prepara a diventare Stato. La neutralità iniziale verso la guerra non basta più; serve una “neutralità attiva” che riaccenda la lotta di classe e mostri i limiti della classe dirigente borghese. La guerra peggiora le differenze interne, soprattutto tra Nord e Sud. Il Sud, dopo l’unificazione, subisce un impoverimento a favore del Nord industriale, e le promesse di aiuto restano vuote. Si vede la necessità di politiche che considerino tutto il paese, non solo gli interessi del Nord. Si analizza anche il fallimento del colonialismo europeo, basato sullo sfruttamento e non sullo sviluppo, che porta al risveglio e alle richieste di libertà delle popolazioni colonizzate.In Italia c’è una forte opposizione al socialismo, anche se è l’unica forza che riesce a dare un senso di unità al popolo, superando i localismi. La Rivoluzione Russa rompe con le idee rigide sul marxismo, mostrando che la volontà e le idee possono superare le condizioni economiche previste. I bolscevichi dimostrano che si può fare una rivoluzione anche senza uno sviluppo capitalistico avanzato, mettendo al centro la volontà collettiva. La proposta americana di una Lega delle Nazioni è vista come uno strumento del capitalismo liberale per superare le barriere nazionali e favorire il commercio globale.Marx non ha lasciato regole fisse, ma un metodo per capire la storia attraverso l’analisi dell’economia e dei rapporti tra le classi. La società è divisa in classi, con una che domina e una che è dominata. Per cambiare le cose, la classe dominata, il proletariato, deve diventare consapevole della sua posizione e organizzarsi. In Italia, il potere della Chiesa e la questione religiosa hanno reso difficile l’affermazione di uno Stato liberale. Ma il capitalismo e la guerra hanno indebolito la religione tradizionale e spinto i cattolici a organizzarsi politicamente. La guerra ha anche cambiato i contadini, prima isolati, dando loro una coscienza collettiva e spingendoli all’organizzazione. La rivoluzione proletaria in Italia richiede l’unione di operai e contadini, superando le differenze tra città e campagna, per trasformare la società e l’agricoltura.Le organizzazioni tradizionali dei lavoratori, come i sindacati legati al sistema capitalistico, e lo Stato parlamentare sono in crisi. La soluzione è che i lavoratori creino una loro struttura di potere. I sindacati attuali non sono adatti a guidare una trasformazione radicale perché sono nati per vendere la forza lavoro. L’organizzazione giusta per la dittatura del proletariato è il Consiglio di fabbrica, che rappresenta tutti i lavoratori in base al loro contributo alla produzione. Il Consiglio di fabbrica nasce dal lavoro e dall’industria, unisce la classe lavoratrice e prefigura lo Stato proletario. Lo Stato italiano è visto come una dittatura della classe dominante che reprime le libertà. Il Consiglio di fabbrica, invece, promuove una disciplina volontaria e crea le basi per una nuova società. I sindacati dovrebbero supportare i Consigli e trasformarsi per costruire una nuova economia comunista. L’organizzazione per fabbrica unifica la classe operaia e incarna lo Stato comunista che elimina le classi. I Consigli sono l’inizio di un processo che porta all’Internazionale comunista, intesa come riorganizzazione dell’economia mondiale. Partito e sindacati devono aiutare i Consigli a liberare le forze produttive e passare al comunismo globale.La vera rivoluzione comunista libera le capacità produttive della società capitalista. Non è solo rovesciare il governo o distruggere lo Stato, ma cambiare i rapporti di produzione e distribuzione per superare le classi. Deve far crescere forze capaci di costruire una società dove lo Stato non serve più. Le rivoluzioni che distruggono lo Stato ma non creano un nuovo ordine economico falliscono. Non basta avere partiti o sindacati comunisti; la classe operaia deve volere la trasformazione partendo dalla fabbrica, che diventa il centro del nuovo Stato. Il Partito Comunista deve organizzare queste forze e guidarle verso l’autonomia industriale. La partecipazione alle elezioni è una tattica per connettersi con le classi oppresse e affermare la guida del proletariato. L’esperienza dei Consigli di fabbrica mostra la loro importanza come istituzioni autonome dei lavoratori, germe di un governo proletario. Torino è un esempio di questa dinamica. Il fascismo è visto come l’ultima reazione della piccola borghesia in crisi, che si mette al servizio del capitalismo e dei proprietari terrieri, imitando la classe operaia. Il fascismo, pur violento, non costruisce un nuovo ordine, ma indebolisce lo Stato borghese che dice di difendere. La rivoluzione proletaria si costruisce con l’organizzazione e la trasformazione economica, partendo dal controllo operaio sulla produzione.La crisi del fascismo nasce dalle sue contraddizioni interne. Nato come movimento piccolo-borghese, ottiene l’appoggio di capitalisti e autorità per la sua opposizione al socialismo. Nelle campagne diventa la guardia armata dei proprietari terrieri contro i lavoratori. Questo crea una spaccatura tra i fascisti urbani, più inclini al compromesso, e quelli rurali, violenti e reazionari. La crisi si manifesta quando i fascisti urbani cercano la pace, mentre gli agrari vogliono continuare la violenza. La divisione del fascismo sembra inevitabile, con una parte che cerca una via politica e l’altra che continua la violenza anti-proletaria nelle campagne. Si analizza la storia politica italiana dal 1900 come un tentativo dei governi di integrare le élite operaie nella classe dirigente. La democrazia italiana, senza una forte base di classe, cerca compromessi. Il giolittismo è un esempio, favorendo sindacati e cooperative per creare una base operaia moderata. Il Partito Socialista si divide tra riformisti, che si integrano nel sistema, e comunisti. La scissione di Livorno è vista come necessaria per smascherare i collaborazionisti e preparare la lotta di classe. La fine della democrazia parlamentare è vista come necessaria per la rivoluzione. Si propone un nuovo giornale operaio, “L’Unità”, per raggiungere le masse legalmente con un messaggio di classe, promuovendo la lotta di classe in modo fermo ma non settario, per preparare l’unità del partito comunista. L’idea di una “Repubblica federale degli operai e contadini” è vista come una possibile strategia, importante per la questione meridionale e l’alleanza tra operai e contadini.Il capitalismo in Italia è dominante ma debole, con un’industria limitata e un’agricoltura centrale. Questa debolezza porta i capitalisti a compromessi con i grandi proprietari terrieri, creando un sistema che danneggia i lavoratori e frena lo sviluppo, aumentando le differenze tra Nord e Sud, con il Sud quasi come una colonia interna. Nonostante la debolezza dell’industria, il proletariato è l’unica forza capace di fare una rivoluzione in Italia, anche grazie alla presenza di molti lavoratori agricoli e alle contraddizioni del capitalismo italiano. La borghesia cerca di controllare le masse con compromessi, ma questo crea nuove tensioni e spinge alla rivolta. Il fascismo è una reazione armata per distruggere la classe operaia, appoggiato dalle élite e dalla piccola borghesia. La politica fascista aumenta la disgregazione sociale ed economica, sfruttando lavoratori e Sud. Questo provoca reazioni, soprattutto al Sud, con un allontanamento dallo Stato e una radicalizzazione di contadini e ceti medi. Per fare una rivoluzione socialista, il proletariato deve guidare le masse popolari, alleandosi con i contadini, specialmente quelli del Sud, e superando le resistenze che sostengono il potere agrario. La questione meridionale è centrale per la strategia rivoluzionaria, richiedendo attenzione ai bisogni dei contadini e degli intellettuali del Sud.Il Risorgimento italiano è guidato dai moderati, un gruppo omogeneo delle classi alte con una strategia liberale. La loro egemonia è dominio e direzione intellettuale. Anche il Partito d’Azione, pur diverso, finisce per essere influenzato dai moderati, mancando di una base sociale propria e un programma concreto. La differenza è la capacità di attrarre le masse, soprattutto i contadini. I moderati ci riescono per la loro posizione sociale. Il Partito d’Azione no, restando uno strumento di agitazione. Il confronto con i giacobini francesi mostra i limiti del Partito d’Azione, che non riesce a guidare il processo rivoluzionario unendo città e campagna come fecero i giacobini. Dopo l’unità, emerge la questione meridionale, con il divario tra Nord e Sud non risolto dalle politiche unitarie. Il dibattito sul nazionalismo italiano mostra una tensione tra una tradizione cosmopolita e un nazionalismo di tipo francese, considerato fuori luogo. La vera missione italiana è un cosmopolitismo moderno basato sullo sviluppo del lavoro umano globale.L’americanismo e il fordismo sono visti come una risposta alla necessità di un’economia pianificata, che incontra resistenze. Il proibizionismo negli USA mostra l’opposizione di forze marginali. Si discute se l’americanismo sia una rivoluzione passiva o un accumulo per un cambiamento radicale, e se il cambiamento debba venire dall’interno della produzione o da fuori. Gli alti salari fordisti sono visti come temporanei. L’industria fordista richiede operai qualificati e molto sforzo. L’organizzazione corporativa è una possibile forma per gestire questo cambiamento, ma si dubita che superi la logica di controllo e porti a un vero rinnovamento. La crisi economica sposta il risparmio verso lo Stato, rafforzando il suo ruolo nel capitalismo, ma sorgono dubbi sul controllo della produzione e sulla necessità di riforme contro il parassitismo. L’americanismo in Europa è un’intensificazione della civiltà europea, non una nuova civiltà. Le reazioni in Europa difendono strati sociali minacciati, mentre la vera innovazione viene da chi costruisce le basi materiali del nuovo ordine.Il Principe di Machiavelli è un libro “vivente”, che unisce ideologia e scienza politica in forma di mito. Non è un trattato, ma un’opera artistica dove la dottrina si incarna in un condottiero, simbolo della volontà collettiva. Prefigura il mito sorelliano, un’ideologia che organizza la volontà di un popolo. Il carattere utopistico sta nell’assenza di un principe reale, che è un simbolo. Ma la passione porta all’invocazione di un principe reale, rendendo l’opera un manifesto. Nel mondo moderno, il Principe è il partito politico, la prima forma di volontà collettiva universale. Solo azioni rapide e immediate possono incarnarsi in un individuo, spinte dal pericolo, ma spesso sono restauratrici, non creative. Il mito sorelliano è astratto per la sua opposizione ai giacobini, che furono un esempio concreto del Principe machiavelliano. Il Principe moderno deve capire il giacobinismo e come si forma la volontà collettiva. La volontà politica moderna è la coscienza della necessità storica, protagonista del dramma storico. La classe politica, secondo Mosca, è complessa e sfuggente, e Mosca non analizza bene il partito politico.Il compito educativo dello Stato è creare civiltà superiori, adattando la morale all’economia. Ci si chiede come l’individuo diventa parte dell’uomo collettivo, trasformando la costrizione in consenso. Il diritto si estende alla società civile, che esercita pressioni anche senza leggi formali. La “rivoluzione permanente” è superata dalla “egemonia civile”. La guerra di movimento lascia il posto alla guerra di posizione, in guerra e in politica. Le democrazie moderne sono le “trincee” della guerra di posizione politica, valida per gli Stati avanzati. L’analisi dei rapporti di forza è cruciale, distinguendo movimenti organici e occasionali. Le crisi lunghe indicano problemi strutturali. L’errore è non distinguere cause strutturali e occasionali, cadendo nell’economismo o nell’ideologismo. La distinzione tra guerra di manovra e di posizione si applica alla politica. L’economia può aprire la strada, ma nella politica moderna la società civile complessa resiste. Gli eventi del 1917 richiedono di studiare gli elementi della società civile che corrispondono alle difese nella guerra di posizione. La formazione dei funzionari è fondamentale. Ogni Stato ha i suoi funzionari, e i nuovi dirigenti si confrontano con le tradizioni burocratiche. Il centralismo democratico è un’organizzazione dinamica che adatta la struttura al movimento, unendo spinte dal basso e comando dall’alto. Il centralismo burocratico indica una classe dirigente chiusa che soffoca le forze nuove. Il rapporto nazionale è il punto di partenza per capire l’internazionale. La classe dirigente internazionale deve capire le forze nazionali e guidarle. L’egemonia lega le esigenze nazionali, e una classe internazionale deve “nazionalizzarsi” per guidare gruppi nazionali. La “rivoluzione passiva” è legata alla “guerra di posizione”. Nel Risorgimento, la lotta tra Cavour (rivoluzione passiva, guerra di posizione) e Mazzini (iniziativa popolare, guerra di manovra) mostra la necessità di entrambi. Ma la consapevolezza di Cavour del ruolo di Mazzini, rispetto alla scarsa consapevolezza di Mazzini del ruolo di Cavour, ha portato a un risultato meno favorevole a Mazzini. La rivoluzione passiva avviene con piccoli cambiamenti che modificano le forze. La crisi economica attuale è un processo lungo, iniziato con la guerra, con origini nei rapporti di classe. Ha generato conflitti e interventi statali. Una contraddizione è l’esasperazione del nazionalismo economico contro l’internazionalismo necessario. La crisi è un’intensificazione di problemi esistenti, con la scomparsa di elementi di equilibrio. Il problema è lo squilibrio produttivo. La base aurea è necessaria per il commercio internazionale e le divisioni nazionali. La stabilità monetaria è cruciale, soprattutto a livello internazionale. Le variazioni monetarie sono spesso dovute a scelte politiche e all’opposizione di gruppi sociali, anche internazionali. La storia di un paese è legata alla lotta di gruppi sociali, e la storia mondiale è influenzata dagli Stati dominanti. La caduta dell’Impero Romano si spiega anche con lo sviluppo dei “barbari”, mostrando che le forze decisive possono essere fuori dalle strutture di potere consolidate.Riassunto Lungo
1. Nascita di un Pensiero Critico
Contesto storico e intellettuale di Gramsci
Il percorso intellettuale e politico di Antonio Gramsci si sviluppa in un periodo storico segnato da conflitti mondiali e trasformazioni sociali profonde. La sua riflessione critica matura a partire dall’analisi della guerra e della Rivoluzione Russa, eventi che accelerano la coscienza delle masse e modificano gli equilibri politici internazionali.Centralità del proletariato e questione italiana
Gramsci individua nel proletariato la forza motrice di un cambiamento radicale, capace di superare le divisioni nazionali e di costruire un nuovo ordine mondiale. La sua attenzione si concentra sull’Italia e sulla necessità di unire operai del Nord e contadini del Sud per superare le debolezze strutturali del paese, ereditate dal Risorgimento.Il concetto di egemonia
Il concetto di egemonia emerge come chiave interpretativa della politica. Non è sufficiente la conquista del potere statale; è necessario costruire un consenso attivo nella società civile. Gli intellettuali assumono un ruolo centrale in questo processo, non come gruppo autonomo, ma organico alle classi sociali, capaci di elaborare e diffondere una visione del mondo coerente con i loro interessi.Filosofia della praxis e critica al marxismo sovietico
La filosofia della praxis, intesa come unità di teoria e pratica, si pone come strumento per comprendere e trasformare la realtà. Gramsci critica il marxismo sovietico per la sua rigidità dogmatica e per la mancanza di autonomia filosofica, proponendo una rielaborazione del pensiero marxista che tenga conto delle specificità nazionali e delle complesse dinamiche tra economia e politica.Americanismo e fordismo
L’analisi si estende all’americanismo e al fordismo, fenomeni che rappresentano una nuova fase dello sviluppo capitalistico, caratterizzata dall’organizzazione scientifica del lavoro e dalla produzione di massa. Gramsci riconosce la forza dirompente di questo modello, ma sottolinea la necessità di superarne i limiti attraverso una riforma intellettuale e morale che promuova un nuovo cosmopolitismo, basato sulla collaborazione tra i popoli e sul primato del lavoro.Guerra di posizione e ruolo del partito
La lotta politica si configura quindi come una guerra di posizione, in cui la conquista dell’egemonia culturale precede e rende possibile la trasformazione sociale e politica. Il partito politico diviene l’organizzatore di questa volontà collettiva, elaborando una nuova intellettualità e una visione del mondo capace di rispondere alle sfide del secolo.Se Gramsci individuava nel proletariato la forza motrice del cambiamento radicale, come si concilia questa visione con le trasformazioni socio-economiche post-industriali, dove la classe operaia tradizionale sembra perdere centralità a favore di altre figure professionali e nuove forme di precariato?
Il capitolo presenta la centralità del proletariato come motore del cambiamento in modo assertivo, senza considerare le possibili evoluzioni del capitalismo e del lavoro. Per rispondere a questa domanda, è utile approfondire la sociologia del lavoro contemporaneo e le teorie sulla post-industrializzazione. Autori come Ulrich Beck e Zygmunt Bauman potrebbero offrire spunti interessanti per comprendere le trasformazioni del lavoro e della società contemporanea.2. Italia al tempo di guerra: neutralità, Mezzogiorno e colonie
La posizione del Partito Socialista Italiano
In un periodo di crisi in Europa, tutti sono d’accordo sulla gravità della situazione e sulla necessità di risolvere i problemi del passato.Il Partito Socialista Italiano (PSI) riflette sul suo ruolo in Italia, distinguendosi dagli altri lavoratori. Il PSI si vede come uno Stato che sta nascendo, indipendente nelle sue azioni ma legato alle organizzazioni internazionali per la lotta dei lavoratori.
La neutralità iniziale, utile per opporsi alla guerra, non basta più. Il PSI propone una “neutralità attiva e operante”. Questa neutralità deve rilanciare la lotta tra lavoratori e proprietari, mostrare l’incapacità della classe dirigente borghese e preparare i lavoratori a prendere il loro posto.
Le difficoltà del Mezzogiorno durante la guerra
La guerra peggiora le differenze che già esistono in Italia. Il Mezzogiorno, la parte sud dell’Italia, soffre a causa delle scelte fatte dopo l’unificazione e delle politiche di guerra.L’unificazione, invece di unire, ha aumentato le differenze tra Nord e Sud. I soldi del Sud sono stati usati per sviluppare le industrie del Nord, grazie anche a leggi che proteggevano le industrie del Nord e ai prestiti per la guerra.
Le promesse di aiutare il Sud non sono state mantenute. È necessario creare politiche che vadano bene per tutto il paese, evitando che il Sud paghi le conseguenze di una guerra che avvantaggia soprattutto il Nord.
Il fallimento del colonialismo europeo
Nello stesso periodo, si discute anche del fallimento del colonialismo europeo. Le nazioni europee che avevano colonie, come Francia e Inghilterra, hanno cercato di dominare e sfruttare le colonie.Hanno trascurato l’istruzione e lo sviluppo delle persone che vivevano in quei territori. Questo modo di agire è contrario ai principi democratici che questi paesi dicevano di seguire in Europa.
Questa situazione ha creato insoddisfazione e desiderio di libertà tra le persone delle colonie. Sta nascendo un movimento mondiale nelle colonie che chiede parità di diritti e indipendenza.
Se l’Europa non riesce a portare un vero progresso nelle colonie, sarebbe meglio rinunciare a dominarle, per evitare il rischio di future guerre nelle colonie.
Se la “neutralità attiva e operante” del PSI mira a “preparare i lavoratori a prendere il loro posto”, non si configura forse come una forma di belligeranza ideologica, mascherata da pacifismo?
Il capitolo presenta la “neutralità attiva e operante” come una strategia del PSI per affrontare la crisi. Tuttavia, l’idea di una neutralità che si propone di “rilanciare la lotta tra lavoratori e proprietari” e “preparare i lavoratori a prendere il loro posto” solleva interrogativi sulla sua effettiva natura neutrale. Per analizzare criticamente questa posizione, è utile approfondire le teorie politiche sulla neutralità e i movimenti socialisti dell’epoca. Autori come Carl Schmitt e Hans Kelsen, pur con prospettive diverse, hanno offerto importanti riflessioni sul concetto di neutralità e sulla sua applicazione in contesti politici complessi.3. L’Alba delle Nuove Ideologie
L’Opposizione al Socialismo in Italia
In Italia, molte forze politiche si oppongono con decisione al socialismo. Lo considerano un nemico da combattere. Questa forte ostilità nasce proprio mentre il socialismo si afferma come l’unico movimento capace di unire il popolo italiano. Il socialismo riesce a superare le divisioni regionali e sociali che hanno caratterizzato la storia del paese. In passato, l’Italia era frammentata e divisa in molte realtà locali. Il socialismo ha dato agli italiani la consapevolezza di essere un popolo unito. Persone provenienti da regioni diverse hanno iniziato a condividere una lingua, idee e sogni comuni. Si sentivano finalmente parte di un’unica comunità politica e sociale.La Rivoluzione Bolscevica e la Rottura con il Marxismo Ortodosso
La rivoluzione bolscevica in Russia rappresenta un cambiamento radicale rispetto alle interpretazioni tradizionali del marxismo. Dimostra che la storia non segue percorsi stabiliti rigidamente. La volontà degli uomini e le ideologie possono superare le forze economiche. Contrariamente a quanto previsto da Marx, la rivoluzione in Russia si afferma senza che il capitalismo si sia pienamente sviluppato. I bolscevichi, pur ispirandosi al pensiero di Marx, rifiutano l’idea che il materialismo storico sia una dottrina fissa e immutabile. Essi mettono in primo piano la forza della collettività e la capacità degli uomini di trasformare la società e l’economia in base ai propri obiettivi.La Lega delle Nazioni e gli Interessi del Capitalismo Liberale
Parallelamente, il presidente americano Wilson propone di creare una Lega delle Nazioni. Questa organizzazione sembra rispondere agli interessi del capitalismo liberale dei paesi anglosassoni. Non si tratta solo di un ideale nobile e irrealizzabile. La Lega delle Nazioni nasce da precise necessità economiche. L’obiettivo è superare i protezionismi dei singoli stati e creare un sistema di scambi internazionali più libero e sicuro. La Lega delle Nazioni rappresenta un tentativo di adattare le relazioni internazionali alle nuove dinamiche dell’economia mondiale. Si vuole promuovere un sistema globale in cui le potenze capitalistiche possano espandere i propri interessi economici senza ostacoli, lasciando da parte le logiche di guerra e nazionalismo del passato.Se l’opposizione all’americanismo e al fordismo viene presentata come resistenza a uno “sviluppo necessario”, il capitolo non rischia di liquidare come irrazionali o superate tutte le critiche a questi modelli economici, ignorando le complesse dinamiche sociali e umane che tali trasformazioni hanno innescato?
Il capitolo sembra suggerire che l’americanismo e il fordismo fossero risposte inevitabili e necessarie a esigenze economiche, minimizzando le ragioni dell’opposizione a questi sistemi. Per comprendere appieno le critiche mosse all’epoca e ancora oggi rilevanti, sarebbe utile approfondire le analisi sociologiche e politiche sulle conseguenze del fordismo, considerando autori come Antonio Gramsci, che ha studiato il fordismo nel contesto italiano, o esplorare le critiche al taylorismo e alla razionalizzazione del lavoro provenienti dalla sociologia del lavoro.11. L’Arte della Guerra Politica Moderna
Il Principe di Machiavelli: un’opera “vivente”
Il valore principale de “Il Principe” di Machiavelli sta nella sua natura di opera sempre attuale e capace di influenzare il pensiero, più che nell’essere un’analisi politica sistematica. Questo libro unisce ideologia e scienza politica attraverso uno stile narrativo intenso e coinvolgente, quasi mitologico. Machiavelli si allontana dalle teorie politiche ideali e dagli schemi accademici, preferendo una forma espressiva artistica. In questa forma, le sue teorie politiche prendono vita in un capo, che diventa simbolo della volontà di un popolo. Le qualità e i compiti di questo capo sono descritti in modo concreto e appassionato, stimolando l’immaginazione e l’interesse politico del lettore.Il mito sorelliano e la figura del Principe
“Il Principe” anticipa il concetto di “mito” sviluppato da Sorel. Questo mito è un’ideologia politica che non si basa su principi utopistici o su ragionamenti puramente teorici, ma su una creazione immaginaria. Questa creazione ha la forza di unire e guidare la volontà di un popolo che non ha una direzione comune. L’aspetto utopistico dell’opera di Machiavelli sta nel fatto che il principe descritto non è una persona reale, ma un modello ideale di leader, un simbolo astratto. Nonostante ciò, l’opera culmina in un appello appassionato per l’arrivo di un principe vero, trasformando il libro in una sorta di manifesto politico.Il Partito Politico come Principe Moderno
Nella realtà contemporanea, il ruolo del Principe non può essere ricoperto da un singolo individuo, ma da un’organizzazione complessa: il partito politico. Il partito è il primo nucleo in cui una volontà collettiva ampia e condivisa inizia a prendere forma concretamente. Solo in situazioni di emergenza, quando è necessario agire rapidamente e con decisione nella storia e nella politica, un singolo individuo può assumere un ruolo di guida. Questo accade soprattutto quando un pericolo immediato riduce la capacità di pensiero critico. Tuttavia, queste azioni individuali sono raramente innovative e costruttive; spesso si limitano a ripristinare un ordine precedente piuttosto che a creare nuove forme di governo.La critica di Sorel e il ruolo del Giacobinismo
La visione di Sorel sul mito politico sembra troppo astratta perché critica i giacobini. I giacobini, invece, hanno rappresentato una realizzazione concreta del modello di Principe descritto da Machiavelli. Il Principe moderno, quindi, deve considerare attentamente l’esperienza del giacobinismo. È fondamentale capire come nasce e come opera una volontà collettiva all’interno di un contesto politico. La volontà politica oggi è la consapevolezza attiva della necessità storica, ed è protagonista delle vicende storiche reali.La classe politica secondo Gaetano Mosca
Il concetto di classe politica, come presentato da Gaetano Mosca, appare complicato e difficile da definire con precisione. Mosca non analizza in modo approfondito il ruolo del partito politico, muovendosi tra un’analisi che vuole essere oggettiva e il suo diretto coinvolgimento nella politica. Senza rendersene conto pienamente, Mosca riprende alcune idee del materialismo storico, ma le tratta in modo superficiale e limitato.Il ruolo educativo dello Stato e il consenso
Lo Stato ha il compito di educare i cittadini a raggiungere un livello di civiltà più elevato, adattando i principi morali della popolazione allo sviluppo economico. In questo contesto, è importante capire come il singolo cittadino diventa parte di una collettività, trasformando l’imposizione in accordo e partecipazione attiva. L’idea di diritto deve essere estesa a tutta la società civile, che esercita pressioni collettive anche al di fuori delle leggi formali.Dalla “guerra di movimento” alla “guerra di posizione”
L’idea di “rivoluzione permanente”, nata prima del 1848, viene superata successivamente dal concetto di “egemonia civile”. La strategia della “guerra di movimento”, caratterizzata da azioni rapide e dirette, cede il passo alla “guerra di posizione”, una strategia più lenta e indiretta. Questo cambiamento si verifica sia in ambito militare che politico. Le democrazie moderne, con le loro istituzioni statali e civili complesse, rappresentano le “trincee” della guerra di posizione politica. Questa strategia è adatta ai paesi sviluppati, ma non a quelli più arretrati o alle colonie.Analisi dei rapporti di forza e crisi
L’analisi dei rapporti di forza tra le diverse componenti politiche e sociali è fondamentale. È necessario distinguere tra cambiamenti profondi e duraturi (organici) e cambiamenti temporanei e superficiali (di congiuntura). Le crisi che si protraggono nel tempo indicano la presenza di problemi strutturali radicati, con forze politiche che cercano di risolvere la situazione. Un errore tipico nell’analisi storica e politica è quello di non saper distinguere tra cause strutturali e cause occasionali, cadendo in interpretazioni eccessivamente economiche (economismo) o ideologiche (ideologismo).Guerra di posizione nell’arte politica
La distinzione tra guerra di movimento e guerra di posizione si applica anche all’arte politica, cioè alla capacità di guidare e gestire la politica. L’aspetto economico immediato può essere paragonato all’artiglieria che apre un varco nel fronte nemico. Tuttavia, nella politica moderna, la società civile è complessa e resistente, rendendo meno efficaci le azioni dirompenti basate solo sulla forza economica. Le strutture della società civile agiscono come trincee, rallentando e modificando la rapidità tipica della guerra di movimento. Gli eventi del 1917, come la Rivoluzione Russa, rappresentano un punto di svolta. Dopo questi eventi, è necessario studiare a fondo gli elementi della società civile che corrispondono ai sistemi difensivi nella guerra di posizione.La formazione del funzionario di carriera
La formazione di funzionari pubblici competenti e stabili è un aspetto fondamentale nella scienza politica. Ogni forma di Stato ha un proprio sistema di funzionari. I nuovi gruppi dirigenti devono spesso confrontarsi con le tradizioni burocratiche esistenti. Il centralismo democratico, diverso dal centralismo burocratico, rappresenta un modello organizzativo dinamico. Questo modello adatta la struttura del potere ai cambiamenti reali, bilanciando le richieste che vengono dalla base con le decisioni prese dai vertici. Il centralismo burocratico, al contrario, indica una chiusura della classe dirigente, che difende i propri privilegi e impedisce il rinnovamento.Rapporti nazionali e dimensione internazionale
Il contesto nazionale è il punto di partenza per capire e influenzare la situazione internazionale. La classe dirigente internazionale deve essere capace di interpretare le diverse forze nazionali, indirizzandole verso obiettivi comuni a livello globale. Il concetto di egemonia, cioè di leadership culturale e politica, lega le necessità nazionali a una visione più ampia. Una classe dirigente che vuole operare a livello internazionale deve “nazionalizzarsi”, cioè radicarsi nelle realtà nazionali, per guidare efficacemente gruppi sociali specifici e con interessi particolari.Il concetto di “rivoluzione passiva”
Il concetto di “rivoluzione passiva” è legato all’idea di “guerra di posizione”. Nel Risorgimento italiano, il confronto tra Cavour (che rappresentava una “rivoluzione passiva” e una “guerra di posizione”) e Mazzini (sostenitore dell’iniziativa popolare e della “guerra di movimento”) mostra la necessità di entrambi gli approcci. Tuttavia, Cavour era consapevole dell’importanza di Mazzini, mentre Mazzini non riconosceva pienamente il ruolo di Cavour. Questo ha portato a un risultato storico in cui l’influenza di Mazzini è stata minore di quella di Cavour. La rivoluzione passiva si realizza attraverso cambiamenti graduali e impercettibili che modificano lentamente gli equilibri di potere.La crisi economica come processo complesso
L’attuale crisi economica è un fenomeno complesso e di lunga durata, non un evento improvviso. È iniziata almeno con la Prima Guerra Mondiale e ha cause profonde nei rapporti tra le classi sociali. Le prime manifestazioni della crisi hanno generato conflitti e interventi legislativi. Una contraddizione fondamentale è l’accentuarsi del nazionalismo economico, che si scontra con la necessità di una cooperazione internazionale per l’economia. La crisi non fa altro che intensificare tendenze già esistenti, portando alla scomparsa di elementi di equilibrio. Il problema principale è lo squilibrio nella produzione, soprattutto tra settori industriali in crescita e settori stagnanti.La base aurea della moneta e la stabilità internazionale
La base aurea della moneta, cioè il sistema monetario basato sulla convertibilità in oro, è indispensabile per il commercio tra le nazioni e per mantenere separate le economie nazionali. La stabilità del valore della moneta è cruciale, soprattutto a livello internazionale. Le variazioni nel valore della moneta, come l’inflazione o la deflazione, sono spesso il risultato di scelte politiche e di conflitti tra gruppi sociali, anche a livello internazionale. La storia di un paese non può essere separata dalle lotte tra gruppi sociali, e la storia del mondo è influenzata dalle nazioni più potenti. La caduta dell’Impero Romano, ad esempio, si spiega non solo con problemi interni, ma anche con la crescita di nuove popolazioni esterne (“barbariche”). Questo dimostra come le forze decisive nella storia mondiale possono nascere anche al di fuori delle strutture di potere consolidate.È sufficiente ridurre la complessità della politica moderna alla dicotomia “guerra di movimento” e “guerra di posizione”?
Il capitolo presenta una sintesi stimolante, ma rischia di semplificare eccessivamente la realtà politica contemporanea attraverso la lente concettuale della “guerra di posizione”. Se da un lato tale metafora può offrire spunti interpretativi interessanti, dall’altro potrebbe oscurare la varietà e la fluidità delle dinamiche politiche attuali. Per comprendere appieno le sfide della politica moderna, sarebbe utile approfondire le teorie della complessità e i modelli di analisi sistemica, che offrono strumenti più sofisticati per navigare la complessità dei fenomeni sociali e politici.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]