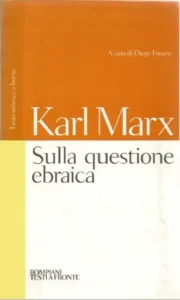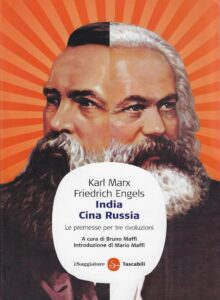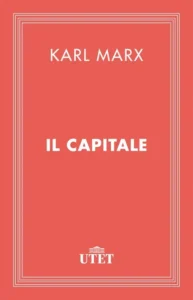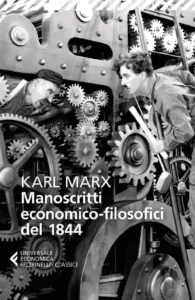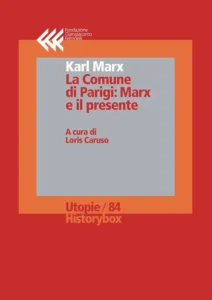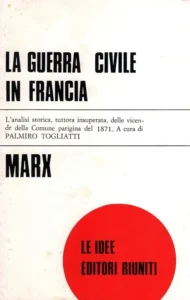1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Miseria della filosofia” di Karl Marx è una risposta diretta e super critica al libro di Pierre-Joseph Proudhon, dove Marx smonta pezzo per pezzo le sue idee economiche. Non è un romanzo, non ci sono luoghi o personaggi nel senso classico, ma è un dibattito intellettuale acceso che si svolge nel contesto delle teorie economiche e socialiste dell’Europa ottocentesca. Marx prende di mira concetti come il “valore costituito” di Proudhon e la sua idea di “scambio equo” basato sul tempo di lavoro, mostrando come non capiscano la vera natura del valore e dello scambio nella società capitalista. Invece di vedere le categorie economiche come idee astratte, Marx spiega che sono il risultato dei rapporti sociali di produzione, che cambiano con la storia. Il libro mette in luce come la teoria del valore-lavoro, già presente in economisti come Ricardo, nella pratica porti allo sfruttamento del proletariato da parte della borghesia, non all’eguaglianza. La critica si estende anche al metodo di Proudhon, accusato di usare una dialettica confusa e idealista, ignorando il materialismo storico. Temi centrali sono la lotta di classe, l’analisi di categorie come concorrenza, monopolio, rendita fondiaria, e l’importanza degli scioperi operai come forma di organizzazione e lotta del proletariato contro il capitale. È un testo fondamentale per capire il pensiero di Marx e la sua visione della storia e della società, vista attraverso il prisma degli antagonismi di classe.Riassunto Breve
Il valore dei prodotti ha due aspetti: l’utilità per soddisfare bisogni e la capacità di essere scambiati. Si cerca di capire come il valore d’uso diventi valore di scambio. L’idea che il valore di un prodotto sia dato dal tempo di lavoro necessario per produrlo non è nuova, altri economisti lo avevano già notato. Però, nel sistema attuale, questa legge significa che anche il lavoro è una merce e il suo valore è fissato al minimo necessario per mantenere il lavoratore. Questo porta a sfruttamento, non a uguaglianza. Si confonde il valore di una merce, legato al tempo di lavoro, con il salario del lavoratore. La concorrenza non permette scambi basati sul tempo impiegato dal singolo, ma impone il tempo minimo necessario, causando problemi come la sovrapproduzione. L’idea di scambiare quantità uguali di lavoro per raggiungere l’uguaglianza non è originale e presenta difficoltà pratiche; sarebbe possibile solo se il tempo di lavoro fosse deciso collettivamente prima, eliminando lo scambio individuale. Lo scambio individuale è legato alla divisione della società in classi. Il denaro, come oro e argento, diventa moneta non perché il suo valore è “costituito” dal tempo di lavoro, ma perché è un rapporto sociale, un mezzo di scambio universale necessario all’organizzazione produttiva attuale. Il valore del denaro in circolazione dipende dalla quantità emessa rispetto ai bisogni, non dal costo di produzione. Il fatto che il lavoro collettivo produca più del lavoro isolato, creando un surplus, non è un mistero ma deriva dalla divisione del lavoro e dall’uso delle macchine. Questo surplus, nelle condizioni attuali basate sull’accumulazione privata e l’antagonismo tra classi, permette ad alcuni di arricchirsi a scapito di altri. Le categorie economiche non sono idee astratte che si sviluppano da sole, ma sono espressioni dei rapporti sociali di produzione, che cambiano con lo sviluppo delle forze produttive. Un metodo che cerca solo il lato buono e cattivo delle categorie economiche e propone “antidoti” non coglie il vero movimento storico. La storia non è guidata da un “genio sociale” che cerca l’uguaglianza, ma da trasformazioni materiali e rapporti sociali concreti. La divisione del lavoro e le macchine sono forze produttive che hanno forme diverse a seconda delle epoche e concentrano il capitale, peggiorando la condizione del lavoratore. La fabbrica moderna è un rapporto sociale nato da condizioni storiche specifiche. La concorrenza non è un principio eterno ma un rapporto sociale che si trasforma, legato allo sviluppo delle forze produttive. Monopolio e concorrenza non sono semplici opposti ma si generano a vicenda e coesistono. La proprietà fondiaria e la rendita derivano da rapporti sociali specifici, non da un’origine mistica. La rendita borghese è l’eccedenza del prezzo agricolo sui costi, legata alla fertilità dei terreni e alla concorrenza. Gli scioperi e le coalizioni operaie sono risposte alla concorrenza tra lavoratori e alla lotta contro il capitale; spingono all’innovazione e sono fondamentali per l’organizzazione dei lavoratori come classe, trasformando la lotta economica in lotta politica. La lotta di classe tra proletariato e borghesia è un antagonismo fondamentale che porta a una rivoluzione totale, mirando all’abolizione di tutte le classi e alla fine del potere politico basato su tale antagonismo.Riassunto Lungo
1. L’Illusione del Valore Costituito
I prodotti hanno due tipi di valore: uno basato su quanto sono utili per soddisfare i bisogni delle persone (valore d’uso) e un altro basato sulla loro capacità di essere scambiati con altri prodotti (valore di scambio). Proudhon ha studiato come il valore d’uso si trasformi in valore di scambio. Ha proposto l’idea del “valore costituito” o “valore sintetico”, sostenendo che il valore di un prodotto è stabilito dal tempo di lavoro necessario per crearlo. Ha presentato questa idea come una sua scoperta originale.L’idea non è nuova
Tuttavia, questa concezione non era nuova. Economisti precedenti, come Ricardo, avevano già dimostrato che il valore di scambio delle merci che possono essere riprodotte è regolato dalla quantità di lavoro impiegato nella loro produzione. Ricardo aveva già spiegato come questa legge economica funzionasse all’interno della società esistente. Pertanto, l’idea che il tempo di lavoro sia alla base del valore di scambio era già un concetto noto e studiato nell’economia prima che Proudhon ne scrivesse.Le conseguenze nel sistema attuale
L’applicazione della teoria del valore basata sul tempo di lavoro nel sistema economico attuale ha conseguenze molto diverse da quelle che Proudhon sembrava immaginare. In questo sistema, il lavoro stesso è considerato una merce. Il suo valore è determinato dal tempo di lavoro necessario per mantenere il lavoratore in grado di lavorare, fissando di fatto il salario al livello minimo indispensabile per la sua sopravvivenza. Questo meccanismo non porta all’uguaglianza, come forse Proudhon sperava, ma costituisce la base della condizione di dipendenza economica del lavoratore, simile a una forma di schiavitù moderna.Confusione sul valore del lavoro
Proudhon ha commesso un errore fondamentale confondendo il valore di una merce, che è determinato dal tempo di lavoro necessario per produrla, con il valore del lavoro stesso, che si manifesta nel salario pagato al lavoratore. Egli sembrava credere che la quantità di lavoro contenuta in un prodotto dovesse corrispondere direttamente alla retribuzione del lavoratore. Questa visione presuppone un’uguaglianza tra lavoro e salario che nella realtà economica non esiste. Questa confusione ha portato a una comprensione distorta delle dinamiche di valore e retribuzione.La realtà della concorrenza
La concorrenza nel mercato impedisce che gli scambi si basino semplicemente sul tempo impiegato dal singolo produttore per realizzare un bene. La competizione impone che il valore sia determinato dal tempo minimo di lavoro socialmente necessario per produrre quel bene in condizioni medie. Questo porta a un continuo abbassamento del valore del lavoro e genera instabilità economica. Si verificano fenomeni di disordine industriale, come la sovrapproduzione, perché l’ideale di una “proporzionalità” perfetta basata sul tempo di lavoro non trova riscontro nella pratica del mercato competitivo.Precursori delle idee di scambio equo
L’idea di applicare la teoria del valore basata sul tempo di lavoro in modo da garantire l’uguaglianza, immaginando che le persone dovrebbero scambiare prodotti che incorporano quantità uguali di lavoro, non è un’idea originale di Proudhon. Socialisti inglesi precedenti, come Bray, avevano già analizzato le cause dell’ineguaglianza. Essi sostenevano che la disuguaglianza derivasse dallo scambio ineguale tra capitalisti e operai, dove il lavoratore cede al capitalista un valore maggiore di quello che riceve in cambio tramite il salario. Questi pensatori vedevano nella realizzazione di scambi equi, basati sull’equivalenza del lavoro contenuto nei prodotti, la soluzione per superare l’ingiustizia sociale.Il capitolo, nel liquidare l’idea di Proudhon come non originale e confusa, non rischia forse di ignorare le specifiche finalità sociali e politiche che egli attribuiva al suo concetto di “valore costituito”, distinte dalla mera analisi economica dei suoi predecessori?
Il capitolo critica Proudhon per non aver colto le dinamiche del mercato competitivo e per aver confuso il valore delle merci con il valore del lavoro. Tuttavia, la critica si concentra prevalentemente sull’aspetto puramente economico della teoria del valore-lavoro all’interno di un sistema capitalistico. Per comprendere appieno la portata (e le eventuali lacune) del pensiero di Proudhon, sarebbe necessario contestualizzare la sua idea di “valore costituito” non solo nel dibattito economico sul valore, ma anche nel suo più ampio progetto di riforma sociale e mutualistica. Approfondire la storia del pensiero socialista e anarchico, e in particolare gli scritti di Proudhon stesso, permetterebbe di valutare se la sua proposta fosse un semplice errore analitico o un tentativo, forse imperfetto, di definire i principi di un’economia non capitalistica basata sull’equità dello scambio e sulla giustizia sociale, al di là della “realtà della concorrenza” che intendeva superare.2. Lo scambio equo e le sue contraddizioni
L’ineguaglianza negli scambi è la causa principale della disuguaglianza nella ricchezza tra le persone. Per superare questo problema, è necessario un sistema sociale dove gli scambi siano uguali. Questo significa scambiare cose che hanno lo stesso valore, un valore determinato da quanto costa produrle. Un sistema così porterebbe la ricchezza verso i lavoratori e richiederebbe che tutti lavorassero. Un primo passo verso un sistema comunitario potrebbe essere una forma semplice di cooperazione, con camere di commercio che gestiscono la produzione e la distribuzione. In questa fase di transizione, le persone manterrebbero la proprietà dei prodotti che realizzano, ma non dei mezzi usati per produrli.I limiti dello scambio basato sul tempo di lavoro
L’idea di scambiare quantità uguali di lavoro, per esempio un’ora di lavoro per un’ora di lavoro, presenta dei problemi. Se una persona lavora più ore di un’altra, si ritrova con un eccesso di lavoro che non può scambiare in modo equo. Questo può portare a essere costretti a non lavorare o a una sorta di “competizione a chi lavora meno”. Per fare in modo che lo scambio basato sul tempo di lavoro sia davvero uguale, il tempo di lavoro necessario per produrre qualcosa deve essere deciso da tutti insieme in anticipo. Questo, di fatto, elimina lo scambio individuale. La forma in cui i prodotti vengono scambiati dipende da come avviene la produzione. Lo scambio individuale è legato all’esistenza di contrasti tra le classi sociali. Pensare a uno scambio individuale che sia “uguale” ma senza classi sociali è un’illusione che non corrisponde alla realtà della società.La vera natura del denaro
Riguardo al denaro, c’è chi dice che l’oro e l’argento sono diventati moneta perché il loro valore è stato “creato” dal tempo di lavoro. Questa idea non considera che il denaro è un rapporto sociale. È un mezzo universale per scambiare le cose, indispensabile per come è organizzata la produzione oggi. L’oro e l’argento sono stati scelti come moneta per le loro caratteristiche fisiche e per la funzione che possono svolgere, non per un motivo economico legato a quanto lavoro serve per ottenerli. Il valore del denaro che circola è determinato da quanto ne viene emesso rispetto a quanto serve per gli scambi (offerta e domanda), non da quanto costa produrlo.Da dove arriva il surplus del lavoro
Il principio secondo cui ogni lavoro deve produrre un surplus, cioè più di quanto serve per vivere, non è una verità misteriosa legata a un’idea astratta di “società-persona”. Deriva dalla maggiore capacità di produrre che hanno le persone quando lavorano insieme, dividono i compiti e usano macchine, rispetto a quando una persona lavora da sola. Questo aumento della produzione e il surplus di lavoro che ne deriva si verificano nelle condizioni storiche attuali. Queste condizioni si basano sull’accumulo di ricchezza privata e sul conflitto tra le classi sociali. Sono queste condizioni che permettono ad alcune classi di arricchirsi, mentre altre restano povere o peggiorano la loro situazione, anche se la ricchezza totale della società aumenta.Se il surplus deriva dalla maggiore capacità produttiva del lavoro collettivo, come si garantisce che nella società proposta non venga semplicemente appropriato da una nuova élite o da un apparato burocratico?
Il capitolo analizza correttamente come l’aumento della produttività derivi dalla cooperazione e dall’uso di macchine, generando un surplus di lavoro. Tuttavia, nel proporre un sistema alternativo, non chiarisce in che modo questo surplus verrebbe gestito o distribuito per evitare la formazione di nuove disuguaglianze o forme di controllo. La critica all’appropriazione del surplus nelle condizioni attuali è chiara, ma la soluzione proposta per la sua gestione collettiva resta vaga. Per approfondire questo nodo cruciale, è utile studiare le diverse teorie sulla distribuzione della ricchezza e del surplus sociale, esplorando autori che hanno affrontato la questione della gestione collettiva dei mezzi di produzione e dei suoi esiti, come Karl Marx o i teorici delle varie forme di socialismo e anarco-sindacalismo.3. Dialettica Capovolta e Storia Dimenticata
Proudhon guarda all’economia come se fosse un insieme di idee astratte che si sviluppano in modo logico, un po’ come faceva Hegel con la sua dialettica. Lui non si limita a descrivere come funzionano le cose nell’economia di oggi, ma cerca di capire come queste idee economiche nascono e cambiano seguendo un percorso di pensiero puro. Però, questo modo di vedere le cose non considera che le idee sull’economia sono in realtà il riflesso di come le persone si organizzano nella società per produrre, e questi modi di organizzarsi cambiano man mano che la società si sviluppa.Il Metodo di Proudhon
Il suo metodo funziona così: per ogni concetto economico, Proudhon trova un aspetto positivo e uno negativo. Poi, cerca di eliminare l’aspetto negativo, spesso proponendo un altro concetto come soluzione. Questo modo di procedere non è la vera dialettica di Hegel, dove le contraddizioni interne a un’idea portano naturalmente alla nascita di un’idea nuova e più completa. La sua logica si riduce a distinguere tra ciò che è buono e ciò che è cattivo, cercando dei “rimedi”. Questo crea una serie di idee che non seguono né la vera storia di come le cose sono cambiate, né un reale sviluppo logico.La Sua Idea di Sviluppo Storico
Proudhon crede che lo sviluppo della storia sia guidato da una sorta di “intelligenza collettiva” o “ragione umana” che cerca di raggiungere l’uguaglianza. Vede i concetti economici come tentativi, spesso pieni di contraddizioni, per arrivare a questo obiettivo. Questa visione è un po’ come credere nel destino o in una forza superiore, e mette al posto dell’analisi concreta di come la società si muove e cambia, l’ideale personale di Proudhon. Lo sviluppo storico vero, invece, dipende dalle trasformazioni concrete e dai rapporti che le persone creano tra loro nella società.Esempi: Divisione del Lavoro e Macchine
Quando Proudhon analizza la divisione del lavoro e le macchine, si vede bene dove il suo metodo non funziona. Le tratta come concetti astratti con lati positivi e negativi. Ma nella realtà, la divisione del lavoro cambia forma a seconda dei momenti storici e delle condizioni pratiche, come quanto è grande il mercato o quali strumenti ci sono. Le macchine, che sono una grande forza produttiva, non sono l’opposto della divisione del lavoro; anzi, nella società hanno contribuito ad aumentarla e a rendere i lavori in fabbrica più semplici, concentrando però il potere (il capitale) e peggiorando la condizione del lavoratore. La fabbrica come la conosciamo oggi è nata da specifici momenti storici e da un certo tipo di rapporti sociali, non da un’idea astratta o da accordi amichevoli tra le persone.Una Posizione Intermedia
Mentre gli economisti vedono l’attuale sistema economico come qualcosa di naturale e che durerà per sempre, e i socialisti studiano i conflitti e le lotte tra le classi sociali, Proudhon si trova in una posizione intermedia. Non riesce a capire a fondo né l’analisi economica né come la storia si muove attraverso i cambiamenti sociali. Rimane legato a un modo di pensare tipico di chi ha una piccola attività o proprietà, cercando soluzioni in formule teoriche invece di guardare alla realtà concreta della società che cambia continuamente.[/membership]Se le idee economiche sono solo un riflesso della realtà materiale, come nascono le nuove idee che poi contribuiscono a trasformare quella stessa realtà?
Il capitolo presenta una visione in cui le idee economiche sono principalmente un riflesso delle condizioni materiali e sociali. Tuttavia, la storia mostra come le idee non siano solo passive, ma possano anche influenzare e guidare le trasformazioni sociali ed economiche. Per approfondire questo complesso rapporto tra pensiero e realtà materiale, è utile studiare la filosofia della storia e la sociologia della conoscenza. Un confronto tra le visioni di autori come Hegel e Marx può offrire diverse prospettive su come la dialettica tra idee e condizioni materiali plasmi lo sviluppo storico.4. Le Categorie Economiche e la Lotta di Classe
La concorrenza si manifesta in diversi modi, distinguendo l’emulazione commerciale da quella industriale. A volte, la ricerca di profitto può portare a fasi speculative che non si basano sulla produzione reale. È importante capire che la concorrenza non è una caratteristica fissa della natura umana o un principio immutabile nel tempo. Si tratta invece di un rapporto sociale che cambia continuamente, influenzato dallo sviluppo delle capacità produttive e dai bisogni che emergono nella storia. Per questo motivo, pensare di poter abolire la concorrenza semplicemente con delle leggi, mantenendo però il sistema dei salari, rappresenta una contraddizione.Concorrenza e Monopolio
Non bisogna vedere la concorrenza e il monopolio come concetti semplicemente opposti. Sono invece strettamente legati e si influenzano a vicenda in un processo dinamico. Il monopolio come lo conosciamo oggi è nato proprio dalla concorrenza, così come in passato la concorrenza è emersa dal monopolio tipico del sistema feudale. Il monopolio proprio della borghesia non è una forma primitiva, ma il risultato di questa evoluzione. Nella realtà di tutti i giorni, il monopolio e la concorrenza si generano continuamente l’un l’altra e convivono in una tensione costante.Proprietà della Terra e Rendita
La proprietà della terra e la rendita che ne deriva non hanno origini misteriose o esterne al mondo dell’economia. Nascono invece da specifici rapporti sociali che si sono creati nel tempo. La rendita, nel sistema economico attuale, è la parte del prezzo dei prodotti agricoli che supera i costi necessari per produrli. Il suo valore è determinato dalla diversa fertilità dei terreni e dal prezzo di mercato, che è fissato in base ai costi sostenuti sul terreno meno fertile ancora necessario per soddisfare la domanda.La rendita ha trasformato profondamente la vecchia proprietà feudale. Ha introdotto nuove figure come il capitalista agricolo, che gestisce la terra, e il lavoratore salariato, che la lavora. In questo modo, lo sfruttamento della terra è diventato legato alla concorrenza, e la terra stessa è stata trasformata in una merce che si compra e si vende. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i miglioramenti nelle tecniche agricole tendono a far diminuire la rendita, non ad aumentarla.Scioperi e Lotta dei Lavoratori
Gli scioperi e le associazioni tra lavoratori nascono come reazione alla concorrenza che esiste tra i lavoratori stessi e come forma di lotta contro il potere del capitale. Non sono semplicemente cause di problemi o azioni inutili, come a volte vengono presentati. Al contrario, spingono le imprese a cercare nuove tecnologie e sono fondamentali per permettere ai lavoratori di organizzarsi. Queste associazioni permettono ai lavoratori di riconoscersi come una classe unita e consapevole dei propri interessi.Attraverso l’organizzazione, la lotta che inizialmente riguarda questioni economiche si trasforma in una lotta di tipo politico. L’antagonismo fondamentale che caratterizza la società è quello tra i lavoratori (proletariato) e la borghesia (i proprietari dei mezzi di produzione). Questa lotta di classe, quando raggiunge il suo livello più alto, porta a una trasformazione radicale della società. L’obiettivo finale è l’abolizione di tutte le classi sociali e la fine del potere politico inteso come espressione di questo conflitto tra classi.Davvero la complessa realtà sociale si può ridurre a un unico, ineluttabile scontro tra “proletariato” e “borghesia”, con la promessa (o minaccia?) della fine di ogni classe?
Il capitolo propone una visione della società e della storia fortemente incentrata sul conflitto tra due classi principali. Tuttavia, questa prospettiva, pur potente, rischia di semplificare eccessivamente la complessa stratificazione sociale e le molteplici forme di potere e conflitto che attraversano la realtà. Per comprendere appieno le dinamiche sociali al di là di un unico scontro binario, è utile esplorare approcci diversi. Si possono approfondire gli studi di sociologia, in particolare quelli sulla stratificazione e sul conflitto sociale, e le teorie politiche sul potere. Autori come Max Weber, Vilfredo Pareto o Ralf Dahrendorf offrono chiavi di lettura alternative sulla struttura sociale e sulle fonti del conflitto.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]