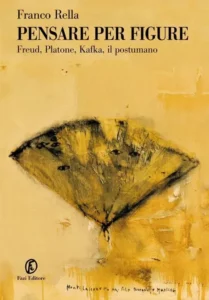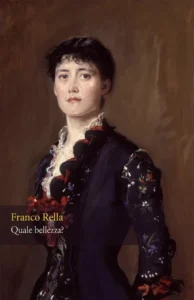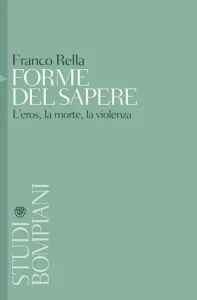1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Micrologie. Territori di confine” di Franco Rella è un libro che ti porta ai margini di quello che pensiamo di sapere, esplorando i veri confini dell’esistenza umana. Non è la solita filosofia chiusa in sé stessa, ma un viaggio attraverso la letteratura e l’arte per affrontare temi enormi come la morte, che non riusciamo a capire del tutto, e l’esperienza interiore, quella roba che sfugge alle parole. Rella guarda a figure come Bataille, Kafka o Nietzsche, che hanno osato spingersi oltre il limite, criticando i sistemi rigidi, tipo quello di Hegel, che lasciano fuori tutto ciò che è scomodo, la singolarità, il caos, la vergogna. È una riflessione appassionata sulla modernità, su come la scienza e la società stiano cambiando la nostra idea di umano, a volte in modi inquietanti, e su come sia fondamentale non evitare la critica e la ricerca di senso, anche quando sembra che non ci sia nessuna verità o giustizia certa. È un invito a guardare in faccia l’impossibile, proprio lì, nei territori di confine.Riassunto Breve
La vita umana si confronta con limiti fondamentali che la ragione e il linguaggio faticano a comprendere pienamente. Esiste un esilio dai sensi nella ricerca del pensiero puro, contrapposto a una “vita necessaria” più cruda e istintiva. La morte è un confine fondamentale, un territorio che dà senso alla vita ma che la ragione fatica a comprendere, riducendola spesso a concetto. Questa difficoltà si riflette nella rappresentazione, dove un dettaglio violento può rivelare una verità indicibile che sfugge alle parole.L’arte e la letteratura si pongono proprio su questo confine tra vita e morte, tra ciò che si può dire e ciò che non si può. Spingono il linguaggio ai suoi limiti per cercare di esprimere l’inesprimibile, l’esperienza dell’impossibile o del “non-sapere”. Questo richiede un sacrificio, un confronto con la bestialità e il bisogno umano. L’esperienza dell'”estremo”, che si manifesta nell’estraniazione o nell’erotismo, è un altro di questi limiti che i sistemi filosofici tendono a lasciare ai margini. Ma questa “negatività senza impiego” è una parte essenziale dell’esistenza umana che chiede di essere riconosciuta. Pensare veramente significa spingersi ai confini del possibile, rischiando la ragione convenzionale per affrontare l’impossibile, l’esperienza interiore che porta a vertigini e vuoto.Anche l’io e la realtà presentano aspetti che sfuggono alla logica e al linguaggio. Il mito offre una via per dare forma all’insensato e all’orrore, rivelando la contraddizione come struttura del reale. La modernità vive su questa frontiera, dove l’identità si costruisce nel cambiamento e le contraddizioni estreme diventano visibili. Le fondamenta stesse sembrano mancare: la giustizia appare basata sul potere più che su un principio certo, la verità è manipolata, e l’inganno è una dimensione costante della vita.Le sfide contemporanee, come la possibilità di modificare geneticamente l’uomo o la percezione della morte e della vecchiaia come qualcosa di esterno e superfluo, mettono ulteriormente in crisi l’idea di cosa sia umano. La scienza attuale, concentrata sul potere e sul possibile tecnico, sembra ignorare la singolarità dell’individuo. Di fronte a un mondo che appare caotico e privo di senso, e a una “bêtise” collettiva che è non-pensiero, emerge la necessità di un pensiero diverso. Questo pensiero deve affrontare ciò che supera la possibilità di essere pienamente compreso, guardando alla nudità e all’unicità dell’ente singolo. È nell’attenzione alla singolarità che si può forse ritrovare un senso e la base per un’etica.Riassunto Lungo
1. L’Esilio della Vita Necessaria
La vita di Descartes è stata dedicata alla ricerca della ragione pura, quasi un esilio volontario dai sensi e dal contatto diretto con il mondo. Questa passione per il pensiero astratto, vissuta spesso in solitudine, rivela un limite dove la ragione più pura si avvicina al corpo e ai sentimenti, come dimostra la sua reazione alla morte della figlia. L’esilio può prendere molte forme. C’è quello geografico, come per autori come Ovidio o Baudelaire, che percepivano il mondo stesso come un luogo di estraneità e persino di orrore. Esiste anche un esilio più intimo, confinato all’interno del proprio corpo, come nel personaggio di Dominique in Simenon.La Forza della Vita Necessaria
Dalla finestra della sua stanza, Dominique, il personaggio di Simenon, vive questo esilio interiore. Da lì osserva la vicina Antoinette e la sua “vita necessaria”. Questa è un’esistenza cruda e istintiva, che rompe con le abitudini convenzionali e spinge verso uno stato più nudo dell’essere. Il vizio, che sia il voyeurismo di Dominique o l’ansia sessuale di Antoinette, sembra essere l’elemento che rende umana questa forza vitale altrimenti percepita come tremenda o puramente animale. Anche Proust esplora un’idea simile di “vita per procura”, osservando come la vecchiaia e la morte possano apparire come un ritorno a uno stato animale o un vero e proprio annientamento, descritto con uno sguardo quasi scientifico o zoologico.Il Confronto con la Morte
La morte emerge come il confine essenziale che ogni idea deve attraversare per potersi manifestare pienamente. È proprio nel confronto con la fine che la vita acquista il suo senso più profondo. In questo scenario, il sacrificio come era inteso tradizionalmente, basato sul valore della vittima offerta, sembra scomparire nell’epoca moderna. Viene sostituito da una logica diversa: l’annientamento di esseri o cose considerate senza valore. Forse l’unico luogo dove il sacrificio mantiene un senso è nell’arte, dove la realtà viene in qualche modo sacrificata per creare un significato più profondo. La scrittura stessa si configura come un confronto diretto con la morte, diventando un non-luogo che conserva le tracce di ciò che è stato vissuto e attraversato.Ma se la “vita necessaria” è cruda e istintiva, perché il vizio dovrebbe essere l’unico elemento capace di renderla “umana” e non semplicemente un’altra forma di istinto o debolezza?
Il capitolo propone che il vizio sia l’elemento che “umanizza” la “vita necessaria”, altrimenti percepita come puramente animale. Questa tesi, per quanto suggestiva, solleva interrogativi sulla natura stessa dell’essere umano e sul ruolo effettivo del vizio. Non è l’unica chiave di lettura possibile. Per comprendere meglio questa complessa relazione tra istinto, vizio e umanità, sarebbe utile confrontarsi con autori che hanno esplorato le profondità della psiche e del comportamento umano, come Freud o Dostoevsky, o con approcci filosofici che mettono in discussione le definizioni convenzionali di morale e natura, come quelli proposti da Nietzsche.2. L’Abisso tra le Parole e la Verità della Morte
Un piccolo dettaglio, come il piede nudo di un soldato morto descritto da Bataille, può svelare una verità cruda e insopportabile che le parole non riescono a cogliere. Questa verità è violenta, indecente, e segna la fine di “ciò che è”. È una verità che sembra guardarci senza avere occhi, chiedendo di essere vista. Allo stesso modo, nel racconto di Balzac, un singolo piede che spunta da un dipinto caotico è ciò che resta di una bellezza perduta. Questo frammento mostra il fallimento del linguaggio della pittura e il legame profondo tra arte e sacrificio. L’arte, come la scrittura, è legata all’idea di sacrificio. Non si tratta solo di distruzione, ma anche della scomparsa dell’artista o del soggetto all’interno dell’opera stessa.La filosofia e la morte
La morte è un tema difficile da affrontare direttamente per la filosofia occidentale. Spesso viene ridotta a un’idea astratta o a un sentimento come l’ansia o la noia. Si dice che l’uomo sia “morte incarnata”, e la paura della morte genera violenza. Esperienze come l’insonnia o lo stare ai limiti della coscienza permettono di avvicinarsi al mondo del morto o del dormiente, mostrando quanto siano vicini vita e morte. Mentre la filosofia cerca di ricostruire un senso con le parole di fronte alla perdita di significato causata dalla morte, la letteratura si spinge oltre, affrontando quel limite dove il pensiero razionale non basta più.L’arte sul confine tra vita e morte
La letteratura, la poesia e l’arte si collocano in uno spazio intermedio, sul confine che separa la vita dalla morte, il giorno dalla notte. Il poeta ha un legame speciale con la morte e la sua opera canta questo confine, l’incontro tra il tempo umano e l’eternità. L’occhio del poeta diventa come l’occhio della morte, capace di guardare verso il vuoto. La poesia forza il linguaggio oltre i suoi limiti, nell’abisso che si apre tra le parole, per raccontare ciò che non si può esprimere. Dare una forma alla morte significa dare una forma a se stessi, ma questo processo è fragile e rischioso.Il pericolo della bellezza vuota e il bisogno di sacrificio
Il pericolo per l’arte è diventare solo bella, una bellezza fine a se stessa che nasconde la verità profonda. In questo caso, il contenuto si perde in una forma senza significato. La vera opera d’arte richiede sacrificio. Questo atto si oppone alla dissoluzione nella forma vuota e rivela la parte più istintiva e vulnerabile dell’umanità, il suo bisogno di aiuto.L’esperienza dell’impossibile e il ruolo delle immagini
L’esperienza di ciò che è impossibile da conoscere, il “non-sapere” che va oltre il pensiero, si manifesta attraverso immagini che a volte sembrano non avere senso, come una bellezza che non si può descrivere. L’uomo si distingue dagli animali creando immagini e miti che si uniscono formando figure e storie. Queste immagini non restano isolate ma si legano tra loro, sopravvivono in frammenti e si ricompongono. Questo processo permette di comunicare esperienze che altrimenti non potremmo condividere, anche attraverso la sofferenza o il sacrificio.Scienza, mito e la resistenza dell’arte
La scienza moderna, con i suoi linguaggi tecnici e la capacità di manipolare la vita, sembra aver assorbito la parte più oscura e misteriosa dell’esistenza. Questo ha portato alla scomparsa del sacro e a una crisi dei miti tradizionali. Tuttavia, l’arte resiste alle immagini imposte dalla società. L’arte spezza le immagini che ci vengono forzatamente proposte per costruire, dalle rovine, visioni di mondi diversi e possibili. Questo è il compito più importante e la ragione d’essere dell’arte.Ma cosa si intende esattamente per “sacrificio” nell’arte, e come si distingue dalla semplice sofferenza o dalla ricerca di sensazionalismo?
Il capitolo lega il sacrificio alla “vera opera d’arte” in opposizione alla “bellezza vuota”, suggerendo riveli una “parte più istintiva e vulnerabile”. Tuttavia, il concetto rimane piuttosto astratto e rischia di diventare un criterio valutativo soggettivo o poco chiaro. Approfondire le teorie estetiche sul ruolo dell’artista, il rapporto tra etica ed estetica, e le diverse manifestazioni del “sacrificio” (dalla performance art al processo creativo) potrebbe chiarire questo punto cruciale. Pensatori che hanno esplorato il legame tra arte, corpo e limite potrebbero offrire spunti utili.3. L’Estremo Contro il Sistema
Sentirsi estranei e vivere esperienze estreme caratterizzano l’esperienza umana. Questa condizione di profonda estraniazione si ritrova in Kafka. Georges Bataille esplora ulteriormente l’estremo, soprattutto nell’erotismo, descritto come qualcosa di squallido e senza via d’uscita, un luogo dove ci si perde completamente. Queste esperienze estreme, difficili da spiegare, sono fondamentali nel pensiero di Kafka e Bataille.Il Sistema di Hegel e la Fuga dall’Estremo
Georg Wilhelm Friedrich Hegel costruisce il suo sistema filosofico, come nella Fenomenologia dello spirito, cercando di allontanarsi da questo estremo e dalla paura di perdere il controllo, della follia. Per Hegel, la singolarità, ciò che è unico e non rientra negli schemi, è vista come una sorta di “notte” o “puro nulla”. Questo viene poi riordinato e compreso dalla ragione e dalla parola (il Logos). Ciò che non può essere inquadrato in questo modo viene considerato poco importante.Bataille e la Negatività Esclusa
Georges Bataille si riconosce proprio in questa parte che il sistema di Hegel lascia fuori, quella che lui chiama “negatività senza impiego”. La sua stessa vita, vista come una “ferita aperta”, è una dimostrazione che il sistema chiuso di Hegel non basta a spiegare tutto. Bataille non accetta di essere considerato trascurabile. Cerca di capire cosa diventa questa negatività esclusa, trovando le sue prime manifestazioni nell’arte e nella religione, anche se lì non viene riconosciuta per quello che è veramente.La Negatività Riconosciuta
Chi vive questa negatività senza impiego deve arrivare a riconoscerla, a diventare l’uomo della “negatività riconosciuta”. Questo significa accettare una negatività che non ha un contenuto definito o uno scopo pratico. Riconoscere questa condizione non è qualcosa di sbagliato, ma è parte fondamentale dell’essere umani. Permette di liberare e affrontare emozioni forti legate alla distruzione, a ciò che è osceno, all’erotismo, al riso, alla paura. Questa possibilità, questa “chance”, sottolinea quanto sia importante avere una comunità dove questa negatività possa essere vista e accettata anche dagli altri.Il Confronto con Kojève
Il confronto con Alexandre Kojève, uno studioso importante di Hegel, chiarisce bene le differenze. Kojève interpreta l’esperienza di Bataille come una forma di misticismo, un parlare del nulla che in realtà non dice nulla di concreto, un allontanarsi dalla ragione hegeliana che si occupa dell’Essere. Bataille non è d’accordo con questa visione. Sostiene che il suo pensiero non cerca di arrivare a un’unità o a una soddisfazione finale, ma mira a mantenere una “tensione critica”. Questa tensione esplora ciò che è impossibile, andando oltre i limiti di ciò che consideriamo possibile.Filosofia, Arte e i Limiti del Pensiero
La filosofia, proprio come l’arte, ha il compito di spingersi ai confini del linguaggio e del pensiero. Solo così può provare a esprimere ciò che non può essere detto facilmente, confrontandosi con l’estremo e con l’idea di follia. Theodor W. Adorno condivide questa critica verso i sistemi di pensiero che lasciano fuori ciò che non rientra nei concetti e ciò che è estremo. Questo è diventato ancora più evidente dopo eventi terribili come Auschwitz, che sfidano ogni tentativo di comprensione razionale.La Scrittura di Bataille come Esplorazione
Le opere letterarie di Bataille sono un esempio di questo sforzo di portare il pensiero ai suoi limiti. Esplorano l’eccesso, ciò che va oltre ogni base o fondamento, e l’impossibile. La sua scrittura, anche quando affronta argomenti difficili o sgradevoli, cerca di alludere a una totalità e all’impossibile. È un’esperienza interiore che si manifesta in un linguaggio che sembra morire nel tentativo di dire qualcosa che, in fondo, non può mai essere detto completamente.Davvero la filosofia e la scienza contemporanee sono così impreparate di fronte alla modifica genetica?
Il capitolo solleva un punto cruciale sulla portata delle nuove tecnologie di modifica umana, ma l’affermazione che la filosofia e la scienza attuali non stiano affrontando adeguatamente questo cambiamento sembra una generalizzazione eccessiva. Esistono interi campi di studio, come la bioetica e la filosofia della tecnologia, che da decenni dibattono intensamente le implicazioni etiche, sociali ed esistenziali di queste possibilità. Per approfondire questo dibattito e comprendere la complessità delle risposte già in atto, è utile esplorare le opere di autori che si sono dedicati a questi temi, come Jürgen Habermas o Peter Singer, e confrontarsi con le diverse correnti di pensiero all’interno della bioetica e della filosofia della scienza.12. La singolarità come confine
La morte e la vecchiaia, nella vita di oggi, generano un profondo disagio. La morte non viene più vista come una parte naturale dell’esistenza, ma come un evento estraneo che rende le persone superflue, come se non avessero più un posto nel mondo. Anche la vecchiaia è percepita come un momento difficile, un confine che provoca lo stesso senso di inutilità. Questa fase della vita è spesso vissuta come un mistero, un territorio sconosciuto, accompagnato dalla perdita della memoria e da un senso di vuoto interiore.Le domande che evitiamo
Le atrocità del passato, come quelle di Auschwitz, dove gli esseri umani sono stati ridotti a essere superflui, e le nuove scoperte scientifiche, come la clonazione, ci costringono a chiederci cosa significhi ancora essere umani e quali siano i limiti del pensabile. Eppure, il pensiero dominante oggi sembra evitare queste domande fondamentali, preferendo rifugiarsi in argomenti considerati meno rilevanti o più facili da affrontare. Questo allontanamento dalle questioni esistenziali profonde contribuisce al senso di smarrimento e vuoto che caratterizza la nostra epoca.Trovare un senso nella singolarità
Di fronte a questa situazione, emerge la necessità di una nuova prospettiva filosofica. Questa nuova visione non cerca risposte al di là delle cose concrete, ma le trova proprio dentro l’unicità irraggiungibile di ogni individuo, nella singolarità di ogni essere. Pensare oggi significa avere il coraggio di affrontare ciò che sembra superare la nostra capacità di comprensione, guardando all’essere umano nella sua essenza più pura e irripetibile. Concentrare l’attenzione su questa singolarità, su ciò che rende unico ogni individuo, potrebbe rappresentare il punto di partenza per costruire una nuova etica e per riscoprire un significato profondo in un mondo che sembra averlo smarrito.Se il capitolo identifica un disagio e un senso di smarrimento diffusi, legati alla percezione collettiva della morte e della vecchiaia, come può la “singolarità irraggiungibile” del singolo individuo offrire una soluzione o fondare una nuova etica che sia valida oltre il sé?
Il capitolo descrive con efficacia il disagio contemporaneo di fronte alla morte e alla vecchiaia e l’evitamento delle domande esistenziali fondamentali, proponendo nella “singolarità irraggiungibile” dell’individuo la chiave per una nuova prospettiva filosofica e un ritrovato senso. Tuttavia, il passaggio dal problema, che viene presentato come un fenomeno sociale e culturale diffuso (“la vita di oggi”, “il pensiero dominante oggi”), alla soluzione, centrata sull’unicità del singolo, non è pienamente argomentato. Non è chiaro come un concetto così intrinsecamente legato all’irripetibilità e, per definizione, all’isolamento del singolo possa fornire risposte o fondamenti validi per affrontare problemi che il capitolo stesso presenta come collettivi o condivisi, come il disagio verso la morte e la vecchiaia o la necessità di una nuova etica che vada oltre la mera contemplazione del proprio essere unico. Per esplorare questo nodo cruciale, sarebbe utile confrontarsi con autori che hanno meditato sul rapporto tra l’individuo e la comunità, sul significato della condizione umana condivisa e sulla possibilità di fondare l’etica non solo sull’unicità del sé. Autori come Hannah Arendt, che ha analizzato la condizione di “superfluità” nell’esperienza totalitaria e il rapporto tra vita attiva e vita contemplativa, o Emmanuel Levinas, che ha posto l’etica nell’incontro con l’alterità irriducibile dell’altro, potrebbero offrire prospettive utili per comprendere meglio come la singolarità si relazioni al mondo condiviso e alla possibilità di un’etica universale o intersoggettiva.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]