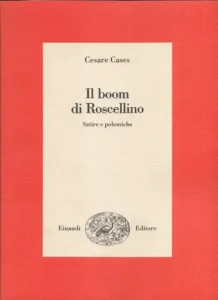Contenuti del libro
Informazioni
“Marxismo e neopositivismo” di Cesare Cases è un libro che ti prende e ti sbatte nel vivo di un dibattito super importante per capire un certo periodo, soprattutto in Italia. Immagina un confronto acceso tra chi difende il marxismo come una vera e propria visione del mondo, un materialismo dialettico capace di spiegare un sacco di cose, e chi invece lo riduce a una semplice “tecnica” o metodologia, un po’ come fanno i neopositivisti. Cases si schiera forte, difendendo pensatori come Lukács, mostrando come la sua estetica marxista, con la teoria del rispecchiamento, sia fondamentale per non far diventare l’arte solo un prodotto sociale, e insiste sull’importanza della categoria di totalità, che i neopositivisti tendono a ignorare. Critica questa mentalità che definisce “provinciale”, perché spesso liquida le tradizioni di pensiero italiane, anche quelle di Gramsci o dello stesso Lukács, come vecchie o superate senza un vero confronto. Il libro attacca anche l’idea del “conto della serva”, un approccio super pragmatico e riduttivo che smonta concetti come alienazione o nazione, legato a un certo tipo di neocapitalismo. Alla fine, è una difesa appassionata della necessità di avere una visione del mondo solida contro il rischio di perdersi solo nelle tecniche o in un conformismo senza pensiero.Riassunto Breve
Si critica una certa mentalità neopositivistica che si diffonde soprattutto a sinistra, la quale riduce il marxismo a una semplice metodologia scientifica, negandogli il valore di visione completa del mondo. Questa corrente identifica la visione del mondo con il dogmatismo e si presenta come l’unica interprete valida della scienza moderna, relegando altre filosofie a scelte personali o “metafisica”.Si difende invece il materialismo storico e dialettico come una visione del mondo capace di spiegare la realtà in modo unitario. In questo contesto, si valorizza l’estetica di Lukács, in particolare la sua teoria del rispecchiamento, che aiuta a capire come l’arte non sia solo un prodotto sociale, ma mantenga un valore autonomo. L’approccio di Lukács, con la sua insistenza sulla categoria di totalità ereditata da Hegel, viene messo a confronto con il marxismo di Gramsci, che sembra non usare sistematicamente questa categoria.La mentalità neopositivistica tende a considerare le tradizioni culturali italiane, inclusi pensatori come Gramsci e Lukács, come “provinciali” o superate, senza un’analisi teorica approfondita. Questo serve a squalificare le posizioni diverse. Nell’estetica, questo approccio separa l’analisi sociologica o formale dal giudizio di valore, non riuscendo a unire la comprensione storica dell’opera con la sua capacità di durare nel tempo. Si promuove un approccio analitico o linguistico, spesso di origine anglosassone, che non affronta la questione del valore perenne dell’arte e appare più una moda che uno sviluppo teorico solido.Il neopositivismo e correnti simili rifiutano l’idea di una realtà oggettiva e di una visione del mondo, concentrandosi sulle tecniche e sulla metodologia. Si pensa che i risultati validi si ottengano indipendentemente dalle idee filosofiche di base. Questo non considera che risultati importanti, come la critica letteraria di Lukács, sono strettamente legati alla sua filosofia. Il materialismo dialettico, invece, afferma che l’essere viene prima della coscienza, un principio che garantisce l’oggettività della ricerca.Le tecniche (sociologiche, economiche, scientifiche) sono utili, ma non possono sostituire una visione complessiva della realtà. Elevare la tecnica a principio guida senza una base teorica porta a un indebolimento intellettuale. La mancanza di una visione del mondo chiara genera confusione e impedisce di affrontare i problemi reali. Una visione oggettiva della realtà è necessaria per dare un senso alla ricerca e all’azione.Questa “nuova cultura” basata su un approccio empirico, chiamato “conto della serva”, critica concetti come alienazione, proletariato, Stato e Nazione, considerandoli superati o semplici etichette. L’alienazione diventa solo disuguaglianza di potere contrattuale, il proletariato un concetto sociologico, lo Stato una semplice organizzazione pratica. Questo approccio pragmatico e riduttivo è legato al neocapitalismo. Si osserva che questa mentalità del “conto della serva” ha prevalso, portando a una sorta di fine del pensiero e della ragione, che si adatta bene alle caratteristiche del neocapitalismo.Riassunto Lungo
1. La Battaglia Ideologica e l’Eredità di Lukács
Si critica la mentalità neopositivistica, soprattutto quando prende piede negli ambienti di sinistra. In opposizione a questa visione, si difende con forza il materialismo storico e dialettico come una visione del mondo completa e valida. Un punto cruciale di questa difesa riguarda l’estetica di Lukács. La sua teoria del rispecchiamento viene presentata come uno strumento essenziale per evitare di considerare l’arte e la letteratura solo come meri prodotti della loro origine sociale o del punto di vista di classe. Questa prospettiva permette di apprezzare la complessità e l’autonomia relativa dell’opera d’arte.Confronto con Gramsci
Si confronta l’approccio di Lukács con il marxismo di Gramsci. Si nota che Gramsci, almeno in linea teorica, non accetta la teoria del rispecchiamento. Inoltre, non utilizza in modo sistematico la categoria di totalità. La totalità è considerata una parte essenziale dell’eredità hegeliana all’interno del pensiero marxista. Lukács, al contrario di Gramsci, insiste molto su questa categoria, vedendola come fondamentale per la comprensione della realtà sociale e culturale.Provincialismo e Tecniche di Analisi
Si affrontano anche altri concetti importanti. Uno di questi è il provincialismo, definito come un modo di guardare alle novità culturali in maniera limitata. Questo atteggiamento si manifesta soprattutto nei confronti delle influenze che provengono dall’esterno. Un altro tema trattato è il rapporto tra il pensiero marxista e diverse ‘tecniche’ di analisi. Vengono considerate, ad esempio, le tecniche sociologiche o quelle psicologiche, esplorando come si relazionano con la visione materialista.La Validità del Materialismo e l’Esempio di Lukács
Si afferma la validità della visione del mondo materialista. Questa prospettiva si dimostra efficace per la sua capacità di spiegare in modo unitario numerosi fenomeni complessi. Possiede inoltre un notevole potenziale di ulteriore sviluppo e approfondimento teorico. L’opera di Lukács rappresenta un esempio concreto e significativo di come questa visione del mondo possa essere applicata e sviluppata. Il suo lavoro dimostra la forza e la coerenza del materialismo storico e dialettico nell’analisi della realtà.Affermare la validità del materialismo storico e dialettico come visione del mondo ‘completa e valida’ non ignora forse decenni di critiche filosofiche e storiche che ne hanno messo in discussione proprio la pretesa di totalità e la capacità esplicativa?
Il capitolo difende con forza il materialismo storico e dialettico, presentandolo come una visione del mondo unitaria e capace di spiegare fenomeni complessi, citando Lukács come esempio della sua applicazione. Tuttavia, questa difesa appare unilaterale, poiché non si confronta con le numerose obiezioni e i limiti che sono stati sollevati nei confronti di questa prospettiva nel corso del tempo. La mancanza di un dialogo con le critiche rende l’affermazione della sua “validità” meno convincente. Per approfondire questo dibattito e comprendere le sfide poste al materialismo, sarebbe utile esplorare la filosofia della storia e la critica delle ideologie, leggendo autori come Karl Popper o Raymond Aron, che hanno analizzato criticamente le pretese di scientificità e totalità del marxismo.2. Il Neopositivismo e la Questione Provinciale
In Italia si diffonde una corrente di pensiero che si presenta come l’unica via scientifica per interpretare il marxismo. Questa visione sostiene che il marxismo sia soltanto un metodo di analisi, non una visione completa del mondo, e identifica quest’ultima con posizioni rigide considerate superate. Chi segue questa corrente si propone come l’unico interprete valido della scienza moderna, relegando altre filosofie a semplici opinioni personali o a idee astratte e non scientifiche.Come giudicano le tradizioni italiane
Questo gruppo usa un altro modo per affermare la propria superiorità: definisce le tradizioni culturali italiane, inclusi pensatori importanti come Gramsci o Lukacs, come “provinciali” o non più attuali, legate a contesti considerati arretrati. Questo giudizio non si basa su un’analisi approfondita delle idee, ma serve semplicemente a squalificare le posizioni diverse dalla propria, etichettandole come superate senza un vero confronto teorico.Il loro approccio all’arte
Nell’ambito dell’estetica, cioè dello studio dell’arte, questa metodologia tende a separare l’analisi di come l’arte è influenzata dalla società o della sua forma, dal giudizio sul suo valore estetico. Non riescono a unire la comprensione del contesto storico in cui un’opera d’arte nasce con la valutazione di quanto quell’opera sia valida e importante nel tempo. Pensatori come Lukacs e Gramsci, invece, cercavano proprio di mettere insieme questi aspetti, affrontando il problema di come l’arte, pur essendo legata al suo tempo, possa mantenere il suo valore anche in epoche diverse.I limiti di questa visione
La metodologia di questa corrente, pur criticando i vecchi modi di studiare l’arte solo dal punto di vista sociale, non offre una soluzione concreta per un “metodo completo” che sappia unire storia ed estetica in modo efficace. Si limita a promuovere un approccio basato sull’analisi dei dettagli o sul linguaggio, spesso riprendendo idee nate in altri paesi, che non affronta la questione fondamentale del perché l’arte continui ad avere valore nel tempo. Questa tendenza appare più come una moda culturale del momento che come un vero e solido sviluppo teorico, incapace di raccogliere in modo critico e costruttivo le tradizioni di pensiero già esistenti.Se questa corrente si presenta come l’unica via scientifica e liquida le tradizioni italiane come “provinciali”, su quali basi teoriche solide fonda tale superiorità, al di là della mera etichetta?
Il capitolo descrive come questa corrente tenda a squalificare le tradizioni di pensiero italiane senza un’analisi approfondita, definendole genericamente “provinciali”. Questo approccio solleva un interrogativo fondamentale sulla validità del loro giudizio e sulla solidità della loro stessa posizione teorica. Per comprendere meglio questo scontro e valutare la fondatezza delle critiche mosse, sarebbe essenziale approfondire non solo le idee della corrente in questione, ma soprattutto quelle tradizioni che vengono liquidate, come il pensiero di Gramsci e Lukacs, per capire se il giudizio di “provincialismo” sia effettivamente motivato o sia solo uno strumento retorico per affermare un presunto primato.3. La necessità di una visione del mondo contro il primato della tecnica
Alcune correnti di pensiero, come il neopositivismo, non ritengono necessaria una visione complessiva del mondo né credono nell’esistenza di una realtà oggettiva. Si concentrano invece sulla metodologia e sulle tecniche di ricerca. L’idea è che si possano ottenere risultati validi, ad esempio nella ricerca scientifica, indipendentemente dalle proprie idee filosofiche. Questo approccio, però, non considera che risultati importanti, come la critica letteraria di Lukacs, sono invece profondamente legati al pensiero filosofico di chi li produce.
Il primato dell’essere e l’oggettività
Al contrario, il materialismo dialettico mette l’essere prima della coscienza. Questo principio è fondamentale per garantire che la ricerca scientifica sia oggettiva e per contrastare l’idea che tutto sia relativo. Anche nel pensiero di Marx si trovano elementi di questo materialismo dialettico, anche se alcuni studiosi vicini al neopositivismo hanno cercato di separare il suo studio della storia da ogni idea sulla realtà oggettiva.
Il ruolo e i limiti della tecnica
Le tecniche, che siano sociologiche, economiche o scientifiche, sono strumenti utili, specialmente in contesti dove c’è bisogno di sviluppare la ricerca, come in Italia o nei paesi socialisti in passato. Tuttavia, questi strumenti non possono sostituire una visione generale della realtà. Mettere la tecnica al primo posto, senza avere solide basi teoriche, porta a un indebolimento del pensiero e della morale. Nei paesi socialisti, ad esempio, una certa rigidità nel pensiero ha spinto verso un eccessivo uso della tecnica, ma senza una visione del mondo chiara e viva, i tecnici non sono riusciti a trasformare le loro capacità in azioni politiche efficaci.
Le conseguenze della mancanza di visione
In Italia, dare troppa importanza alla metodologia e a una generica “apertura” culturale, senza avere una base teorica coerente, crea confusione. Questo impedisce la formazione di intellettuali capaci di affrontare i problemi concreti della società. Una visione del mondo, invece, offre una guida per pensare e agire. La mancanza di una visione oggettiva della realtà può portare a perdersi in pensieri irrazionali o ad accettare passivamente le idee dominanti. È importante riscoprire il desiderio di comprendere la realtà nella sua totalità oggettiva per dare un senso profondo alla ricerca e alla vita.
[/membership]Ma questa ‘visione oggettiva della realtà’ che il capitolo invoca, non rischia di essere solo un’altra forma di dogma?
Il capitolo postula la necessità di una “visione oggettiva della realtà” per dare senso alla ricerca e contrastare la confusione. Tuttavia, l’idea stessa di una visione oggettiva e universalmente accessibile è un tema complesso e molto dibattuto in filosofia. Affermare la sua esistenza e necessità senza chiarire come accedervi o come distinguerla da una semplice costruzione ideologica rischia di sostituire un problema con un altro, potenzialmente dogmatico. Per approfondire queste questioni e capire i limiti e le possibilità della conoscenza oggettiva, è fondamentale studiare l’epistemologia e la filosofia della scienza. Autori come Karl Popper o Thomas Kuhn offrono prospettive diverse e critiche sul concetto di oggettività scientifica e sulla natura della conoscenza.4. Il Conto della Serva e la Fine del Pensiero
Una nuova cultura e una nuova politica si basano su un approccio pratico, chiamato “conto della serva”. Questo modo di pensare si oppone a idee più astratte e complesse. Critica i concetti tradizionali, vedendoli come un linguaggio legato a vecchie ideologie.Un Nuovo Sguardo sui Concetti Tradizionali
L’alienazione, ad esempio, non è vista come un problema reale, ma come una parola inventata. La vera questione è la differenza di forza tra chi vende e chi compra. Anche il proletariato non esiste come un gruppo storico concreto, ma è solo un’idea usata in sociologia; la realtà è fatta di singole persone. Concetti come Stato e Nazione sono considerati vecchie idee superate, risalenti all’Ottocento.Gli Stati e la Storia
Gli stati sono descritti semplicemente come gruppi che operano nello stesso ambito, paragonati a “botteghe di barbiere”. La cosa importante è come questi gruppi si organizzano. L’Italia, per esempio, viene vista come una struttura che mantiene disoccupazione e analfabetismo. Se la nazione è un’idea vuota, anche la storia che la riguarda, come il Risorgimento, viene messa in discussione.Il Legame con il Neocapitalismo e la Fine del Pensiero
Questo approccio pratico del “conto della serva” è strettamente legato al neocapitalismo. Chi cerca modi di pensare diversi non dovrebbe essere considerato un nemico, ma un alleato contro la superficialità del neocapitalismo, che si manifesta in questa visione riduttiva e basata solo sulla praticità. Si osserva che questa mentalità pratica, identificata con le “orde del Conto della Serva”, ha prevalso. Non resta che accettare che il pensiero e la ragione stiano scomparendo. Questo processo è visto come uno spegnimento tranquillo, semplice e utile, in linea con le caratteristiche del neocapitalismo. Anche la storia del pensiero scientifico trova la sua conclusione in questa nuova realtà.Se l’alienazione, il proletariato e lo Stato sono solo parole vuote o idee superate, come possiamo allora analizzare le profonde disuguaglianze, i rapporti di potere e le strutture sociali che persistono?
Il capitolo, nel liquidare concetti fondamentali della tradizione critica come mere etichette obsolete, rischia di trascurare i fenomeni complessi e persistenti che tali concetti intendevano descrivere. La riduzione della realtà sociale a un mero “conto della serva” pratico ignora le dinamiche storiche, economiche e politiche che plasmano la vita degli individui e dei gruppi. Per approfondire la comprensione di queste strutture e dinamiche, al di oltre di una visione puramente superficiale, è utile confrontarsi con le analisi della sociologia critica, della filosofia politica e dell’economia. Autori come Marx, Weber e i pensatori della Scuola di Francoforte offrono strumenti concettuali per indagare la natura del potere, dell’organizzazione sociale e delle forme di disuguaglianza nel capitalismo moderno.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]