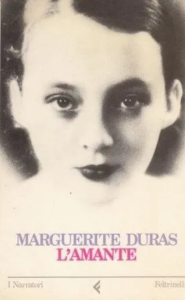1. L’Attesa e il Ritorno
Marguerite attende con angoscia il ritorno del marito Robert L., deportato in un campo di concentramento. Il telefono è l’unico legame con il mondo, portatore di speranze e delusioni. I campi vengono liberati, ma il nome di Robert non compare mai. Al Centro d’Orsay, tra frenesia e burocrazia, Marguerite cerca notizie. Incontra l’indifferenza di alcuni, ma anche la solidarietà di chi condivide il suo dolore. La città si prepara a festeggiare la fine della guerra, ma la speranza di Marguerite si affievolisce. Eppure, continua a cercare, aggrappandosi a ogni voce, a ogni frammento di notizia. Reduci dal campo raccontano dettagli confusi, contraddittori: un’altalena tra speranza e disperazione. Una telefonata inattesa: Robert è vivo, a Dachau, ma in condizioni disperate. Inizia un viaggio verso la Germania, un viaggio della speranza per riportarlo a casa. Robert torna, fragile, segnato nel corpo e nell’anima. Il suo silenzio racconta l’orrore. Inizia una nuova lotta, quella per la sopravvivenza, tra le mura di casa, con le cure e l’amore di Marguerite. Il corpo di Robert, debole e sofferente, testimonia il passato, ma è anche la promessa di una rinascita.2. Il Ritorno Dalla Notte
L’uomo torna dai campi di concentramento molto magro, con piaghe e ferite. Per diciassette giorni sta malissimo, con scariche corporee anomale che spaventano chi lo aiuta.Poi la febbre passa e arriva una fame fortissima. L’uomo mangia tantissimo, come se volesse recuperare tutte le forze perse. Questa fame è l’unica cosa a cui pensa. Chi gli sta vicino, come la narratrice, vive con ansia questo momento, condividendo il suo tormento.Migliorando fisicamente, appaiono le ferite emotive. La notizia della morte della sorella è un colpo durissimo. La relazione con la narratrice finisce, un’altra separazione nella sua vita distrutta. Anche se recupera peso e forze, il soggiorno in Italia mostra un uomo ancora segnato dal trauma. La narratrice lo guarda, sapendo che l’ombra dei campi è ancora su di lui, ma è anche felice che sia sopravvissuto.6. Smarrimento tra le ortiche
Lungo una strada di periferia, dove il cemento lascia spazio a pietre e sterpaglie, un uomo siede immobile. Baracche di legno, circondate da recinzioni improvvisate e ortiche, si ergono come testimoni silenziose di un progetto urbano incompiuto. Voci di bambini e suoni di vita quotidiana emergono dalle abitazioni precarie. Un bambino spinge un passeggino, il fratellino addormentato, e lancia occhiate curiose all’uomo solitario. Poco dopo, un operaio, Lucien, si siede accanto a lui, consumando il suo pasto frugale. L’uomo lo osserva in silenzio, un silenzio che pesa come l’aria stagnante del pomeriggio. “Dove mi trovo?”, chiede infine l’uomo, la voce incrinata da un disorientamento palpabile. Lucien indica la periferia di Parigi, un confine incerto tra città e campagna abbandonata. Lo sguardo dello straniero cade sulla mano ferita di Lucien, un’occasione per parlare di fabbriche, presse e incidenti. Lucien descrive il suo lavoro, il pericolo costante, ma anche una strana preferenza per il rischio rispetto alla monotonia. Offre vino al bambino, sigarette all’uomo. Un gesto di condivisione in un’atmosfera sospesa. L’uomo chiede se Lucien sia felice del suo lavoro, una domanda che cade nel vuoto, senza una risposta. Il silenzio ritorna, interrotto solo da brevi scambi. Un gesto improvviso: l’uomo sfiora un’ortica, un piccolo dolore che risveglia qualcosa. Lucien parla dell’occupazione finita, dei cecchini, un ricordo che riporta entrambi a una realtà condivisa. La sirena della fabbrica rompe l’incantesimo. Lucien si alza, il tempo della pausa è finito. Il bambino viene richiamato a casa. L’uomo rimane solo, seduto, lo sguardo perso nel vuoto. Il bambino, voltandosi indietro, percepisce nell’immagine di quell’uomo immobile un presagio, l’ombra silenziosa di qualcosa di incomprensibile.7. Berlino
Una foresta ondeggia al vento oltre i vetri, mentre una bambina osserva il paesaggio da una torre. Rose, ormai appassite, evocano un paese lontano, sconosciuto alla piccola. Il cielo, seppur scuro, mostra ancora un po’ di blu. La bambina, ignara del mondo esterno, canta in una lingua antica, l’ebraico, che le è familiare ma allo stesso tempo estraneo. Si guarda allo specchio, notando i capelli neri e gli occhi blu, dettagli di un’identità ancora da scoprire. Nella stanza, una signora piange sommessamente accanto a una rivoltella, in perenne attesa della polizia tedesca. Da anni, vive con la bambina in questo rifugio, pronta a un gesto estremo per proteggerle entrambe. La bambina, per distrarre la signora, chiude le tende e gioca con un gatto e una farfalla morta. Ma la guerra incombe, il rombo degli aerei squarcia il cielo. La signora, spaventata, chiede alla bambina di parlarle. La piccola, con una strana preveggenza, annuncia l’arrivo degli aerei. Il loro fragore riempie la stanza, portando con sé la minaccia della morte. La bambina, quasi in trance, sa dove sono diretti: Berlino. La signora e la bambina si rifugiano in una stanza interna, dove la guerra sembra lontana. Si stringono l’una all’altra, piangendo e ridendo insieme. La signora confida alla bambina di piangere ogni giorno per il “mirabile errore della vita”. La bambina ripete che il loro destino è morire, uccise dalla signora stessa. La conversazione si sposta su dettagli confusi: il nome del gatto, Aranacha, un pezzo di stoffa bianca con le iniziali A.S. e una data di nascita. La bambina, con la sua chiaroveggenza, annuncia l’arrivo degli aerei su Berlino, il ritorno dalla missione, il numero dei morti. La signora esulta per le vittime, in un misto di orrore e sollievo. La bambina, allo specchio, si definisce ebrea, ricordando il negozio della madre a Parigi e il padre siriano. La routine si ripete: gli aerei tornano, questa volta diretti a Düsseldorf. La bambina ha paura, la signora la rassicura, elencando città tedesche da distruggere. Un aereo precipita, incendiando la foresta. La signora, in preda a ricordi confusi, parla di ebrei, treni, e della bambina che cresce troppo in fretta. Rivela di aver ricevuto la bambina dalla madre, poco prima dell’arrivo della polizia tedesca. La bambina, appoggiando la testa sulle ginocchia della signora, scopre il nome della madre: Aurélia Steiner. Anni dopo, nella stessa stanza, la bambina è cresciuta. La foresta e il vento sono sempre lì, ma le rose sono morte. La ragazza, ora diciottenne, si presenta: “Mi chiamo Aurélia Steiner. Abito a Parigi. Scrivo”.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]