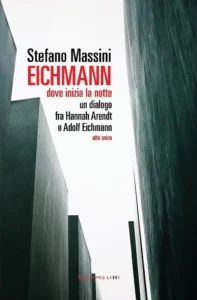1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Manuale di sopravvivenza. Messaggi in bottiglia d’inizio millennio” di Stefano Massini è un libro che ti prende e ti sbatte dentro il casino in cui viviamo. Parte analizzando la nostra società digitale, quella fatta di like, relazioni usa e getta, politica che cambia idea ogni cinque minuti e un lavoro che ti insegue ovunque, mostrandoci quanto siamo diventati bravi a nasconderci dietro schermi e password, perdendo un po’ il contatto con quello che sentiamo davvero e con gli altri, in una specie di costante ricerca di un nemico per sentirci vivi. Poi, di colpo, arriva la pandemia del 2020, un evento che squarcia il velo sulla nostra presunta invincibilità tecnologica e rivela tutta la nostra fragilità umana. Il libro racconta come questa crisi contemporanea ci ha costretti a fare i conti con la paura, l’isolamento, l’incertezza del futuro e la perdita di controllo, cambiando il modo in cui ci relazioniamo, percepiamo il tempo e persino noi stessi. Non ci sono personaggi nel senso classico, ma è come se il protagonista fossimo noi, la società, alle prese con queste sfide enormi. È una serie di riflessioni sul presente, quasi come dei messaggi in bottiglia lanciati per capire dove siamo finiti e, forse, trovare un modo per sopravvivere a questo inizio millennio un po’ caotico.Riassunto Breve
La vita di oggi è molto digitale e veloce, piena di cose che si usano e si buttano via, dalle cose fisiche alle idee e anche ai rapporti tra le persone, che finiscono facilmente come un’amicizia online. La politica cambia spesso idea, senza nemici o schieramenti fissi. Le emozioni e i ricordi diventano numeri sui social, misurati in “mi piace”, e questo fa pensare solo a sé stessi, senza capire davvero gli altri. È difficile trovare il proprio vero sentire, come cercare una password. Le persone non cambiano idea facilmente come i telefoni che si aggiornano, e questo porta a isolarsi. Le cose tecnologiche diventano vecchie in fretta, ma si fa fatica ad accettare che il corpo invecchia. Il lavoro è sempre presente, non c’è più differenza tra tempo libero e tempo di lavoro. La società cerca qualcuno da incolpare, e si urla invece di parlare. Non si dà più valore all’esperienza delle persone anziane, conta solo essere veloci ed efficienti. Si pensa solo al presente, senza preoccuparsi del futuro, e questo aumenta l’ansia. Si passa dalla paura dei posti chiusi alla paura degli spazi aperti dove non si ha controllo. Le vacanze servono solo a dimenticare i problemi per un po’. Le esperienze di gruppo, come il cinema fuori, sono diverse da come la tecnologia ci fa fare tutto da soli. La realtà di oggi non è come nei film di fantascienza, ma c’è una mancanza di umanità che porta a non rispettare chi è debole. La corruzione c’è ancora, il cambiamento non è vero. Il lavoro umano vale poco, come il prezzo di un caffè, mostrando lo sfruttamento. La tecnologia spinge a fare foto delle esperienze invece che viverle. Chi gestisce la cosa pubblica non pensa a settori come le carceri, che mostrano quanto una nazione è civile. Si cercano esperienze forti in un mondo che sembra freddo, e questo porta a farsi del male. La sicurezza nelle città non è vera, ci sono pericoli inaspettati. I social media mostrano una realtà finta, senza le cose brutte. La storia si ripete, con problemi vecchi che causano rivolte e modi di punire di tanto tempo fa. Scrivere sui social serve a farsi vedere e a cercare approvazione. Le notizie in TV e online non sono sempre complete o vere. I riti importanti della vita sono sostituiti da sfide pericolose per farsi notare sui social. Il territorio è fragile per colpa di chi non se ne cura e della corruzione. Il tempo è scandito da quando si compra qualcosa. Le idee importanti e i simboli diventano banali perché si diffondono troppo in fretta. Le feste di una volta perdono il loro significato. L’inizio dell’anno porta ansia per i problemi del mondo. Poi arriva un virus che nessuno conosce e fa vedere quanto siamo fragili, mettendo in crisi l’idea che la tecnologia ci protegga da tutto. L’idea di essere al sicuro grazie alla scienza si rivela sbagliata di fronte a un rischio biologico semplice. Sopravvivere diventa una cosa difficile e non scontata. La pandemia cambia come stiamo insieme. Dobbiamo stare lontani, e questo ci fa sentire soli e meno socievoli, usando di più i mezzi digitali per lavorare e stare con gli altri, con effetti sulla solitudine e sulla salute. La paura di tutti diventa ansia, anche perché il virus rende difficile respirare. I social media diventano importanti anche per la politica, saltando i modi normali di fare le cose. L’emergenza fa tornare lo Stato a controllare la vita privata, chiedendo di obbedire e mettendo in discussione la libertà di ognuno. La crisi mostra anche che i capi non sono preparati. L’economia e la società mostrano i loro problemi. La finanza si basa su cose non vere, mentre la pandemia fa vedere che non tutti hanno le stesse possibilità di curarsi e che c’è chi guadagna dalle tragedie. Le scoperte scientifiche vengono dette in fretta, creando confusione. La paura fa cercare qualcuno a cui dare la colpa per qualcosa che non si capisce. Tornano paure e idee del passato, mentre il futuro non si sa come sarà. Sopravvivere significa riscoprire le piccole cose di ogni giorno e capire che il tempo è prezioso. La crisi fa anche pensare di nuovo a cosa è importante, come l’arte e la bellezza, e fa chiedere se una civiltà può riprendersi quando nascono meno bambini. La pandemia del 2020 rompe l’idea di essere completamente al sicuro e di avere tutto sotto controllo grazie alla tecnologia. Non si pensa più che non ci siano rischi, ma c’è sempre incertezza. Questa crisi globale mostra che a volte si difendono gli animali più delle persone, come se si odiassero gli umani ma si amassero gli animali. La politica e come si comunica cambiano. L’importanza di farsi vedere e fare selfie sui social diminuisce perché si deve portare la mascherina. La politica deve mostrare di avere paura e di essere debole, invece di far vedere forza, rispecchiando come si sentono tutti. Il messaggio politico diventa come una cosa da vendere, e i candidati pensano di aver successo in base a quanti soldi raccolgono con gli eventi online. Il 2020 è l’anno dei limiti, perché non si è liberi di fare quello che si vuole e non si può pensare al futuro. Questo limite si vede anche nella scienza, per esempio con i premi Nobel per lo studio dei buchi neri, che sono i confini di quello che sappiamo. Ammalarsi di virus fa perdere sensi come il gusto e l’olfatto e rende difficile pensare bene, come avere una “nebbia nel cervello”. Ci si sente in colpa per essersi ammalati e si cerca chi ha trasmesso il virus. La malattia cambia l’idea di stare vicino agli altri, che diventa un pericolo, anche per chi si ama. La pandemia fa vedere anche problemi sociali ed economici, come lo sfruttamento dei lavoratori che viene giustificato dall’emergenza. Gestire l’emergenza con la burocrazia è difficile e fa arrabbiare, lasciando le persone ad aspettare e in difficoltà. Tornare normali dopo la malattia può far sentire in colpa per essere sopravvissuti, soprattutto pensando a chi è stato peggio. Anche nascere viene visto con la paura di morire, e i neonati vengono testati per il virus. Sopravvivere diventa più importante che vivere. Nonostante le difficoltà, ci sono segni di speranza e voglia di guardare avanti, come le luci di Natale messe prima e il vaccino dato a una persona che si chiama Shakespeare, che fa pensare a una ripresa per il mondo dello spettacolo che ha sofferto. Non rispettare le regole, come quelle per Natale, mostra che le persone non vogliono obbedire, anche quando le regole servono per la salute di tutti. La pandemia rende il mondo simile, perché tutti hanno la stessa paura e lo stesso problema, ma allo stesso tempo crea divisioni e competizione su chi ha più contagi o morti. Questa situazione mostra che la natura non si interessa di quello che succede agli umani, come terremoti o malattie, che succedono senza un motivo e senza provare niente, mettendo in dubbio che l’uomo possa controllare il pianeta. In questo momento, si cerca di essere diversi dagli altri, di non seguire la maggioranza, forse per come funzionano i social media. Vedere sempre i numeri dei morti fa abituare e annoiare, come un film che non finisce mai. La fiducia nei numeri e nei sistemi automatici, usati per gestire le cose difficili, si scontra con il fatto che sbagliano, come si vede dagli errori nei dati e dal fatto che non riescono a prevedere o fermare il virus. Aspettare una soluzione veloce, come i vaccini visti come una salvezza, delude per i ritardi, e la speranza diventa frustrazione. L’incertezza continua impedisce di fare piani, creando una situazione ferma dominata da pensieri negativi (“e se poi succede questo…”) e dalla paura di non capire i segnali di pericolo in futuro, come è successo all’inizio della pandemia. Il virus, con le sue versioni diverse, si comporta come un nemico che cambia per sopravvivere, in una lotta naturale con l’uomo. È pericoloso perché si diffonde senza farsi notare e molto velocemente, non perché uccide in modo spettacolare. La pandemia fa vedere anche quanto sono importanti la cultura e il lavoro, non solo per guadagnare ma perché danno un’identità e aiutano la società, un valore che spesso si dimentica. Il futuro non si sa come sarà, non c’è una strada chiara per uscire da questa situazione, e il dubbio di non farcela indebolisce lo spirito. Nonostante questo, l’amore e i rapporti tra le persone sono un modo per resistere alla paura e alla solitudine. La pandemia ha anche cambiato come percepiamo il tempo, non c’è più differenza tra tempo libero e tempo di lavoro, e si desidera solo riavere il proprio tempo. Tutta questa esperienza sembra un sogno che, al contrario, suggerisce che è importante aiutarsi e guardare oltre i limiti che ci sono.Riassunto Lungo
1. Il Presente Digitale e le sue Ombre
La vita di oggi è profondamente segnata dalla presenza di diverse forme di “scarto”, che vanno dalla spazzatura fisica ai contenuti mediatici di poco valore e ai sentimenti che si usano e si buttano via. Questa mentalità del “usa e getta” si riflette anche nelle relazioni tra persone, che diventano come oggetti da consumare. È facile iniziarle e finirle, proprio come si cancella un’amicizia online con un clic. Anche nel mondo della politica, si osserva un’assenza di schieramenti fissi. Le posizioni cambiano rapidamente, rendendo difficile mantenere una linea coerente e capire chi è “amico” e chi “nemico”.La Tecnologia Trasforma Emozioni e Relazioni
Le nostre interazioni con la tecnologia hanno l’effetto di trasformare emozioni e ricordi in semplici dati quantificabili. Questi dati vengono misurati attraverso “mi piace” e condivisioni sui social media. Questo processo porta a un forte concentrazione su noi stessi, quasi un trionfo dell’autoreferenzialità. L’esperienza degli altri finisce per servire solo come pretesto per definire chi siamo noi, e questo annulla la capacità di provare empatia. La costante necessità di password per accedere a ogni servizio digitale riflette, in un certo senso, la nostra difficoltà interiore nel trovare la “password” del nostro sentire più autentico.Difficoltà ad Accettare il Cambiamento e il Tempo
A differenza dei dispositivi tecnologici che si aggiornano facilmente, si nota una certa resistenza da parte degli esseri umani nel voler aggiornare le proprie idee. Questa chiusura mentale non aiuta e spesso porta all’isolamento sociale. C’è una grande differenza tra la vita breve degli oggetti tecnologici, fatti per diventare presto vecchi, e la nostra incapacità di accettare l’invecchiamento del corpo umano. Il mondo del lavoro di oggi, caratterizzato dal precariato e dalla connessione costante, finisce per invadere ogni momento della nostra vita. Questo cancella di fatto il confine tra il tempo dedicato al lavoro e quello che dovrebbe essere libero.La Ricerca di un Nemico e la Vita nel Presente
La società sembra aver bisogno di trovare un nemico per capire chi è. Questo crea un clima di scontro continuo, dove si urla invece di parlare. Non si dà più importanza all’esperienza e alla saggezza delle persone anziane, preferendo velocità ed efficienza. La politica tende a privilegiare l’azione immediata e istintiva rispetto alla riflessione. Si vive molto nel presente, senza pensare al futuro, neanche nella prevenzione medica, e questo aumenta l’ansia per quello che non possiamo prevedere.Nuove Paure e Esperienze Diverse
Le nostre paure cambiano natura: si passa dalla paura dei confini chiusi, la claustrofobia, alla paura degli spazi aperti e della mancanza di controllo, che è l’agorafobia. Spesso le pause estive vengono usate solo per mettere da parte i problemi per un breve periodo, senza affrontarli e risolverli davvero. Questo modo di agire mostra una tendenza a evitare il confronto diretto con le difficoltà. Ci sono ancora momenti di esperienze vissute insieme, come guardare un film all’aperto in compagnia. Tuttavia, queste esperienze collettive contrastano con la forte personalizzazione e l’individualismo che la tecnologia ci offre con contenuti “su richiesta”, fruibili da soli.La Deumanizzazione e la Realtà di Oggi
La realtà di oggi non è come le storie di fantascienza distopiche che immaginavano un futuro lontano. Piuttosto, mostra una perdita di umanità che porta a non dare importanza alle persone più deboli e vulnerabili. La corruzione continua a esistere, dimostrando che il “cambiamento” di cui si parla è spesso un’apparenza superficiale. Il valore del lavoro umano diminuisce drasticamente, arrivando a costare quanto un semplice caffè, un segno evidente di sfruttamento globale e locale. La tecnologia, inoltre, ci spinge a immortalare le esperienze con foto e video piuttosto che viverle pienamente nel momento presente.Aspetti Nascosti della Società e Ricerca di Emozioni Forti
Chi gestisce la cosa pubblica tende a ignorare settori che non sono visibili o popolari, come ad esempio le carceri. Eppure, proprio le carceri riflettono in modo chiaro il grado di civiltà di una nazione. In un mondo percepito come freddo e digitale, le persone cercano esperienze molto intense. Questa ricerca a volte porta a comportamenti autodistruttivi. L’illusione di sicurezza che si prova nella città moderna viene spesso smentita da pericoli inattesi che possono presentarsi. I social media, dal canto loro, filtrano la realtà che ci mostrano, rimuovendo contenuti che considerano “violenti” per presentare un’immagine più semplice e gradevole.Schemi che si Ripetono e Nuove Abitudini
Guardando la storia, vediamo che alcuni problemi tornano, come rivolte nate da bisogni semplici, e che si usano ancora metodi di controllo molto vecchi. Scrivere sui social network diventa un modo per parlare solo di sé e cercare l’approvazione degli altri attraverso i numeri. Le notizie che vediamo, in TV o online, sono spesso controllate e non complete. I vecchi modi per segnare il passaggio all’età adulta sono rimpiazzati da sfide rischiose fatte solo per farsi notare sui social. Il nostro territorio è più fragile a causa della mancanza di cura e della corruzione. Il ritmo della vita è sempre più deciso dal consumo. Idee importanti come “mito” e “culto” perdono il loro significato profondo quando si diffondono velocemente online. Le feste di una volta non hanno più la stessa magia e non rafforzano più i legami tra le persone. L’inizio di ogni nuovo anno porta ansia per le minacce globali e l’incertezza politica.Ma siamo sicuri che tutti questi mali siano colpa del “digitale”, o non stiamo forse solo guardando vecchi vizi umani con uno schermo nuovo?
Il capitolo, pur descrivendo efficacemente i fenomeni attuali, tende a concentrare la critica sulla dimensione digitale, trascurando forse le radici storiche e sociali più ampie di molti dei problemi descritti. La “mentalità usa e getta”, la ricerca dell’approvazione, la difficoltà nelle relazioni, non sono forse fenomeni che precedono l’era digitale e che questa tecnologia ha solo amplificato o reso più visibili? Per un’analisi più completa, sarebbe utile confrontare queste osservazioni con studi sulla storia sociale e sulla critica della modernità, leggendo autori come Zygmunt Bauman, che ha esplorato la liquidità dei legami sociali, o Christopher Lasch, che ha analizzato la cultura del narcisismo.2. La fragilità svelata
Un virus sconosciuto appare e mostra quanto sia fragile la condizione umana. Mette in crisi l’idea che la tecnologia possa renderci invincibili e protetti da tutto. La sensazione di essere al sicuro grazie al progresso scientifico si rivela un’illusione di fronte a un semplice rischio biologico. Il nostro stesso corpo si dimostra vulnerabile in modi inaspettati. La possibilità di sopravvivere diventa così una questione concreta, ma allo stesso tempo incerta e precaria per tutti.L’impatto sulla vita sociale
La pandemia cambia profondamente il modo in cui le persone interagiscono tra loro. La necessità di mantenere le distanze fisiche porta all’isolamento. Questo crea un senso di antisocialità diffusa. L’uso delle piattaforme digitali per lavorare e mantenere relazioni aumenta notevolmente, ma questo uso massiccio ha effetti negativi sulla solitudine e sulla salute mentale delle persone. La paura che si diffonde nella società si trasforma in ansia, spesso legata anche alla difficoltà di respirare, che è uno dei sintomi principali del virus.Le conseguenze politiche
In politica, i social media iniziano a essere usati direttamente dalle istituzioni, saltando i passaggi tradizionali della comunicazione. L’emergenza sanitaria costringe lo Stato a intervenire di nuovo nella vita privata dei cittadini. Viene richiesta una forte obbedienza civica per contenere il virus. Questo mette in discussione l’autonomia e la libertà individuale. La crisi evidenzia anche le debolezze e l’impreparazione di molti leader politici di fronte a una situazione inaspettata e grave.Economia e disuguaglianze
L’emergenza rivela le contraddizioni profonde dell’economia e della società. Si scopre che il mondo della finanza è spesso basato su sistemi poco solidi o addirittura falsi. La pandemia mette in luce le enormi disuguaglianze nell’accesso alle cure mediche tra le diverse fasce della popolazione. C’è anche una tendenza a cercare di guadagnare dalle tragedie. La ricerca scientifica, pur fondamentale, viene a volte comunicata in modo troppo rapido e poco chiaro, generando confusione e sfiducia tra le persone.La paura e la ricerca di senso
La paura diffusa porta a una sorta di regressione psicologica nella società. Molti cercano subito dei colpevoli per dare una spiegazione a ciò che non conoscono e che li spaventa. Si assiste a un ritorno di vecchie paure e temi del passato che sembravano superati. Il futuro appare incerto e difficile da prevedere in questo nuovo scenario. Questa situazione spinge le persone a cercare un appiglio.Riscoperta e riflessione sul futuro
La sopravvivenza quotidiana si lega alla riscoperta di piccoli gesti e riti che prima sembravano banali. Diventa chiara la consapevolezza del valore del tempo, che non è più scontato. La crisi spinge anche a riflettere su cosa sia veramente essenziale nella vita. Cose come l’arte e la bellezza vengono rivalutate per la loro capacità di nutrire lo spirito. Ci si interroga sulla capacità di una civiltà di rinnovarsi e superare le sfide, anche di fronte a problemi come il calo delle nascite.Se la paura diffusa porta a cercare colpevoli e a una “regressione psicologica”, non si rischia di liquidare come irrazionale ogni forma di dissenso o critica?
Il capitolo osserva che la paura diffusa porta a una ricerca di colpevoli e a una regressione psicologica. Tuttavia, questa interpretazione rischia di semplificare eccessivamente le reazioni sociali e individuali a una crisi. Non tutte le critiche o le espressioni di dissenso sono necessariamente frutto di paura irrazionale o regressione. Per comprendere meglio queste dinamiche, sarebbe utile approfondire la psicologia sociale e la sociologia delle crisi, esplorando autori come Gustave Le Bon (sulla psicologia delle folle, con le dovute cautele critiche) o studi più recenti sui movimenti sociali e la reazione pubblica alle emergenze.3. La sopravvivenza e il limite inatteso
La pandemia del 2020 dissolve l’illusione di sicurezza e controllo totale che la tecnologia sembrava garantire. L’idea del rischio zero scompare, sostituita da una costante incertezza che pervade ogni aspetto della vita. Questa crisi globale rivela una tendenza inattesa: difendere la fauna con più veemenza della solidarietà umana, mostrando una forma di misantropia zoofila. Contemporaneamente, la politica e la comunicazione cambiano profondamente. L’ossessione per l’immagine e i selfie sui social viene ridimensionata dall’obbligo della mascherina, che copre i volti e altera la percezione. La politica si trova costretta a mostrare vulnerabilità e paura, anziché la consueta forza e sicurezza, rispecchiando lo stato d’animo collettivo. Il messaggio politico assume la forma di una merce in vendita, con i candidati che misurano il successo in base ai fondi raccolti durante gli eventi mediatici, evidenziando un cambiamento nelle priorità e nelle modalità di interazione pubblica.La Scoperta dei Limiti Personali e Collettivi
Il 2020 diventa l’anno del limite, un concetto che si manifesta in modo tangibile nella restrizione delle libertà personali e nella ridotta capacità di progettare il futuro. Questa limitazione si riflette anche nel mondo della scienza, come dimostrano i premi Nobel per lo studio dei buchi neri, che rappresentano i confini estremi della conoscenza umana e l’impossibilità di superarli. L’esperienza diretta del virus porta alla perdita di sensi fondamentali come gusto e olfatto e a difficoltà cognitive, definite “nebbia cognitiva”, che limitano le capacità mentali. Si manifesta un senso di colpa per il contagio e una ricerca ossessiva dell'”untore”, trasformando le relazioni interpersonali. La malattia cambia la percezione della vicinanza, che da fonte di conforto diventa una potenziale minaccia per gli altri, anche per i propri cari, imponendo un limite fisico ed emotivo alle interazioni.Le Conseguenze Sociali e Psicologiche
La pandemia evidenzia anche problemi sociali ed economici preesistenti, portandoli in primo piano. Si assiste allo sfruttamento di lavoratori, giustificato dall’emergenza, che mostra le fragilità del sistema economico. La gestione burocratica dell’emergenza si dimostra inefficiente e frustrante, lasciando le persone in attesa e in difficoltà di fronte a procedure complesse. Il ritorno alla normalità dopo la malattia può generare un senso di colpa per essere sopravvissuti, specialmente confrontando la propria esperienza con quella più grave di altri. La nascita stessa viene vista attraverso la lente del rischio di morte, con i neonati sottoposti a test per il virus fin dai primi istanti di vita. In questo contesto, la sopravvivenza prende il posto della vita come obiettivo principale, spostando l’attenzione dalla qualità dell’esistenza alla sua mera continuazione.Segnali di Speranza e Resistenza
Nonostante le immense difficoltà affrontate, emergono segnali di speranza e la volontà di guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Questo desiderio di rinascita è simboleggiato da gesti come l’anticipazione delle luci natalizie, un segno di speranza in un periodo buio. L’arrivo del vaccino, che raggiunge una persona di nome Shakespeare, evoca una possibile ripresa per il mondo dello spettacolo e della cultura, duramente colpiti dalla crisi. Tuttavia, la tendenza a eludere le regole e le restrizioni, come nel caso delle misure natalizie, mostra una persistente resistenza all’autorità. Questa resistenza si manifesta anche quando le misure sono necessarie per la salute pubblica, evidenziando una tensione continua tra libertà individuale e bene collettivo.[/membership]Come si può affermare una diffusa “misantropia zoofila” senza fornire prove concrete o contesto per un’affermazione così forte?
Il capitolo introduce il concetto di “misantropia zoofila” per descrivere un presunto comportamento emerso durante la pandemia, ma non offre dati o esempi specifici che dimostrino che la difesa della fauna sia stata effettivamente prioritaria rispetto alla solidarietà umana su larga scala. Per valutare la fondatezza di tale affermazione, sarebbe utile approfondire studi di sociologia del comportamento collettivo in situazioni di crisi, analisi dei media e della comunicazione pubblica durante la pandemia, e ricerche sull’interazione tra preoccupazioni ambientali e sociali. Autori come Zygmunt Bauman o Edgar Morin potrebbero offrire spunti sulla complessità delle risposte sociali in contesti di incertezza globale.4. La lotta per sopravvivere e il tempo sospeso
La pandemia ha reso il mondo stranamente simile, con tutti che affrontano la stessa paura e lo stesso problema. Eppure, allo stesso tempo, ha spinto le persone verso localismi e divisioni, creando una competizione basata sui numeri dei contagi e dei morti. Questa situazione ha mostrato quanto la natura sia indifferente agli eventi umani, come terremoti o epidemie, che accadono senza un motivo apparente o empatia. Questo mette in discussione l’idea che l’uomo possa davvero controllare il pianeta. In questo contesto, è emersa una tendenza a cercare l’identità nella controtendenza, nel distinguersi dalla maggioranza, forse anche a causa della logica dei social media.Assuefazione e fiducia tradita
La presenza costante dei dati sulla morte nei bollettini quotidiani ha portato a una sorta di assuefazione, quasi una noia, come guardare un film che non finisce mai. Quella fiducia che avevamo nei numeri e negli algoritmi, su cui avevamo basato la gestione di situazioni complesse, si è scontrata duramente con la loro fallibilità, con errori evidenti nei dati e l’incapacità di prevedere o controllare davvero il contagio. L’attesa di una soluzione rapida, come i vaccini visti inizialmente quasi come un intervento salvifico, è stata delusa dai ritardi. Questo ha trasformato la speranza iniziale in profonda frustrazione. Questa incertezza costante ha impedito di fare progetti, creando una stasi dominata da ipotesi negative, quelle che iniziano con ‘se poi…’. C’è anche la paura di non riuscire a riconoscere per tempo i segnali di pericolo futuri, proprio come è accaduto all’inizio della pandemia.Il virus e il valore del lavoro
Il virus, con le sue continue varianti, si comporta quasi come un avversario che si adatta costantemente per sopravvivere. È una forma di competizione naturale con l’uomo, dove la posta in gioco è la diffusione. La sua vera pericolosità non sta tanto in una letalità spettacolare, che colpisce in modo visibile, ma nella sua capacità di diffondersi in modo silenzioso ed esponenziale, rendendo difficile il contenimento. La pandemia ha anche evidenziato il valore economico della cultura e del lavoro. Non sono solo un mezzo per guadagnare, ma una fonte fondamentale di identità e un contributo essenziale alla società, un valore che troppo spesso viene dimenticato.Futuro incerto e resistenza umana
Il futuro appare incerto, senza una chiara via d’uscita visibile. Il dubbio sulla possibilità di superare davvero questa situazione indebolisce lo spirito collettivo. Nonostante tutto questo, l’amore e le relazioni umane emergono come forme potenti di resistenza contro la paura e l’isolamento imposti dalla situazione. La pandemia ha anche alterato profondamente la percezione del tempo, annullando di fatto la distinzione tra tempo libero e tempo di lavoro. Ha mostrato un desiderio profondo e diffuso di riavere semplicemente il proprio tempo. L’intera esperienza, con i suoi capovolgimenti, suggerisce l’importanza della solidarietà e dell’andare oltre i limiti che ci vengono imposti.Se la “fiducia nei numeri e negli algoritmi” è stata “tradita” dalla loro “fallibilità”, come sostiene il capitolo, non dovremmo forse interrogarci sulla nostra stessa pretesa di poter “controllare” la realtà con la sola quantificazione, piuttosto che sulla presunta oggettività dei dati?
Il capitolo solleva un punto cruciale sulla crisi di fiducia nei confronti dei dati e dei modelli predittivi. Tuttavia, la critica alla “fallibilità” dei numeri rischia di semplificare eccessivamente una questione complessa. Non si tratta solo di errori nei dati o nei modelli, ma della nostra stessa comprensione dei limiti della scienza nel prevedere e controllare sistemi caotici come una pandemia. Per approfondire questa crisi di fiducia e la natura della conoscenza scientifica di fronte all’incertezza, sarebbe utile esplorare la filosofia della scienza e la teoria della complessità. Autori come Karl Popper o Nassim Nicholas Taleb offrono prospettive critiche sui limiti della conoscenza e sulla fragilità dei modelli predittivi.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]