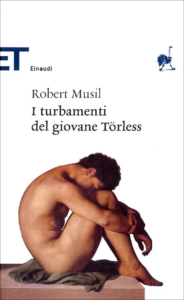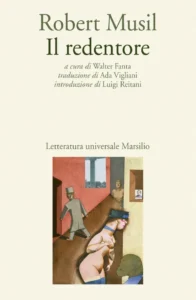1. La Città e l’Individuo Senza Qualità
Vienna, agosto 1913. La città è un intreccio di suoni e movimenti, un caos che rispecchia la vita della capitale. Un camion investe un uomo, attirando l’attenzione dei passanti. Una coppia, poco distante, osserva la scena, più interessata a discutere le cause dell’incidente che a prestare soccorso. L’evento diventa un pretesto per riflettere sulla distanza tra la loro realtà e il mondo esterno. Poco lontano, in una palazzina storica nascosta in un giardino, vive Ulrich, un uomo che osserva il traffico dalla finestra. Cerca di dare un senso all’assurdità della vita moderna, calcolando mentalmente lo sforzo necessario per affrontare la quotidianità. Pensa all’eroismo, confrontando la fatica di ogni giorno con l’atto eroico singolo, arrivando a considerare più significativa la prima. Il padre di Ulrich, un professore di successo, incarna il “senso della realtà”. Disapprova la scelta del figlio di vivere in quella palazzina, considerandola un’inutile ostentazione. Ulrich, invece, è l’opposto: vive nel “senso della possibilità”, dove l’immaginazione e il potenziale superano la realtà. Fin da giovane, Ulrich mostra un pensiero originale, come quando a scuola scrive un tema sul patriottismo che diventa una riflessione sulla natura di Dio. Dopo varie esperienze, torna in patria e si ritrova a ristrutturare la sua casa. L’indecisione lo porta a perdersi in un mare di possibilità, incapace di scegliere uno stile preciso. Alla fine, si affida al caso e alle convenzioni, ritrovandosi in una dimora elegante ma impersonale, che riflette la sua vita ancora indefinita.2. Amori, Risse e Ambizioni in Tempo di Kakania
Fin da giovane, Ulrich desidera diventare un uomo importante. Inizialmente, ammira figure come Napoleone e intraprende la carriera militare. La rigida disciplina e la mancanza di eroismo autentico, però, lo deludono. Abbandona quindi la vita militare e si dedica alla tecnica e all’ingegneria, attratto dalla modernità del mondo industriale. Anche in questo ambito, tuttavia, scopre una realtà diversa dalle sue aspettative, popolata da figure più pragmatiche e meno inclini a visioni grandiose. Nella sua ricerca di realizzazione personale, Ulrich rivolge la sua attenzione anche alla sfera sentimentale. Conosce Leona, una cantante di cabaret, e ne rimane affascinato. La ribattezza Leona e inizia una relazione con lei. Leona, però, desidera una vita di lusso e cene in ristoranti eleganti, un’aspirazione che Ulrich non soddisfa pienamente. Una notte, Ulrich viene aggredito e malmenato da sconosciuti. Questo episodio di violenza lo porta a riflettere sull’ostilità latente nella società. Viene soccorso da Bonadea, con la quale inizia una nuova relazione. Durante il tragitto in carrozza verso casa, Ulrich paragona lo sport e la lotta a esperienze mistiche, in cui il corpo agisce guidato da un istinto primordiale. L’Impero austro-ungarico, Kakania, fa da sfondo a queste vicende. Kakania è uno stato ricco di contraddizioni, con un ritmo di vita più lento rispetto alla modernità incalzante. Ogni aspetto della vita pubblica e privata è caratterizzato da ambiguità e formalismi. Questa nazione, pur essendo a suo modo progredita, sembra accettare passivamente le proprie incoerenze, mostrando una diffusa sfiducia nel progresso e nel cambiamento.37. L’Ambivalenza dei Sentimenti e le Illusioni dell’Amore
Il sentimento ha una natura duplice: uno sviluppo esteriore, che porta all’azione, e uno interiore, più vago. Il sentimento determinato si manifesta in azioni concrete verso obiettivi definiti, mentre quello indeterminato influenza la percezione del mondo in modo diffuso, senza uno scopo preciso. La cultura europea valorizza il mondo interiore, ma sempre in funzione di un’azione esterna. Ulrich e Agathe, isolandosi dal mondo nella città anonima, riflettono sull’ambivalenza della vita: ogni progresso sembra accompagnato da un regresso, e ogni nobile aspirazione si scontra con la banalità. La mediocrità, paradossalmente, potrebbe essere una forza stabilizzatrice nella storia umana. Il corso degli eventi appare simile al caso, suggerendo che la realtà potrebbe essere priva di un ordine spirituale, governata piuttosto dalla probabilità. L’amore per il prossimo è un sentimento universale. Il comandamento di amare il prossimo “come se stessi” è ambiguo, dato che la reale conoscenza di sé e degli altri è incerta. L’amore è illusorio: si ama forse un’immagine idealizzata, più che la persona reale. Le interpretazioni tradizionali dell’amore, sia religiose che psicologiche, appaiono insoddisfacenti. L’esperienza amorosa potrebbe derivare da un’espansione temporanea dei bisogni sociali a discapito di quelli egoistici. Esiste una “partecipazione mistica” alla realtà, distinta da una partecipazione concreta, che delinea due modi di vivere l’esperienza. L’amore è strettamente legato alla parola: l’essere umano è l’unico animale che usa il linguaggio anche nella sfera amorosa. Il dialogo è centrale nell’amore, forse più dell’azione. Ulrich e Agathe parlano incessantemente d’amore, quasi per comprenderlo senza viverlo pienamente. L’amore tra persone di sesso diverso è l’esempio perfetto dell’amore per l’ignoto. In amore, si crea un’immagine idealizzata dell’altro, spesso indipendente dalle sue reali qualità. Le opere d’amore sono ambigue e non provano l’autenticità del sentimento. L’amore non si basa sul merito o sulla conoscenza razionale, ma su un’illusione necessaria, piena di contraddizioni e insicurezze.38. Il Disagio di Amare
L’amore è un’esperienza complessa, con tante sfaccettature diverse che è difficile definirlo in modo unico. Ci si chiede cosa significhi amare, sia gli altri che sé stessi, e quale sia la vera essenza di questo sentimento. Una domanda che può sembrare banale, ma che rivela tutta la sua complessità se si pensa alla grande varietà di relazioni che chiamiamo “amore”, molte delle quali, in realtà, non hanno un vero nucleo d’amore.La parola “amore” comprende significati molto diversi: l’amore per gli oggetti, le idee, i vizi, le virtù, le persone e persino Dio. Questa varietà fa nascere una domanda: cosa hanno in comune queste forme d’amore così diverse? Si può fare un paragone con la parola “forchetta”, che indica sia le forchette da tavola che i forconi, ma che mantiene in comune la forma. Allo stesso modo, si cerca un’esperienza fondamentale, comune a tutte le forme d’amore, anche se l’amore non è un oggetto che si può toccare, ma un evento che riguarda la nostra interiorità, come la giustizia o il disprezzo.Si potrebbe pensare che la libido e l’eros siano il nucleo dell’amore, ma è più utile osservare esempi concreti di amore per capirne la natura. Il sentimento, che sembra così importante nell’amore, potrebbe in realtà essere l’aspetto meno significativo. I sentimenti d’amore, come tutti gli altri sentimenti, non sono originali e sono difficili da descrivere con precisione. L’amore per un amico è diverso da quello per un partner, e sentimenti come la venerazione o il desiderio sono diversi fin dall’inizio. Anche se siamo sicuri di quello che proviamo, la natura del sentimento rimane incerta, influenzata da cause psicologiche e sociali. Ogni sentimento ha un nucleo iniziale che cresce e cambia nel tempo, rendendo difficile definirlo in modo chiaro.L’intensità del sentimento, quando è al massimo, diventa incerta e confusa, perde chiarezza. L’oggetto dell’amore, invece, è molto importante nel determinare la qualità del sentimento. Oggetti diversi possono rendere l’amore ricco o povero, sano o malato. Le relazioni in cui l’amore non è corrisposto, o è rivolto a oggetti di poco valore, possono far degenerare il sentimento. Un’analogia è quella con la natura morta nei quadri, che rivela un aspetto misterioso della vita, suscitando un’emozione indefinita. La natura morta evoca un senso di silenzio, simile a un volto di un defunto, e si collega a temi come la necrofilia e l’incapacità di vivere pienamente.Durante un dialogo in giardino, sotto il sole estivo, Agathe, osservando dei petali che cadono, ricorda esperienze mistiche e il concetto di Regno Millenario, un regno d’amore e di Dio sulla terra. Cerca di raggiungere uno stato di pace interiore, ma non ci riesce. Ripensa alle emozioni violente del passato, ormai svanite. Ulrich distingue due modi di vivere la passione: uno “appetitivo”, con emozioni intense che svaniscono subito, e uno “non-appetitivo”, più profondo, simile a un sogno. Questi due modi corrispondono a due tipi di sentimento: “mondano”, inquieto e insoddisfatto, e “mistico”, costante ma lontano dalla realtà. Ulrich paragona queste due tendenze all’animale e alla pianta, e vede nell’istinto “appetitivo” la causa delle azioni e delle preoccupazioni del mondo. Esistono due tipi di persone: quelle “appetitive”, attive e passionali, e quelle “contemplative”, timide e introverse. Questa differenza riflette un modo diverso di vivere l’esperienza umana. Entrambi si sentono “uomini senza qualità”, in bilico tra il nulla e l’azione.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]