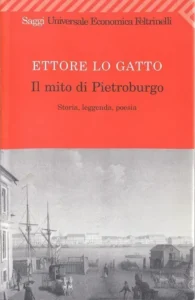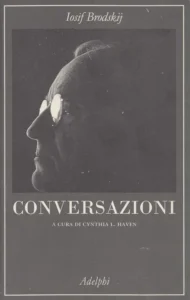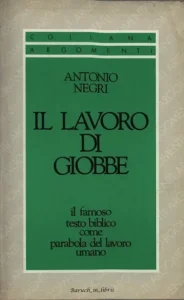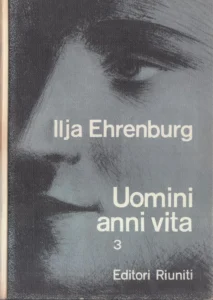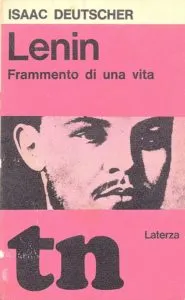Contenuti del libro
Informazioni
“L’intellighenza sovietica tra la critica e il dogma” di Ladri Biblioteche ti porta dentro il mondo intellettuale dell’Unione Sovietica in un periodo super interessante, quello tra gli anni ’60 e ’70. Non è solo la storia del regime, ma di chi ci viveva dentro e provava a pensare, a capire, a volte a criticare. Il libro esplora come l’ideologia sovietica, che sembrava monolitica, in realtà si scontrasse con un sacco di problemi interni ed esterni. C’è la stagnazione ideologica ufficiale, il dogma marxista-leninista che non sa più spiegare la realtà, ma dall’altra parte c’è l’intellighenzia sovietica – scienziati, filosofi, sociologi – che cerca risposte nuove, magari guardando alla rivoluzione scientifico-tecnica o persino al pensiero occidentale. Vediamo le tensioni tra il Partito che vuole controllare tutto e chi, come i sociologi che usano metodi empirici o i filosofi che cercano un confronto internazionale, spinge per un pensiero più libero. E poi ci sono le voci di dissenso URSS, quelle che criticano apertamente il sistema, come Sakharov o Amal’rik, usando canali come il Samizdat. È un viaggio affascinante dentro le crepe di un sistema che si sente minacciato, dove la critica interna URSS diventa un segnale di malessere profondo. Il libro ti fa capire quanto fosse complessa la vita intellettuale lì dentro, stretta tra la fedeltà al dogma e la voglia di capire il mondo per davvero.Riassunto Breve
L’ideologia ufficiale in Unione Sovietica affronta sfide interne ed esterne, mostrando rigidità e difficoltà ad adattarsi. Esiste un conflitto con la Cina riguardo la via al comunismo e persistono elementi capitalistici nell’economia cinese. All’interno, si discute sulla definizione del socialismo come tappa distinta dal capitalismo, ma non perfetta, e c’è incertezza sulla sua completa realizzazione. Si nota una distanza tra le affermazioni ideologiche e la realtà, con problemi che richiedono adattamenti teorici. La filosofia ufficiale appare rigida, ma emergono ricerche specialistiche e interesse per idee non ortodosse, anche occidentali. Critiche esterne e domande delle nuove generazioni stimolano dibattiti, riconoscendo l’esigenza di un pensiero più dinamico. L’idea di un’ideologia monolitica è superata da processi di differenziazione e ricerca intellettuale, anche non ufficiale. Il pensiero dominante è dogmatico, visto come difesa basata sulla debolezza. La politica estera mostra interessi di grande potenza, mentre quella interna esige obbedienza. Ci sono spinte intellettuali autonome e risvegli nazionali. Emerge un’auto-interpretazione più empirica, basata sui fatti, con un linguaggio tecnico da scienza e cibernetica che tende a dissolvere le vecchie idee ideologiche. La prospettiva del comunismo imminente si allontana, concetti economici come denaro e profitto vengono rivalutati. L’ideologia ufficiale promuove efficienza e patriottismo, riconoscendo l’interesse materiale. L’idea marxista di liberazione diventa critica interna. La filosofia rischia l’irrilevanza, limitata dal controllo politico. Emergono approcci post-ideologici nella “direzione scientifica della società”, basati su analisi empiriche per affrontare problemi concreti, visti come minaccia dallo status quo. Le tensioni tra stati del blocco derivano da nazionalismi e interessi economici, non solo ideologici. L’ideologia tradizionale perde credibilità, usata per gestire conflitti di potere. Il socialismo è ridefinito come formazione autonoma e duratura, giustificando lo stato attuale e spostando l’attenzione sulla “società socialista sviluppata”. La rivoluzione scientifico-tecnica è cruciale ma crea attriti, con il partito che cerca controllo sull’intellighenzia scientifica. La coesistenza pacifica è vista come lotta ideologica, portando a irrigidimento e “konfrontacija”. Diverse posizioni riflettono le difficoltà del partito nel conciliare controllo e esigenze di una società in evoluzione. Emergono contestazioni ideologiche e filosofiche. Una rivista cerca rinnovamento e apertura, sfidando l’ortodossia. Figure autorevoli criticano la stagnazione della filosofia ufficiale e la sua incapacità di dialogare con il pensiero internazionale. La vecchia guardia difende il marxismo-leninismo contro la “deideologizzazione”. Dibattiti su materialismo storico, sociologia empirica e strutturalismo mettono in discussione concetti fondamentali. Il regime interpreta contestazioni e influenze esterne come attacchi “anticomunisti”, cercando unità, ma rivelando difficoltà nell’adattarsi. La lotta contro il pensiero divergente diventa stimolo per l’ideologia stagnante. Critiche provengono da diverse prospettive, inclusa una sinistra radicale che vede una “convergenza negativa” con il capitalismo. Figure come Wl. Bienkowski descrivono un “comunismo pietrificato”. Andrei D. Sacharov propone una critica “costruttiva”, chiedendo libertà intellettuale, cooperazione e democratizzazione radicale per superare la “malattia della menzogna reciproca totale” e le tradizioni staliniste. Sostiene che l’economia moderna richiede partecipazione e informazione libera. Andrei A. Amal’rik ha una visione più estrema e pessimistica sulla sopravvivenza del regime, subendo repressione. Le sue critiche, diffuse clandestinamente, lo rendono noto internazionalmente. Le tensioni si intensificano dopo il 1968. La sociologia affronta difficoltà, vista con sospetto dagli ideologi. Il caso di Jurij A. Levada illustra queste tensioni, proponendo un approccio empirico basato su concetti occidentali, criticato dagli ortodossi. Altri esempi di pensiero critico emergono, anche se repressi. Forme di dissenso clandestine come il Samizdat e il “Diario politico” rivelano malessere diffuso. Le tensioni interne e il pensiero critico non sono marginali, riflettono erosione e stagnazione nel sistema e mettono in discussione l’immagine ufficiale. La critica interna contribuisce a una maggiore consapevolezza dei problemi e dei pericoli comuni, come la corsa agli armamenti che porta a una “convergenza negativa”.Riassunto Lungo
1. Il Pensiero Sovietico: Stagnazione e Fermento
La teoria sovietica affronta momenti difficili intorno al cinquantesimo anniversario della rivoluzione d’Ottobre. C’è un contrasto forte con la Cina. La visione di Mao viene criticata perché cerca di saltare le tappe verso il comunismo e usa la violenza. Si notano anche elementi che sembrano capitalistici nell’economia cinese.
Definizione di Socialismo
All’interno dell’Unione Sovietica, ci si interroga su come definire le diverse fasi che portano al comunismo. Si cerca di stabilire che il socialismo sia una tappa precisa, considerata la prima parte del comunismo. È diversa dal capitalismo, ma non è ancora perfetta. Mantiene infatti alcuni aspetti, come la produzione di beni destinati alla vendita e la sensazione di estraneazione dal proprio lavoro. Non c’è chiarezza su quando il socialismo potrà dirsi completamente realizzato.
Teoria e Realtà
C’è una differenza evidente tra quello che dice l’ideologia ufficiale e la situazione reale. Nonostante gli sforzi per mostrare un quadro positivo, emergono difficoltà concrete. Questo fa capire che la teoria deve essere adattata alla realtà dei fatti.
Fermento Intellettuale
La filosofia ufficiale in Unione Sovietica può sembrare rigida, ma mostra anche segnali di cambiamento. Cresce l’interesse per ricerche specifiche, per i problemi pratici e per idee che non sono considerate strettamente ortodosse. Ci si guarda anche verso pensieri occidentali o che risalgono a prima della rivoluzione. Le critiche che arrivano dall’esterno e le domande poste dalle nuove generazioni stimolano discussioni interne. Si capisce che serve un modo di pensare più vivo e capace di affrontare quanto è complesso il mondo e le domande che riguardano le persone. L’idea che l’ideologia sovietica sia un blocco unico non regge più, perché ci sono differenze e ricerche intellettuali in corso, anche se spesso non in modo aperto e ufficiale.
Se il socialismo sovietico ammetteva di mantenere aspetti ‘capitalistici’ come la produzione di merci e l’alienazione, su quali basi logiche si pretendeva che fosse una tappa diversa dal capitalismo e non semplicemente una sua variante statalista?
Il capitolo evidenzia la difficoltà della teoria sovietica nel definire chiaramente il socialismo, ammettendo che mantenesse aspetti come la produzione di merci e l’alienazione. Questa ambiguità solleva un dubbio fondamentale sulla distinzione logica tra socialismo e capitalismo di stato, e sulla coerenza interna della teoria stessa. Per esplorare questa lacuna argomentativa, sarebbe utile approfondire la teoria economica marxista originale, le specifiche interpretazioni leniniste e staliniste sul socialismo, e le analisi critiche successive dei sistemi economici pianificati. Discipline come l’economia politica, la filosofia politica e la storia economica sono essenziali per comprendere le basi teoriche e le contraddizioni pratiche di tale definizione.2. Il Pensiero Sovietico: Tra Dogma e Pragmatismo Tecnico
Il pensiero ufficiale in Unione Sovietica appare rigido e legato ai dogmi, visto fuori dal paese come un modo per difendere una posizione di debolezza. La politica verso l’esterno usa un linguaggio rivoluzionario, ma in realtà nasconde gli interessi di una grande potenza. All’interno del paese, si chiede ai cittadini di essere obbedienti, usando l’idea di virtù civica e patriottismo per mantenere il potere esistente. Nonostante questa rigidità, l’ideologia ufficiale cerca di adattarsi, promuovendo valori come l’efficienza nel lavoro e un forte senso patriottico. Anche l’interesse personale per il benessere materiale viene riconosciuto come qualcosa che può spingere le persone ad agire. Questa situazione è molto diversa dagli sforzi che si vedono in altri paesi dell’Est, dove si cerca di rinnovare il sistema e renderlo più democratico.Nuove idee e linguaggi
Nonostante il controllo ufficiale, emergono spinte intellettuali autonome. Artisti, scienziati e giovani mostrano un pensiero indipendente, e si assiste a risvegli nazionali. Un cambiamento importante è l’inizio di un modo di interpretare la realtà che parte dai fatti concreti, non solo dalle idee prefissate. Questo porta all’uso di un linguaggio più tecnico e specifico, che viene dalla scienza e dalla cibernetica. Questo nuovo linguaggio descrive le cose in modo diverso dal vecchio modo di parlare del partito. Anche se a volte difficile da capire, questo nuovo linguaggio tende a indebolire le vecchie idee ideologiche, rendendole meno comprensibili dal punto di vista politico.L’economia e il cambiamento dei valori
Accanto a questi cambiamenti, si nota che l’idea di raggiungere presto il comunismo come obiettivo finale si allontana nel tempo. Concetti legati all’economia, come il denaro e il profitto, che prima erano visti in modo negativo, vengono ora considerati in modo più positivo. Questo riflette un tentativo di rendere il sistema più efficiente e produttivo. L’ideologia ufficiale si modifica per includere e promuovere valori come l’efficienza nel lavoro e un forte senso di patriottismo. L’interesse personale per il guadagno materiale viene riconosciuto come una forza che può motivare le persone. Anche l’idea originale, centrale nel pensiero di Marx, di liberare l’uomo, pur restando presente nelle parole ufficiali, finisce per essere usata come uno strumento per criticare ciò che non funziona all’interno del sistema stesso.La filosofia e il suo ruolo
In questo quadro, la filosofia in Unione Sovietica mostra una maggiore preparazione e si confronta con le idee che arrivano dal mondo occidentale, superando in parte l’isolamento. Nonostante questi progressi, rischia di non avere un vero peso nella società e nella politica, apparendo più come un elemento decorativo che come una forza capace di stimolare il cambiamento. Questa situazione è legata alla costante tensione tra la necessità di approfondire gli studi e il forte controllo politico. Chi si specializza in un campo trova il dialogo limitato, perché la politica frena la libera ricerca e l’espressione delle idee.Approcci pragmatici per la società
In questo contesto, iniziano a farsi strada approcci che vanno oltre le vecchie ideologie. Un esempio importante è quello che viene chiamato “direzione scientifica della società”. Questo modo di pensare si basa sull’analisi attenta dei fatti concreti e guarda molto al futuro, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. Si occupa di risolvere problemi pratici legati all’organizzazione e alla gestione della società. Questi approcci non partono dai dogmi ideologici, ma dalla realtà, e per questo potrebbero trovare punti in comune con tendenze simili che esistono nei paesi occidentali. Tuttavia, vengono anche visti con preoccupazione, perché rappresentano una possibile minaccia per chi detiene il potere e per le idee radicate nella società.Se il pensiero ufficiale era così “rigido e legato ai dogmi”, come si spiega la sua capacità di assorbire concetti “borghesi” come efficienza e profitto, svuotando di fatto il nucleo rivoluzionario?
Il capitolo descrive l’integrazione di valori pragmatici ed economici nel pensiero sovietico, ma non approfondisce la tensione logica e ideologica che tale processo deve aver generato. Come si giustificava internamente questo allontanamento dai principi marxisti classici? Era una reale evoluzione ideologica, un compromesso pragmatico dettato dalla necessità economica, o un sintomo di svuotamento del dogma? Per esplorare queste dinamiche, è utile approfondire la storia dell’ideologia sovietica post-staliniana, studiando la politologia, la storia intellettuale e l’economia pianificata. Autori che hanno analizzato le contraddizioni interne del sistema sovietico, come Stephen Kotkin o Archie Brown, possono offrire spunti preziosi.3. Ideologia e Scienza: Tensioni nel Blocco Sovietico
Le tensioni tra i paesi del blocco comunista non nascevano tanto da idee politiche diverse, quanto piuttosto da forti sentimenti nazionali e da interessi economici che non coincidevano. La competizione tra Mosca e Pechino, insieme alle situazioni interne in nazioni come la Cecoslovacchia e la Romania, dimostrava chiaramente che gli interessi di ogni singolo paese erano più importanti dell’idea di unità socialista internazionale. L’ideologia, quella tradizionale, perdeva la sua forza come motore principale e diventava invece uno strumento per nascondere o gestire le lotte per il potere e le questioni di sicurezza tra gli stati.Il nuovo significato del socialismo
L’idea stessa di socialismo cambiò nel tempo. Non era più vista solo come un breve passaggio verso il comunismo, ma diventava una forma di società stabile e duratura per conto suo. Questo nuovo modo di vedere le cose serviva a giustificare la situazione presente e a concentrare gli sforzi sulla costruzione di una “società socialista sviluppata”, un obiettivo a lungo termine che definiva il percorso di questi paesi.Scienza e controllo: uno scontro
Il progresso scientifico e tecnologico (la cosiddetta rivoluzione scientifico-tecnica) divenne molto importante per lo sviluppo dei paesi e per competere a livello mondiale. Tuttavia, questo progresso creò anche problemi interni. Il partito al potere cercava di mantenere il controllo sulle idee degli scienziati e degli intellettuali, che erano visti con sospetto perché chiedevano di poter avere più informazioni, maggiore libertà di pensiero e più contatti con l’estero. Le critiche rivolte a come la scienza era gestita nei paesi occidentali venivano usate, in modo indiretto, per parlare dei problemi simili che esistevano all’interno del sistema sovietico.La “pace” come lotta ideologica
La convivenza pacifica con i paesi occidentali non era vista semplicemente come un periodo di pace. Veniva interpretata come una forma di lotta tra classi sociali e un campo di battaglia dove si scontravano idee diverse. Si pensava che l’Occidente cercasse di influenzare e indebolire i paesi socialisti attraverso politiche che miravano ad “avvicinarli” al loro sistema. Questa visione portava a un irrigidimento delle posizioni ideologiche e a uno stato di “confronto” continuo.Le diverse anime del sistema
All’interno del sistema sovietico esistevano posizioni diverse. Alcuni seguivano rigidamente le vecchie idee (dogmatismo), altri provavano ad adattarsi alla realtà che cambiava, e altri ancora spingevano verso un modo di pensare più basato sulla scienza e meno sull’ideologia. Queste differenze mostravano quanto fosse difficile per il partito al potere riuscire a conciliare il controllo politico con le necessità di una società in evoluzione e con le sfide che arrivavano dal resto del mondo.Ma davvero i problemi del sistema sovietico erano solo un’eredità di Stalin?
Il capitolo attribuisce molte delle difficoltà del sistema sovietico, come la mancanza di libertà di pensiero e la repressione, all’eredità autoritaria dell’era stalinista. Tuttavia, la dinamica del sistema negli anni ’60 e ’70 era complessa e influenzata da fattori economici, sociali e politici specifici del periodo post-staliniano, non solo dal passato. Per comprendere meglio queste dinamiche, è utile approfondire la storia dell’Unione Sovietica nel periodo post-staliniano, in particolare l’era Brezneviana. Discipline come la sovietologia e la storia politica comparata possono offrire strumenti analitici. Autori come Stephen Kotkin, Archie Brown, o Robert Conquest possono fornire contesti più ampi sulle cause della stagnazione e della repressione in quel periodo storico.6. Tensioni Ideologiche e Pensiero Critico nel Blocco Sovietico
Dopo gli eventi del 1968 in Cecoslovacchia, la lotta ideologica all’interno del blocco sovietico si fa più intensa. Questa pressione serve a contrastare le tendenze interne che vengono viste come “opportunismo di destra”, considerate simili al social-democratismo. Questa situazione è percepita come molto pericolosa. Le grandi conferenze internazionali che si tengono nel 1970 mostrano chiaramente le tensioni esistenti tra la necessità di mantenere la fedeltà alla linea ufficiale e le differenze che emergono all’interno del sistema.Le difficoltà della sociologia
La sociologia in Unione Sovietica incontra notevoli difficoltà. Dopo la fine dell’era staliniana, c’è un tentativo di reintrodurla, ma la sua natura di analisi basata sui fatti concreti è vista con sospetto dagli ideologi. Temono infatti che la ricerca empirica possa portare a una perdita di importanza dell’ideologia. I dibattiti sul rapporto tra la sociologia e il materialismo storico riflettono bene questa lotta tra il pensiero ideologico e quello scientifico, e tra i gruppi più conservatori e quelli che spingono per riforme.Il caso di Jurij A. Levada
Il caso di Jurij A. Levada è un esempio significativo di queste tensioni. Nelle sue lezioni di sociologia, Levada propone una teoria sociale che utilizza concetti provenienti dal pensiero occidentale, come le teorie dei sistemi, per analizzare la società nel suo complesso e le sue diverse funzioni. Per lui, la sociologia è una disciplina che si basa sull’osservazione e sui dati concreti, distinta dalle leggi generali che governano lo sviluppo sociale secondo il materialismo storico. Questo suo approccio, che include la distinzione tra società tradizionali e società industriali (mettendo sullo stesso piano capitalismo e socialismo come forme di società industriale) e che dà importanza all’individuo, viene duramente criticato dai sostenitori della linea ortodossa. Essi considerano le sue idee una violazione dei principi fondamentali del marxismo-leninismo. Nonostante le critiche, Levada difende le sue posizioni, sottolineando quanto sia necessaria una ricerca sociale che sia efficace e capace di comprendere la realtà.Altre forme di pensiero critico e dissenso
Accanto ai dibattiti in ambiti più o meno ufficiali, emergono altri esempi di pensiero critico. Ci sono discussioni sulla storia del partito e riflessioni sulla presenza della coercizione nel socialismo. Queste controversie, anche se spesso vengono messe a tacere, sono un segnale chiaro dei conflitti interni al sistema. Esistono anche forme di dissenso che operano in segreto, come il Samizdat, pubblicazioni clandestine diffuse a mano, e il “Diario politico”. Queste pubblicazioni, insieme alle voci di intellettuali che esprimono critiche aperte, come Andrei Sakharov, rivelano un malessere diffuso nella società e una ricerca attiva di alternative al sistema esistente.Il significato delle tensioni interne
Le tensioni interne e il pensiero critico non sono fenomeni isolati o di poca importanza. Essi indicano una situazione di progressiva debolezza e di blocco all’interno del sistema e mettono in discussione l’immagine di unità e forza che viene mostrata ufficialmente. La critica che nasce dall’interno, anche se spesso limitata nella sua diffusione, contribuisce ad aumentare la consapevolezza dei problemi del sistema e dei pericoli che riguardano tutti, come la corsa agli armamenti. Questa consapevolezza porta a una sorta di “convergenza negativa” tra i paesi dell’Est e quelli dell’Ovest, basata sulla condivisione delle preoccupazioni per il futuro.Se l’ideologia dominante temeva così tanto l’analisi empirica della sociologia, non è forse perché sapeva di non reggere il confronto con la realtà?
Il capitolo descrive con efficacia la tensione tra l’ideologia ufficiale e l’emergere di un pensiero critico basato sull’osservazione dei fatti, come nel caso della sociologia. La paura manifestata dagli ideologi nei confronti della ricerca empirica, vista come una minaccia alla preminenza dell’ideologia, solleva un interrogativo fondamentale sulla solidità stessa di quel sistema di pensiero. Un’ideologia che si sottrae al confronto con i dati concreti rivela una debolezza strutturale, un timore che la realtà possa smentire i suoi postulati. Per comprendere meglio questa dinamica, sarebbe utile approfondire la storia della sociologia in Unione Sovietica e nei paesi del blocco orientale, studiare il rapporto complesso tra scienza e potere nei regimi autoritari e leggere autori che hanno analizzato la funzione dell’ideologia e della propaganda nel mantenimento del consenso in tali contesti.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]